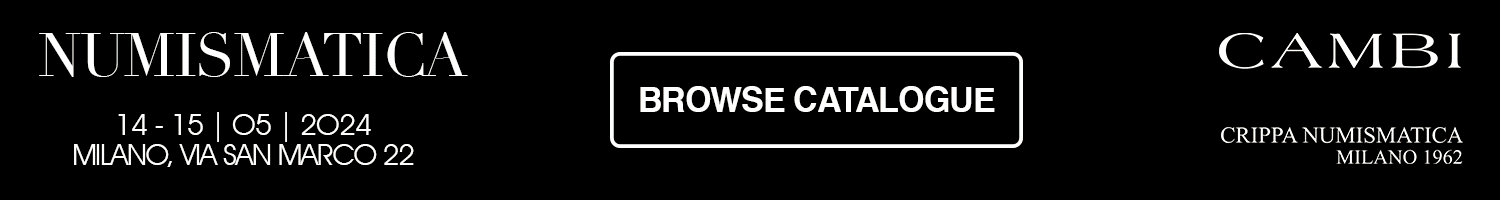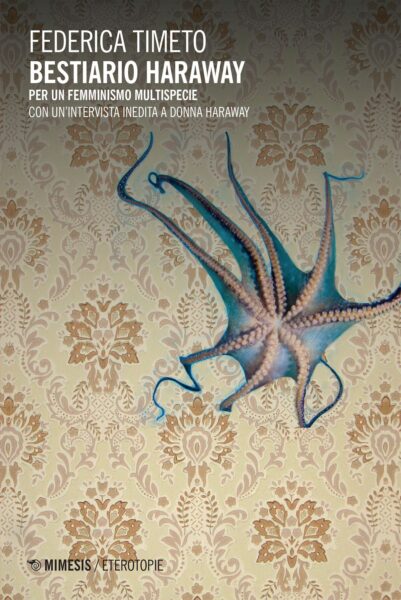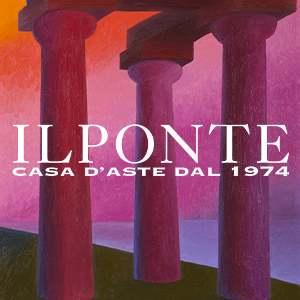È in libreria Bestiario Haraway. Per un femminismo multispecie. Intervista all’autrice, Federica Timeto: “anche ciò che è utile non sempre è lecito”
Federica Timeto insegna all’Università Cà Foscari di Venezia Sociologia dei processi culturali e comunicativi. Si occupa da anni di studi coloniali, cultura visuale e femminismo.
Fa parte del Centro di Studi Postcoloniali e di Genere dell’Università di Napoli L’Orientale, della redazione della rivista Studi Culturali e della rivista antispecista Liberazioni.
Il suo ultimo lavoro dal titolo “Bestiario Haraway. Per un femminismo multispecie” (Mimesis, 2020) accompagna il pubblico italiano nell’analisi della teoria delle specie compagne e degli agenti non-umani di Donna Haraway – femminista statunitense in auge sin dagli anni ’80 per la sua riflessione radicale sull’antropocentrismo e il ruolo della tecnica nella vita e nel pensiero.
Una conversazione con Federica Timeto è parsa piuttosto irresistibile. La possibilità sempre più reale di essere costrett* a un’esistenza alternativa dovuta all’attuale pandemia in corso rende il dialogo sul Bestiario impellente. Il saggio contiene, inoltre, un’intervista dell’autrice a Donna Haraway risalente al gennaio 2020 in cui traspaiono contraddizioni e punti salienti del rapporto politico con la categoria ‘specie’.
D. Sin dalle note introduttive del Bestiario Haraway sottolinei come il concetto di rappresentazione abbia storicamente consegnato un’immagine degli animali non-umani, particolarmente netta e specchiata. Come se gli animali fossero completamente trasparenti alla nostra lettura, ovvi, meccanici. Riprendendo Haraway, hai parlato di loro come esseri torbidi, densi, vittime innanzitutto di lesioni retiniche del pensiero occidentale. Vorrei che tu spiegassi, a questo proposito, se e come la tutela della vita altrui in un mondo di relazioni impari possa evitare questo tipo di sguardo.
R. L’idea che gli animali e in generale gli altri viventi non umani siano trasparenti deriva da una rappresentazione che postula un osservatore e un osservato come separati: il primo guarda ciò che si trova di fronte e attraverso lo sguardo presuppone ciò che osserva, ma al contempo anche lo produce, come passivo. Chi guarda si pone fuori “dal quadro”, per così dire, recidendo i propri legami, dunque la relazione, con ciò che vede, ma allo stesso tempo prestando la propria voce all’altro muto che la rappresentazione “immortala” (l’espressione inglese still life, riferito al genere della natura morta, rende molto bene l’idea del blocco della vita della rappresentazione tradizionale). Questa trasparenza è quella che permette anche di mantenere separati il sapere e il potere, e servirsi del primo per ottenere il secondo dissimulando questa operazione dietro la ricerca – e l’apparenza – della verità (delle scienze sociali come di quelle naturali). Da qui la critica alla visione illuminata-illuminante-illuminista che Haraway avanza, riarticolando le pratiche di rappresentazione in una direzione più opaca e viscosa. In Primate Visions Haraway dice che gli animali sono “densi”, non trasparenti, in Chthulucene parla di una teoria che viene dal fango, impastata di terra, aggrovigliata (entangled), cioè una teoria in cui osservatore e osservato siano posti finalmente sul medesimo piano di immanenza, nello stesso quadro, e non si dia una scappatoia esterna privilegiata, che è poi quella della visione specista che procede per tassonomie e gerarchie al fine di definire e soprattutto definirsi. Non userei la parola tutela, tuttavia, quanto la parola rispetto. La tutela infatti immagina una specie da salvare, senza mettere in questione chi salva cosa, e quali altre siano le agentività in gioco, se non l’umana; ri-spettare invece, in termini harawaiani, significa fare compiere una torsione allo sguardo nella revisione della categoria di specie, e portarlo a rivedere innanzitutto i meccanismi che rendono possibile lo specismo e le sue pratiche.
D. Dall’intervista a Donna Haraway si legge: “[…] il punto è che non possiamo agire innocentemente. Penso sia giusto dare peso alla vita che si sente-pensa, senza elevare il pensiero sopra il sentire né viceversa, quello che definisco la danza del pensare-sentire, che poi si traduce in giudizio. Non esiste decisione che non implichi una qualche forma di violenza”. Mi sembra che qui si sia esplicitato in maniera rilevante il divario tra la tua prospettiva sulla soggettività degli animali non-umani e la postura di Haraway su ciò che tu hai paradossalmente definito ‘carne felice’. C’è per te un punto di non ritorno in questo atteggiamento? In altri termini, si può sempre parlare in termini di responsabilità, scelta, il nostro rapporto con gli animali e le ecologie? L’impotenza degli animali umani di fronte a questa pandemia rende evidente che sia quanto meno discutibile il nostro ruolo sul Pianeta (senza-di-noi), non nel mondo (per-noi) per dirla con le parole di Thacker riprese nella postfazione di Massimo Filippi.
R. Ti ringrazio per la domanda perché per me questo è un punto fondamentale per comprendere sia Haraway sia la mia posizione nei suoi confronti. Partiamo da Haraway: in un passaggio molto discusso di When Species Meet, Haraway s’interroga sulla differenza fra uccidere e rendere sterminabile, e consapevole della mai assoluta innocenza (questo è un concetto cardine di tutto il suo pensiero) nello stare al mondo e nel fare mondo (in linea con posizioni come quelle del veganesimo etico contestuale in ambito ecofemminista, paradossalmente), afferma che non esistono ragioni sufficienti per rendere qualche altra vita sterminabile, ma ci possono talvolta essere ragioni contingenti per uccidere: uno dei motivi per cui, per esempio, non si dichiara mai contraria all’impiego di animali per la sperimentazione di laboratorio, di cui problematizza tuttavia le pratiche all’estremo; su queste stesse basi Haraway stessa si rende conto, soprattutto negli scritti più recenti, di quanto invece vacilli, e molto, il sistema-allevamento, pur non arrivando a compiere ancora una scelta vegana o anche solo vegetariana. Haraway, che proviene dal femminismo socialista dal quale poi in parte si discosta, ma di cui pure condivide la riflessione sul lavoro, non condanna le relazioni strumentali in cui la vita animale è di fatto annientata e propone di considerare gli animali come “partner significativamente non liberi” (cioè significanti sì, ma vincolati) rispetto alle relazioni che gli umani instaurano con loro. Haraway insomma non condanna incondizionatamente le relazioni strumentali, ma solo quelle in cui ai non umani non è lasciata possibilità di entrare in relazione con gli umani su basi comuni. C’è da chiedersi, a questo punto, come si concili questa simmetria ontologica fra viventi umani e non umani che il suo pensiero propone, e consente fruttuosamente di adottare attraverso il concetto di specie compagne, con le pratiche istituzionalizzate di sfruttamento e messa a morte animale, che per esempio il doloroso resoconto della creazione di oncotopi al centro di Testimone Modesta spiega molto bene. Ovvero, quale animale non umano sceglierebbe liberamente di servire agli umani per sperimentare un nuovo farmaco o per riempire gli scaffali dei supermercati di pezzi del proprio corpo in pratiche vaschette monoporzione? È vero che condividere “troppi luoghi di lavoro” ci unisce in un abbraccio familiare con le specie compagne, ed è altrettanto vero che dubitare delle ragioni della messa a morte animale e dichiararsene responsabili è un primo importante passo, ma da femminista antispecista ritengo che si debba andare oltre questo, e sostenere che anche ciò che è utile (in base a ragioni contingenti) non sempre è lecito.
La vita animale oggi è annientata prima ancora di poter essere considerata o lasciata libera di diventare significativa e significante, anzi nella maggior parte dei casi è prodotta proprio a tale scopo, il che rende scivoloso l’appello a una simmetria ontologica che è regolarmente sconfessata dal complesso animal-industriale odierno, che sulle asimmetrie dell’ideologia specista invece poggia. Da questo punto di vista, far dialogare il pensiero di Haraway con le riflessioni di Zipporah Weisberg sulle biotecnologie, Jason Hribal sul lavoro animale, Erika Cudworth sui limiti del welfarismo degli Animal Studies può essere certamente fruttuoso.
D. Il Bestiario Haraway è un ricettacolo di studi critici sulla primatologia, le scienze ‘naturali’, anche sugli Animal Studies. Ho avuto l’impressione che tu mirassi a scompaginare le certezze più solide di chi guarda alla biologia o alla zoosemiotica attraverso i paradigmi della ‘somiglianza’ e della ‘differenza’ dall’umano. Il percorso storico che delinei a questo proposito sui primati è illuminante. Potresti chiarire meglio cosa intende Haraway con l’espressione ‘la primatologia occidentale è l’orientalismo delle scimmie’? Inoltre: nella storia di King Kong il gorilla doveva, secondo Haraway, simbolicamente essere battuto da una forza ‘tecnica, astratta’. Cioè, ‘dagli strumenti della guerra moderna’. L’astrazione in questo senso è sempre una forza mortifera oppure può contribuire a decostruire somiglianze e differenze forse improponibili?
R. Attraverso la primatologia, in laboratorio e sul campo, sono state giustificate molte delle teorie che tra la fine della prima guerra mondiale e il periodo della guerra fredda hanno costruito il corpo sociale in opposizione al corpo naturale: i primati sono diventati uno dei luoghi privilegiati per osservare quel “traffico di significati” dai quali l’Umano, bianco maschio e occidentale, si è progressivamente sfilato per poter confermare ancora una volta il proprio eccezionalismo. Possiamo dunque parlare di un complesso di scienze biosociali per le quali i corpi dei primati e il corpo della natura (spesso in relazione metonimica) sono stati impiegati come specchi per restituire agli umani una immagine di ciò che erano, ciò da cui si sarebbero in seguito distaccati, ciò cui comunque restavano profondamente legati nell’eventualità di una catastrofe o di una fuga, che sarebbe potuta avvenire all’indietro, in un ritorno al primitivo, o in avanti, verso l’esplorazione dello spazio – si vedano a tal proposito le vicende degli astroscimpanzé, di cui racconto in dettaglio nel Bestiario. Il progetto colonialista (e orientalista) implicato più o meno direttamente dai discorsi sui primati produce il corpo animale e quello animalizzato (per esempio dei nativi e delle donne) come inferiori e passivi, dunque sfruttabili: pensiamo a operazioni come Pastoria, a Kindia, nella Guinea Francese, base dell’Istituto Pasteur per studiare la medicina tropicale, dove furono attuati una serie di esperimenti di “civilizzazione” sui primati, oppure alle spedizioni del noto tassidermista e naturalista Carl Akeley, che non avrebbero potuto aver luogo senza un sistematico sfruttamento della popolazione locale, oltre che dei suoi trofei di caccia. Quanto alla morte di King Kong, beh è certamente emblematico questo confronto fra verticalità e terrestrità, e il fatto che la morte arrivi dall’alto e che uno degli aerei che circondano il gorilla nella scena finale del film originale è pilotato dai produttori e registi Cooper e Schoedsack, il primo dei quali, anticomunista convinto, era stato anche membro dell’aviazione americana… La tecnologia che cala dall’alto è tecnocratica e violenta tanto più quando si accompagna a una visione da “occhio di dio”, direbbe Haraway (pensiamo all’impiego odierno dei droni in ambito militare su cui James Bridle ha fatto un ottimo lavoro nel campo dell’arte), e non è certamente la tecnologia cui Haraway fa appello quando parla di connessioni cyborg. Purtroppo, quest’ultima è una figurazione che è stata molto appiattita dalle divulgazioni del mainstream, che hanno privilegiato un immaginario che definirei antitetico rispetto al cyborg harawaiano, che è piuttosto vicino alle salamandre ferite che alle divinità onnipotenti.
D. Nella tua critica alle nozioni di ‘specie invasiva’ e ‘specie compagna’ vedo tutta la portata femminista di critica alla scienza e un diverso significato di ‘modestia’ nelle pratiche tecnoscientifiche. Nella citazione di Weisberg a pag. 102 si legge a proposito dell’animale cavia da laboratorio: “[…] Nel suo corpo, sa che il suo corpo è la base della sua stessa alienazione e auto-negazione. Sa che proprio il suo corpo è l’impossibilità di quella libertà della quale è stato derubato”. Volevo sapere a questo riguardo quale idea ti sei fatta sull’esistenza di un istinto di vita o di morte negli animali, se questo sia ‘cultura senza cultura’ o ‘natura senza natura’.
R. Quanto afferma Weisberg non riguarda tanto l’instinto di vita/morte quanto, in linea con molt* pensator* contemporane*, che il terreno di battaglia della politica odierna è il corpo. Ma Weisberg va oltre la visione mainstream, specificando che il biopotere è più che mai evidente sui corpi degli degli “animali da reddito” in cui la cattura del corpo coincide con l’esclusione del loro sé. Detto questo, non so se gli animali abbiano istinti di vita/morte. Come non lo so per gli umani. Questo concetto dualistico è una “scoperta” della psicoanalisi freudiana che, pur avendo inferto un colpo brutale al narcisismo umano, resta comunque una disciplina ancora troppo umana. Ovviamente, da un punto di vista darwiniano è difficile pensare che qualcosa che può rispondere al concetto di istinto di vita/morte nell’uomo non possa essere presente in almeno alcune altre specie. Non saprei neppure dire se tutto questo si possa chiamare cultura senza cultura o natura senza natura. So che la comprensione di tutto questo eccede e rientra in un continuum naturalculturale in cui l’umano è implicato ma rispetto al quale non sempre ha il privilegio delle definizioni.
D. Haraway parla di una rigenerazione, contro le forzate nascite o le forzate morti, di imparare a morire e uccidere responsabilmente. Volevo soffermarmi ancora sulla questione della sparizione, non esistenza, estinzione, morte. In “After Life” (2014) Patricia MacCormack afferma che l’amore non cesserà con l’assenza umana, così come non è svanito con l’avvento del pensiero post-soggettivista. La domanda etica dell’a-umanesimo si sposta, dunque, dal “What am I?” al “Why am I?” (p. 187). Siamo composti di questo ‘perchè’, secondo te?
R. Sì, le idee dell’estinzione e dell’Antropocene sono ancora affrontate in modo profondamente antropocentrico e “soluzionista”: una evidenza è la gestione emergenziale della pandemia attuale. L’idea della società-compost che Haraway delinea in modo particolare in Chthulucene immagina invece una co-evoluzione di oloenti, a partire dai microrganismi, che vivono da sempre in una condizione simpioietica, di emergenza intesa come movimento della vita che emerge, questa volta in un senso completamente diverso dal precedente, dunque, che condividono l’evoluzione e il divenire (H. parla infatti di divenire-con, aggiungendo un “attaccamento” alla filosofia di un divenire senza “prensioni”). I simbionti coltivano alleanze in azione, sono, potremmo dire, una versione operativa del modello cyborg, che è stato criticato per rimanere soltanto una figurazione. I simbionti condividono la vita e la morte, nel senso che si fanno carico, si prendono cura e si nutrono vicendevolmente (oppure il contrario), sono respons-abili di quel contagio continuo che li caratterizza, ovvero, devono essere capaci di rispondere a chi fa parte della loro storia da sempre. Questa distribuzione a-gerarchica delle responsabilità non avviene ovviamente in un vuoto, è anch’essa situata: farsi carico del vivere e del morire dell’altro, piuttosto che del proprio, è un compito che l’umano soprattutto dovrebbe prendere in seria considerazione in questa fase, per essere capace di rispondere delle conseguenze delle proprie azioni, piuttosto che sentirsi invaso o minacciato da chi/cosa arriva, e procedere nella direzione di un ulteriore arroccamento. Ecco, l’Antropocene è invece troppo spesso un discorso che parte dall’umano per piangere la morte dell’umano oppure immaginare alternative solo per l’umano, ancora una volta perdendo l’occasione di stare, potremmo dire parafrasando Haraway, in quel trouble di cui è sempre stato composto e dal quale ha sempre voluto svincolarsi. Stare nel trouble significa invece accorgersi che l’Io si compone-decompone di continuo in una infinità di connessioni parziali, che non c’è un fuori assoluto in cui fuggire o al contrario in cui relegare l’altro da sé. In Manifesto cyborg, Haraway scrive: “la lotta politica consiste nel guardare da entrambe le prospettive a un tempo, poiché ognuna ci mostra sia il dominio sia le inimmaginabili possibilità dell’altra posizione”. Per far risuonare questa affermazione attraverso MacCormack, potremmo dire, con quest’ultima, che la fine del privilegio dell’umano (l’a-umano) si dà quando le capacità di creazione (anche nefasta) si accompagnano a pari capacità di ricezione.
D. Per concludere, seppure i riferimenti all’interno del saggio alle traiettorie di genere e specie siano innumerevoli e tutti affascinanti, parliamo di farfalle. Nel tuo ultimo capitolo c’è una delle più belle illustrazioni di Silvia Giambrone che traccia una fila di farfalle con addome di catene. Il peso delle catene è incommensurabile con la misura estetica delle farfalle. A partire dall’immagine di Haraway delle cinque Camille nell’arco temporale 2025-2425, particolarmente interessante è il passaggio sul passato che deve ancora essere raggiunto. Il tempo torna, per te, Donna Haraway, Karen Barad. In una lezione tenuta nel 2018 presso il Barnard Center for Research on Women, Barad sottolinea il tempo come sempre un condensato di passato-presente-futuro in un qui. Il ‘non c’è più tempo’ come slogan per la nuova ondata di movimenti ambientalisti globali, ahimè, suona in ritardo. Suona per alcun*. Non c’è già più tempo per molt* altr*. Con quale orario sincronizzarsi, allora?
R. Il tempo dello Chuthulucene non è un tempo progressivo né regressivo, e non può essere umanamente (cioè a partire dall’Umano) misurato, previsto o frenato: segue le traiettorie a loop dei polpi, si compone di interferenze e compossibilità, di salti e discontinuità. È un tempo involutivo e trasversale, un turn continuo e pieghettato, dove si può procedere soltanto ri-guardando ciò che è rimasto indietro/dentro. Un tempo quindi avvitato e mostruoso, perché ciò che deve arrivare è sempre già qui, anche se noi ci ostiniamo ad aspettarne l’arrivo (ad aspettare i barbari…). Un tempo da cui non si fugge né ci si salva, ma che certamente non può essere soltanto presente. Per riprendere la suggestione di Barad e del suo approccio da femminista e fisica alla realtà, i fenomeni (a fini di un femminismo multispecie possiamo anche dire i viventi) vivono in spaziotempomaterializzazioni [spacetimematterings] che, come nelle correlazioni quantistiche, evidenziano un’inseparabilità (ontologica) delle “componenti” che intra-agiscono localmente: se ci si arrende alla impossibilità di totalizzare questo tempo, allora probabilmente si può fare spazio alle relazioni come ciò che materializza l’esistenza. Fuori di metafora, immaginare un tempo simile significa poter pensare che anche le anime dei morti non umani restano, così come le farfalle monarca estinte continuano a vivere nei corpi di Camille, la fabula speculativa che chiude Chthulucene, che ne custodiscono la memoria e anche il futuro: i simbionti come Camille 4 si fanno araldi dei morti perché hanno il compito di sciogliere le catene della Doppia Morte: i morti che non hanno più discendenti patiscono infatti una duplice morte. Gli araldi di questi morti devono assumersi una doppia responsabilità, sia verso il passato sia verso il futuro, quasi rivoltando la prospettiva storica e facendo del passato qualcosa che non è ancora ma può ancora essere.