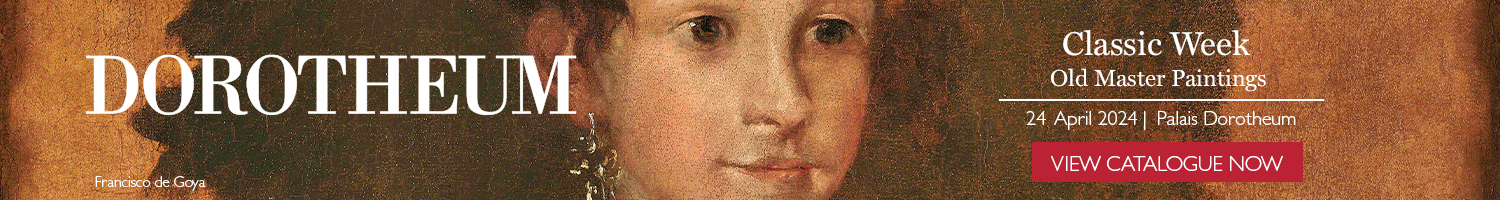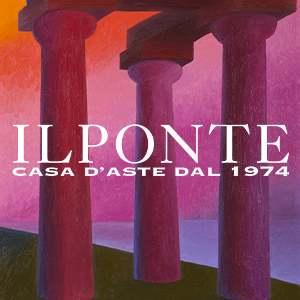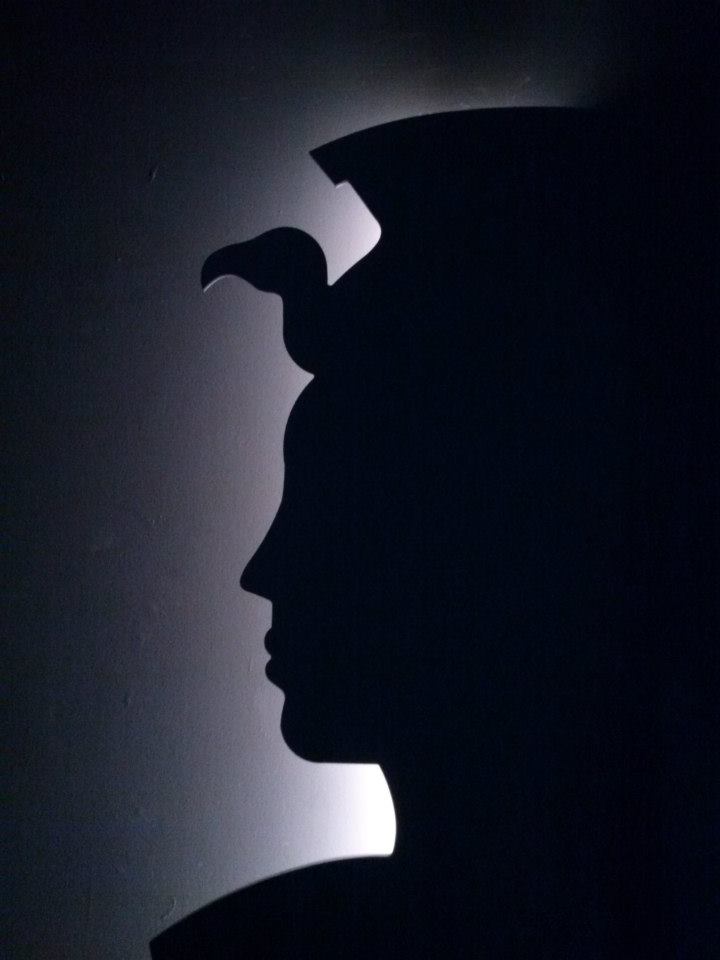Il catechismo sostiene che per ottenere la vita eterna occorra lasciare quella terrena. Dopo la morte, i beati smettono l’abito di carne per indossare un radioso corpo di gloria. Invisibile da quaggiù, ma proprio per questo definitivo e inalienabile. Una legge non troppo diversa regola anche uno dei rapporti più sorprendenti (e velenosi) del triangolo arte-storia-potere.
Nessuna pellicola ha saputo fissare il tramonto del comunismo europeo meglio di “Good Bye, Lenin!”. Uscita da un lungo stato di coma, la protagonista viene tenuta all’oscuro del fatto che la sua Repubblica democratica tedesca si è sciolta al sole della perestrojka. Ma quando meno se l’aspetta, ecco incombere sopra di lei la statua colossale del padre del bolscevismo. Lenin volteggia appeso a un elicottero, ed è un’epifania lirica e potente, che imprime alla pellicola, di genere brillante, un senso tutto nuovo. Il gigante dorato, nella sua posa icastica, volteggia fra le nuvole più solenne e profetico che mai. Non sembra affatto che l’elicottero lo voglia rimuovere dall’agorà della memoria collettiva. Al contrario: ascende al cielo. Come Romolo, come un eroe che gli dei tolgano dal mondo solo per premiarlo con l’immortalità.

È questo il contrappasso di ogni damnatio memoriae, perché quanto è accaduto a Lenin era successo prima a Mussolini, dopo sarebbe toccato a Saddam Hussein. Potremmo andare su, su almeno fino al faraone Akhenaton, del quale i discendenti rimossero accuratamente le effigi e i cartigli perfino nelle parti più inaccessibili dei templi, con il risultato che oggi ricordiamo il suo nome assai meglio dei loro. Perché ogni volta che buttiamo giù il re dal piedistallo evochiamo un fantasma che per decenni, forse per sempre si aggirerà intorno ai simboli del suo antico potere, e lo farà con una forza che il bronzo non avrebbe avuto. L’obliterazione dei simboli è una pratica talmente pericolosa che sembra imparentarsi alla negromanzia: suscita demoni. Demoni spiegabilissimi.
Chi si affretta a rimuovere i simboli del suo passato dimostra di temerne il potere. Non c’è bisogno di scomodare Edipo e Freud per riconoscere il parricida dietro i martelli instancabili che scalpellavano via aquile, duci e fasci dopo il 25 luglio ’43. Un’attività che avrebbe tenuto occupati gli italiani per un altro quinquennio almeno, tanto erano numerosi i marchi con cui il fascismo aveva voluto firmare tutte le sue realizzazioni. E anche questi erano, intendiamoci, i segni di un’intima debolezza: la superfetazione simbolica sventagliata dal regime suppliva alla fragilità di una macchina scenica tanto proterva quanto effimera.
L’alternativa alla damnatio memoriae c’è, ma richiede tanto coraggio. Conservare il ritratto del tiranno è come accoglierlo nella storia di famiglia, ammettendo la responsabilità di quanti lo hanno spalleggiato e adulato, o anche soltanto sopportato troppo a lungo per sentirsi davvero a posto con la coscienza.
Un altro celebre filmato ha per protagonista una statua bronzea, e stavolta non si tratta di fiction. Dieci anni fa, proprio mentre le sale cinematografiche proiettavano “Good Bye, Lenin!”, qualcuno riprendeva soldati americani nell’atto di abbattere l’effige di Saddam Hussein in piazza Firdaus, a Bagdad. Il materiale, la statura, la posa erano proprio le stesse di quel Lenin. Ma là dove il regista Wolfgang Becker aveva messo un elicottero a far le veci lievi dell’angelo, ecco la forza bruta del carro armato. Invece di elevare la statua al cielo dell’immortalità, uno strappo furioso la condannava alla polvere. Fin qui siamo ancora nel regno dei simboli. La differenza essenziale sta nel fatto che Saddam venne abbattuto da nemici venuti dall’altra parte del mondo, e la damnatio memoriae imposta dallo straniero non è mai veramente tale. Le mancano le stimmate del parricidio.

Ora, potremmo provare a immaginare un’Italia dove i segni del fascismo non fossero stati scialbati con tanto zelo? Il rapporto con le nostre radici sarebbe più sereno se ancora diecimila Mussolini occhieggiassero dai tribunali, dalle stazioni, dalle scuole, dalle università, dagli uffici postali e amministrativi? Difficile rispondere. La vicenda recente del “Bigio” di Brescia offre, però, alcune indicazioni interessanti.
Viene così chiamata un’imponente statua (sette metri e mezzo) realizzata da Arturo Dazzi nel 1932. Marmo di Carrara, che nella mistica dell’epoca rappresenta un po’ la versione “mediterranea” del bronzo, qui scolpito per giganteggiare nella piacentiniana piazza della Vittoria. Non un Mussolini, non un milite eroico o un’icona di regime, ma un giovinetto ispirato più al David michelangiolesco (quello, sì, era un simbolo politico) che allo sterminato catalogo della statuaria del ventennio. Certo l’esaltazione di un’adolescenza virile sposa bene gli ideali d’epoca, ma rappresenta anche il prezzo più basso da pagare all’inevitabile retorica, insieme al titolo: “Era fascista”.

Il Bigio comincia male. La sua nudità integrale diventa subito oggetto di polemica, specie da parte cattolica, e a pochi mesi dalla posa i genitali vengono occultati da una foglia di vite in alluminio. Il tempo passa veloce e si succedono l’impero, la guerra, la caduta di Mussolini, la Repubblica sociale. Dopo l’arrivo degli Anglo-americani qualcuno pone per due volte una carica esplosiva sotto la statua, che perde una gamba, un braccio e la foglia pudica. Anche il Bigio diventa mutilato di guerra, un reduce storpio che è meglio togliere di mezzo. “Dove è andato a finire?” si chiede otto anni dopo Mario Moretti sulla rivista “Terra Nostra”. “Sappiamo di certo che questa statua, non disprezzabile opera del Dazzi, pagata con soldi della città, non rappresenta nulla di politico. Rappresentava un bel pezzo di giovanotto, un atleta. Nel marasma del dopoguerra a qualcuno è venuto la voglia di fracassarlo e ci è riuscito in parte. Dalla piazza lo han tolto per ragioni di viabilità, si dice. Se è vero che le ragioni sono queste non si capisce perché non lo han messo su in castello o a porta Venezia. Ora questo marmo apuano giace nei magazzini del Comune con le numerose fontane tolte da vie e piazze. L’edera e la gramigna lo ricopriranno. I secoli passeranno sulle vecchie e sulle giovani pietre. E tra duemila anni le scopriranno i posteri e le ficcheranno in qualche museo”. Di anni ne passano molti meno, ma il destino del Bigio rimane incerto. Nel 1970 il sindaco socialista Bruno Fedrigolli sembra disposto a recuperare l’opera, poi ritira l’idea. Nel 1984 si pensa di venderla all’asta e un paese vicino si propone di ospitarla nella sua piazzetta, ma niente da fare. Finché pochi mesi fa, a seguito dei lavori per la metropolitana e della volontà di risistemare la piazza secondo il disegno di Piacentini, si delibera di rimettere tutto al suo posto. Compreso il Bigio, compresa la fontana che lo circondava, anch’essa sparita nel dopoguerra (ha ragione Moretti: la forsennata rimozione delle fontane di epoca fascista rappresenta un fenomeno misterioso, che non può essere spiegato soltanto con la necessità di fare spazio alle automobili). È una levata di scudi generale. L’opposizione, spalleggiata dall’Associazione nazionale partigiani d’Italia, bolla la delibera come “un atto offensivo, prepotente e grave, che ferisce la memoria collettiva con il ripristino di simboli fascisti”. Ci si mobilita, si fa volantinaggio, si raccolgono firme, le strofe di “Bella ciao” interrompono le sedute d’infuocati consigli comunali. Il Bigio non deve risorgere.
Tutto questo a Brescia, che in verità trabocca di architettura mussoliniana, e del genere più massiccio e inequivocabile. Per fare un esempio, a pochi metri dal piedistallo del Bigio, sotto la Torre della Rivoluzione, si erge un arengario in pietra rossa di Tolmezzo che più retorico non si può. Una specie di pulpito ingombrante da dove parlò il duce e sul quale ancora si legge, benché scalpellata via, la scritta “fascismo anno X” in una vistosa formella popolata di personaggi in orbace che salutano romanamente. Che male può portare il giovane Bigio? Non quello di una resurrezione, ma di un’ammissione di colpa. Recuperarlo significa dar torto a chi lo fece a pezzi, specie se all’epoca sbagliò obiettivo. Se non condivisibili, le ragioni degli oppositori sono almeno comprensibili. Ma quanti si sentono eredi diretti della Resistenza dovrebbero meditare sulla forza simbolica di una concessione che da sola basterebbe a scongiurare l’evocazione dello spettro. I simboli del passato mantengono la loro forza solo quando gliela si concede e ci si arma contro di loro. In questo caso è l’esorcismo a suscitare il demone. Se il Bigio tornerà a casa in silenzio, senza scalpori, Brescia avrà una bella statua in più, una piazza compiuta, un pezzo di memoria recuperata. E ciò che è morto resterà sepolto.