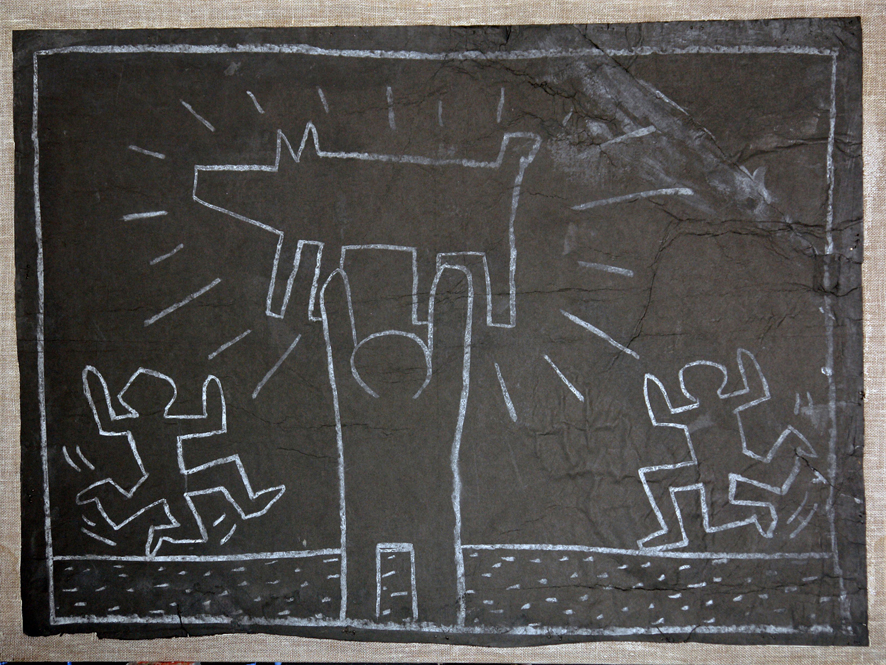Ci si potrebbe ingegnare in mille modi per spiegare il Barocco e la sua complessa pluralità espressiva. Ma, dismessa la livrea della storiografia ortodossa, l’istantaneità di un’agnizione rifulge, idealmente, in un’ipotetica antologia sull’esprit di quell’epoca; e, soprattutto, sulla sua essudazione pittorica. La si rinviene, come pescando da palombari negli abissi dell’imagerie letteraria, in un noto romanzo di Curzio Malaparte, La pelle (1947). Per la cui prosa, peraltro, è stato sovente rinverdito l’aggettivo “barocca”, vero jolly terminologico. Immagini srotolate con forza di maniera; un’occasionale crudezza realistica, sempre pronta a far capolino tra pieghe estetiche e piaghe di vita; una spuma lirica ricamata sull’onda di un distaccato cinismo: così, Malaparte, che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato reporter, racconta Napoli, la sua vita, ela Vita in un romanzo infarcito di descrizioni, più che di eventi; di evocazioni di turgore pittorico. Una passo giustamente celebrato è relativo ad un banchetto – tema amato dal Barocco, ancora fino alle sottigliezze Rococò d’un Tiepolo. Il Generale Cork invita nel Palazzo dei Duchi di Toledo i propri commensali. Entra in scena una portata singolare:
Una bambina, qualcosa che assomigliava a una bambina, era distesa sulla schiena in mezzo al vassoio, sopra un letto di verdi foglie di lattuga, entro una grande ghirlanda di rosei rami di corallo. Aveva gli occhi aperti, le labbra socchiuse: e mirava con uno sguardo di meraviglia il Trionfo di Venere dipinto nel soffitto da Luca Giordano. Era nuda: ma la pelle scura, lucida, dello stesso color viola del vestito di Mrs. Flat, modellava, proprio come un vestito attillato, le sue forme ancora acerbe e già armoniose, la dolce curva dei fianchi, la lieve sporgenza del ventre, i piccoli seni virginei, le spalle larghe e piene.
Poteva avere non più di otto o dieci anni, sebbene a prima vista, tanto era precoce, di forme già donnesche, ne paresse quindici. Qua e là strappata, o spappolata dalla cottura, specie sulle spalle e sui fianchi, la pelle lasciava intravedere per gli spacchi e le incrinature la carne tenera, dove argentea, dove dorata: talché sembrava vestita di viola e di giallo, proprio come Mrs. Flat. E come Mrs. Flat aveva il viso (che l’ardore dell’acqua bollente aveva fatto schizzar fuori della pelle come un frutto troppo maturo fuor della sua scorza) simile a una lucente maschera di porcellana antica, e le labbra sporgenti, la fronte alta e stretta, gli occhi tondi e verdi. (…) I fianchi, lunghi e snelli, finivano, proprio come dice Ovidio, in piscem, in coda di pesce. Giaceva quella bambina nella sua bara d’argento, e pareva dormisse. Ma, per un’imperdonabile dimenticanza del cuoco, dormiva come dormono i morti cui nessuno ha avuto la pietosa cura di abbassar le palpebre: ad occhi aperti. E mirava i tritoni di Luca Giordano soffiar nelle loro conche marine, e i delfini, attaccati al cocchio di Venere, galoppar sulle onde, e Venere nuda seduta nell’aureo cocchio, e il bianco e roseo corteo delle sue Ninfe, e Nettuno, col tridente in pugno, correr sul mare trainato dalla foga dei suoi bianchi cavalli, assetati ancora dell’innocente sangue d’Ippolito. Mirava il Trionfo di Venere dipinto nel soffitto, quel turchino mare, quegli argentei pesci, quei verdi mostri marini, quelle bianche nuvole erranti in fondo all’orizzonte, e sorrideva estatica: era quello il suo mare, era quella la sua patria perduta, il paese dei suoi sogni, il felice regno delle Sirene.
Quello di Malaparte è una sorta di sdoppiamento stilistico, un travestimento mimetico. Il suo personaggio – la bambina-pesce, che poco dopo si apprende essere un sirenoide dell’acquario di Napoli – possiede una pelle così barocca, che finisce per gemmare una visione nella visione, ossia quella del Trionfo di Venere di Luca Giordano. Un espediente tipico della poesia barocca è quello della trasformazione di una materia nell’altra: così la “pelle” della bambina sembra “seta”, ma è anche “argentea” e “dorata”, ed il suo viso è una “maschera di porcellana antica”, emula di certi bagliori rilucidati d’un Rubens. Queste continue trasformazioni erano amate soprattutto dalla scultura: proprio dall’Ovidio citato da Malaparte, ad esempio, è tratto il mito di Apollo e Dafne, da cui, alchimista del marmo, Bernini trasse partito nel gruppo della Galleria Borghese per trasformare la carne in lauro, nell’inseguimento del dio alla sua riluttante amata. E ancora: quelle spalle “larghe e piene”, da far venire in mente ancora le carni di Rubens; o le “forme armoniose”, fatte di curve e sporgenze, che danno da pensare a quello che lo storico Heinrich Wölfflin scrisse sul Barocco: “il trionfo della linea curva sulla linea retta”.


Quando, poi, si legge l’ecfrasi, appena accennata come una pittura disfatta che abbia sciolto il disegno in una trama d’impressioni, del Trionfo di Venere di Luca Giordano, viene in mente il Trionfo di Giuditta (1703-04) sul soffitto della Cappella del Tesoro della Certosa di San Martino, sempre a Napoli: le stesse nuvole ovattate, il fasto di un corteo disperso nel turbine turchino del cielo, ma soprattutto un “paese dei suoi sogni”, un contraltare visivo onirico ad un contesto di sfacelo. La peste doveva intitolarsi il romanzo di Malaparte – titolo poi rigettato, perché considerato troppo violento: quella “peste” che aveva visto un altro dei pittori barocchi napoletani, Mattia Preti, esprimersi con gli affreschi votivi nel 1656 sulle porte della città. Di certo, materiale per le meditazioni del giovane Luca, che tra Roma e Venezia, tra i Carracci e Veronese, veniva condendo ed impastando una tavolozza più ricca, densa e luminosa rispetto agli esordi post-caravaggeschi. Una muta, una pelle diversa, nutrita dei memento mori della Storia, della cecità dei fasti, delle messe in scena insistite del potere: come una portata inghirlandata su di un vassoio.