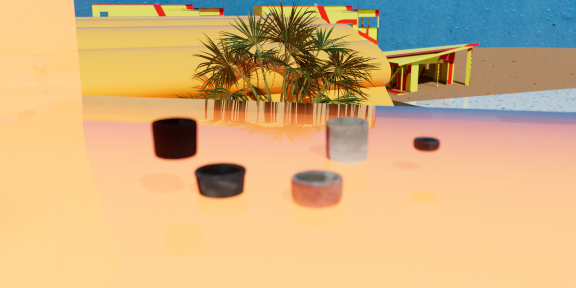È con un invito e una domanda che Alberta Pane riapre gli spazi della sua galleria veneziana: la mostra, che ha primo obiettivo quello di ribadire l’esigenza e l’importanza della condivisione, si intitola non a caso Share Happiness, e cerca di affrontare con relativa leggerezza alcuni dei quesiti posti o acuiti dalla recente emergenza sanitaria.
Prima di una trilogia di mostre che dovrebbero svolgersi tra il 2020 e il 2021 la collettiva espone opere selezionate e prestate da sette gallerie veneziane (otto con la stessa Pane), cui seguiranno nelle due edizioni successive gallerie italiane e internazionali.
Nato in primis dall’esigenza di fare rete il progetto vuole ribadire l’importanza della galleria come spazio di creazione e interazione, e si pone come occasione d’incontro e confronto.

Per l’esposizione veneziana l’ispirazione nasce dal Frankenstein di Mary Shelley: romanzo ottocentesco celeberrimo il libro sembra oggi quanto mai attuale per i quesiti che solleva, tra cui ruolo e limiti del Prometeo moderno, rapporto tra autore e opera e tema dell’isolamento.
Victor Frankenstein sfida divinità e morale gareggiando con Dio ma la sua creatura mostruosa, emarginata e incompresa, finisce per macchiarsi di crimini e delitti terribili: abbandonata anche dal suo creatore sparirà infine nei mari del nord, inconsolabile di fronte alla propria solitudine.
Reduci da un periodo di isolamento a nostra volta veniamo spinti, stavolta in quanto spettatori, a interrogarci su quale sia il senso di un’esistenza non condivisa, quale il senso di un’arte priva di fruizione e compartecipazione.
La fragilità e la perdita di riferimenti sono temi che ricorrono in più opere: dalle coordinate di Mohammed Kazem, astratte nella loro decontestualizzazione, all’immaginario dell’installazione di Kensuke Koike, suggestivo quanto oscuro; dalle delicate sculture di Lilla Tabasso, i cui fiori di vetro combattono (e sembrano vincere) il cemento, alla testimonianza di MatsBergquist, che con intervento minimalista lascia traccia di un episodio drammatico del suo vissuto.
C’è sicuramente un sottile senso di alienazione a fare da fil rouge alle opere esposte ma anche consapevolezza, che si trasforma a seconda dei casi in distacco, partecipazione attiva o ironia.

L’osservazione scientifica dell’oggetto-virus (ingigantito e tradotto in installazione visiva da Michelangelo Penso) è anche strumento per distaccarsene, così come l’accostamento di Penzo + Fiore: le immagini, prese da internet e di natura disturbante o bizzarra, sono stampate su bugiardini che nel renderle metafora di malattia sociale ne depotenziano il contenuto, e più che sdegno o curiosità sembrano suscitare indifferenza e straniamento.
L’essere umano è l’animale grottesco dei disegni di Nives Kavurić-Kurtović ma anche quello sociale rivendicato da Kateřina Šedá, che con i suoi lavori di arte relazionale riporta al centro la comunità cercando di ricucire fratture politiche ed economiche; è mostro e scienziato, osservatore e attore ma, quale che ne sia la manifestazione, non può prescindere dal confronto con l’altro, semplice “spettatore” o parte attiva che sia.
A prendere vita è un percorso che sembra rispondere in modi diversi alle stesse domande, una narrazione che, pur esibendo prospettive e approcci differenti, si risolve in riflessione comune. La reazione agli eventi recenti e presenti ha sfumature diverse ma si dimostra coerente in dubbi e intenzioni: le risposte mutano ma le domande sono condivise, e una pluralità di voci a confronto non può che arricchire il dibattito.