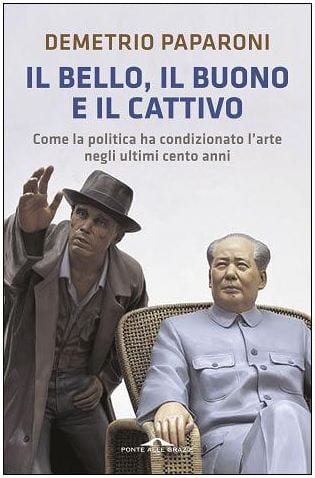Ha inaugurato lo scorso 20 gennaio On the Wall, la nuova collettiva sulla figurazione pittorica curata, e appositamente studiata, da Demetrio Paparoni per gli spazi di BUILDING, che presenta più di quaranta opere inedite, o mai esposte prima in Italia, di Paola Angelini, Rafael Megall, Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke Slyngstad e Ruprecht von Kaufmann. Dalle nuove frontiere della figurazione al tentativo di governare le molteplici soluzioni del contemporaneo, fino al ruolo che ricopre nella mostra uno spazio dall’identità ibrida come BUILDING, in questa intervista abbiamo avuto il piacere di poter approfondire diverse tematiche con Demetrio Paparoni, partendo da una domanda di fondo da cui il curatore tesse le fila: perché non si è mai smesso di realizzare dipinti figurativi nonostante la tecnologia ci porti a visioni inedite?
Gli artisti proposti (eccetto Paola Angelini) ritornano con lei dopo la mostra Le nuove frontiere della pittura ospitata, tra il 2017 e il 2018, dalla Fondazione Stelline di Milano. Come si sono sviluppati i linguaggi di Rafael Megall, Justin Mortimer, Nicola Samorì, Vibeke Slyngstad, Ruprecht von Kaufmann in questi ultimi anni? Le frontiere della pittura di cinque anni fa sono state varcate? Che direzione sta prendendo oggi la figurazione?
Direi che rispetto alle precedenti mostre vedo dei cambiamenti, più evidenti in Megall, Samorì e Slyngstad. Ma -e questo vale per tutti- ogni nuovo dipinto aggiunge sempre qualcosa alla consapevolezza del suo autore. Ogni artista è una storia a sé. La mia scelta ha tenuto conto più delle differenze che dei tratti comuni, che pure ci sono. Cambia lo stile, la provenienza culturale, le vicende individuali, il metodo. Nicola Samorì è uno sperimentatore, tutto il suo lavoro di pittore muove dal concetto che l’opera è un corpo e che la pittura è la sua pelle. È un costruttore di immagini, lontano dall’iconoclastia, eppure la sua opera si presta a questo equivoco. Basti pensare ai lavori su marmo: sceglie lastre corrotte da un difetto e poi, proprio attorno a quella imperfezione costruisce una figura e una narrazione che nobilita il difetto stesso, in quanto lo fa diventare l’elemento da cui si genera l’immagine. Fa questo anche nella scultura. Ma il suo corpo d’opera è molto variegato. Per quanto possa sembrare forzato, trovo diversi punti di contatto tra l’attitudine di Samorì e quella di Rafael Megall. Entrambi non cercano la bellezza, sono interessati a mettere in evidenza un tarlo che corrompe l’armonia dell’insieme. Samorì è attratto soprattutto dalla pittura barocca, Megall ha la cultura armena e la sua storia che gli scorrono nel sangue, ma c’è anche molta cultura pop in lui, assente in Samorì. Sia l’uno che l’altro non lavorano per realizzare dei cicli, tuttavia i loro lavori possono essere raggruppati per soggetti.

Vibeke Slyngstad invece si concentra su dei cicli pittorici che porta a termine prima di passare ad uno nuovo. Nel suo lavoro c’è molto della sua vita privata e del suo rapporto con la natura, ma anche con l’architettura modernista. C’è una narrazione personale anche in Justin Mortimer e in Ruprecht Von Kaufmann. Quest’ultimo sviluppa un discorso sociale sull’aggressione della natura da parte dell’uomo. Non è semplice riassumere in poche parole il lavoro di questi artisti. I lavori di Samorì e di Megall li seguo con continuità da anni (sempre a cura di Paparoni sono infatti la recente mostra al MMOMA di Mosca, quella alla National Gallery of Armenia e la partecipazione alla Biennale di Venezia nel padiglione armeno, ndr.), gli altri sono per me rapporti meno assidui. Esporli rappresenta anche un modo di conoscerli meglio.

Ha dichiarato che curare una mostra equivale a tentare di governare il caos della molteplicità di linguaggi e soluzioni del contemporaneo, volontà che, ben presto, arriva alla consapevolezza di un’impossibilità di fondo poiché forse non necessaria. Come ha tracciato e definito le coordinate di On the Wall? Su quale orizzonte si aprono le finestre della sua proposta?
Ogni mostra, come ogni libro, nasce da domande alle quali vuoi dare risposta. Difficilmente queste domande sono originali, ma questo importa poco, perché sono le risposte a doverlo essere. Una delle domande alla base di questa mostra è: perché non si è mai smesso di realizzare dei dipinti figurativi nonostante la tecnologia ci porti a visioni inedite? Una domanda, questa, che ci si è posti già con l’avvento della fotografia e che si ripropone dopo il digitale e la diffusione di programmi che permettono di manipolare l’immagine. E poi perché l’invasione delle fiction non è sufficiente a soddisfare la nostra sete di narrazioni? La percezione di un quadro non ha i tempi lunghi della letteratura e del cinema, ma nello stesso tempo capire quale significato esso incarni richiede tempo. Approdare al significato dell’opera attraverso un metodo analitico e non attraverso una lettura “creativa” è una bella sfida, che può darti più informazioni sul mondo e narrazioni ben più intriganti di quelle raccontate da una fiction. Ovviamente mi riferisco a dinamiche legate alla sfera della percezione visiva.


Molti dei dipinti in mostra hanno grandi formati.
Ho una predilezione per i dipinti di grande formato. Quelli in mostra sono stati realizzati quasi tutti appositamente, oppure non erano mai stati esposti prima in Italia. Le scelte sono state concordate con gli autori, ovviamente. I lavori di formato più piccolo mi sono serviti per creare delle pause visive. In questo caso per me sono stati un po’ l’equivalente della punteggiatura all’interno di un testo. Il che non significa che siano meno importanti o meno densi di quelli più grandi.
La mostra è ospitata in una galleria-non galleria, una realtà dalla natura ibrida tra spazio espositivo e museo contemporaneo. Ne consegue un avvicendarsi di artisti, curatori e situazioni differenti che si passano il testimone. È necessario (e quanto) ad oggi che il contenitore sia identificabile e coerente con il lavoro proposto? Quanto, dunque, è importante il luogo nella proposta di On The Wall?
La tipologia dello spazio espositivo condiziona molto non solo l’allestimento di una mostra, ma anche il suo concetto. Ma questo non vuol dire che un curatore debba tenere conto di cosa sia stato ospitato in uno spazio e cosa esporrà in futuro. Dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista del curatore, a interessarmi è l’unicità del progetto a cui sto lavorando. Non avverto un incarico come un passaggio di testimone, né voglio passare un testimone a chi verrà dopo di me nello stesso spazio. Come poi la questione possa essere avvertita dal gallerista, in questo caso Moshe Tabibnia, dovrebbe chiederlo a lui. Per quel che mi riguarda ho subito valutato che gli spazi di Building rispondono alla logica espositiva del cubo bianco, cioè di uno spazio che non interferisce con l’opera. L’altezza delle pareti è diversa da piano a piano, di questo ovviamente ho dovuto tenere conto. Il curatore si ritrova inevitabilmente a dare ordine all’insieme tenendo conto anche di questo.

Personalmente prediligo le pareti bianche, amo poco quelle colorate perché diventano una sorta di proseguimento dell’opera. In tal senso solo l’autore dell’opera può decidere se dare un colore alle pareti. In linea di massima una parete neutra mette meglio in risalto l’opera. Questo fermo restando che ogni progetto è un caso a sé. Adesso, per esempio, sto lavorando a una mostra che si inaugurerà l’11 marzo a Napoli, intitolata interACTION. La mostra sarà nella sede espositiva della Fondazione Made in Cloister, il chiostro di Santa Caterina a Formiello. Se studi un progetto per un chiostro rinascimentale, con un colonnato importante e con una struttura borbonica lignea al centro, è ovvio che la mostra sarà lontana anni luce da una come On the Wall. Direi dunque che sì, la struttura dello spazio gioca un ruolo determinante nella definizione non solo della presentazione delle opere, ma anche del concept della mostra.

Suoi progetti futuri, volontà di tracciare nuovi percorsi di ricerca, artisti emergenti che stanno delineando nuove frontiere. Ci racconti.
A marzo come ho detto curerò alla Fondazione Made in Cloister una mostra che presenterà di 27 artisti con una prevalenza di allestimenti site specific. Ma c’è altro in cantiere da fare prima dell’estate di cui preferisco adesso non parlare in attesa che tutto sia formalizzato. Sto lavorando tra l’altro a un nuovo libro sul sacro in arte. Sono vent’anni che esploro questo tema con diverse pubblicazioni, vorrei fare il punto su quello che ho già scritto sull’argomento, elaborando ulteriormente le tesi sviluppate.
A questo riguardo ricordiamo la recentissima ristampa per i tipi di 24 Ore Cultura del volume The Devil. Atlante illustrato del lato oscuro -a cui si affiancano un’edizione francese e una inglese-, 384 pagine che indagano per immagini la presenza del diavolo tra storia dell’arte e immaginario collettivo, da Giotto a Picasso, da Pollock a Serrano, dai Tarocchi ai Videogiochi.

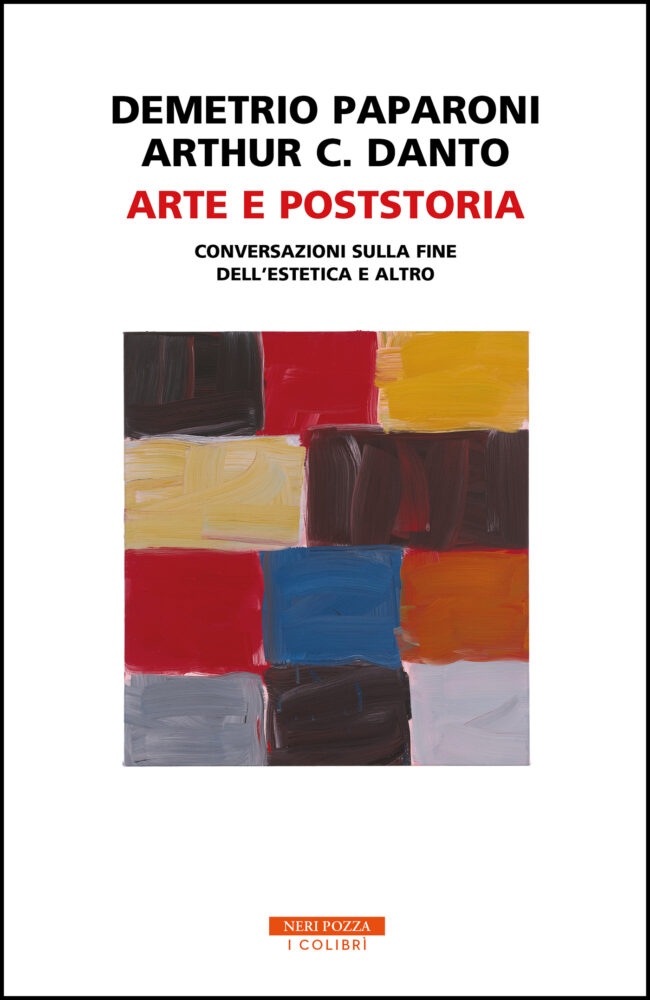

On the Wall
a cura di Demetrio Paparoni
20 gennaio – 19 marzo 2022
BUILDING
via Monte di Pietà 23, Milano
dal martedì al sabato, 10 – 19