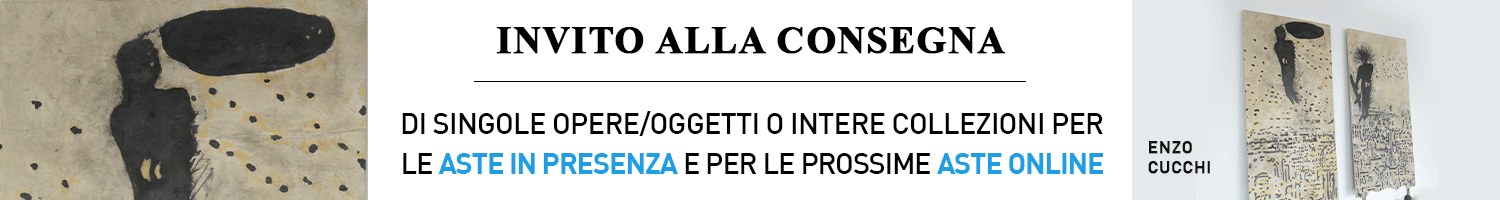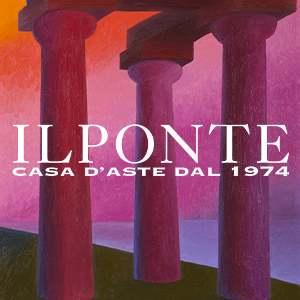Cosa s’intende per scultura oggi? Questa rubrica prova a rispondere attraverso le voci di alcuni tra i più interessanti artisti italiani, che ci raccontano la loro pratica. In questa puntata è il turno di Antonio Tropiano.
In un’epoca di virtualizzazione selvaggia la scultura è l’arte più anacronistica ma – parola di Antonio Tropiano, ex filologo medioevale e scultore del legno – la più necessaria. Proviamo a capire il perché.
Che cosa spinge un filologo medioevale a dedicarsi alla scultura?
Entrambe le discipline esistono in virtù dell’errore: la prima perché si propone di sanarlo, l’altra di evitarlo. Ma in tutti e due i casi quello ne determina l’agire. Il filologo opera per ricostruire un testo partendo dagli errori che la tradizione (specie quella precedente all’invenzione della stampa) ha perpetuato; al pari uno scultore (segnatamente nella sua accezione di operatore “per via di tòrre”) nel definire una figura lascia che la sua mano sia controllata dalla paura del “levare di soverchio”. Ecco, a pensar bene credo di non aver fatto altro nella vita che praticare l’errore tentando di scansarlo.

Quanto conta la memoria nel tuo approccio creativo?
La memoria è l’unico alfabeto di cui noi disponiamo per nominare le nostre sensazioni: erroneamente si ritiene che essa sia l’esito di un processo di sedimentazione; credo piuttosto che somigli più a un’officina, a quel luogo cioè dove per trovare soluzioni che oggi urgono si forgiano strumenti che prima non esistevano. Lì sta l’urgenza della memoria, nel corredo esperienziale che siamo riusciti a mettere a punto per leggere la realtà e le sue variazioni immaginifiche.
Il legno è, senza dubbio, il tuo medium preferito: un materiale calloso, caldo, povero, dalle mille venature. Perfetto per una Madonna con Bambino o per un Cristo in Croce di montagna. Tu però lo usi, virtuosisticamente, per realizzare oggetti che potrebbero essere plasmati in modo molto più semplice. Anche a costo di verniciarlo pesantemente, camuffando i suoi tratti distintivi. Per quale ragione?
Io non credo nei tratti distintivi di un materiale, ma nei suoi limiti: sono quelli ad incuriosirmi, con quelli mi riesce di instaurare un dialogo: né Donatello né Michelangelo sapevano che gran parte delle sculture classiche fossero in origine colorate, eppure hanno creduto di poter gareggiare con la plastica antica sul piano di quel biancore con cui le hanno sempre viste, e che essi stessi hanno percepito come un limite nella resa espressiva da dover sempre più spostare in avanti. Il legno non è solo venature e cromia variabile. E non direi affatto che sia povero, se non per la pigrizia con cui prolaghiamo una visione ereditata del pregio dei materiali: mi viene da pensare che il Buonarroti (solo per citare la vetta) non abbia mai tenuto per le mani un tronco di black walnut, di bobote, o di zebrano; ma che gli fosse di certo più facile procurarsi un grosso tronco di noce che un blocco di statuario carrarese… e solo che il primo mal si adattava al suo standard di eternità! E comunque a scanso di equivoci, tutto quel che ho detto nulla ha a che vedere con la ragione per cui io prediligo e uso il legno: la verità è che è l’unico materiale che mi procura un certo piacere: e la scultura è già di per sé stessa una pratica assai faticosa per non concedersi di farla con piacere.

Alcuni tuoi lavori mostrano in bella vista le fratture, i punti di rottura: un invito a ripristinare i ponti (non necessariamente sullo Stretto), a riconsiderare le nostre relazioni con l’esterno e con noi stessi?
Torniamo al discorso sui limiti del materiale: la scultura lignea da tronco, a differenza di quella da blocco esige di dover fare i conti con i movimenti di una materia che in una qualche misura rimane ancora viva. In questo caso si accoglie con consapevolezza, nel mio caso direi con piena intenzione, l’idea di affidare l’onere della rappresentazione di un preciso pensiero a un supporto e alla imprevedibilità delle sue modificazioni. Sovente nella mia scultura vi sono delle porzioni non pienamente definite, che non si possono affatto annoverare nelle forme del “non finito”: Rodin intese farle assurgere a componente essenziale della figurazione moderna (mutuandole sempre dalla “vetta”, vedi sopra); ma nel mio caso è assai diverso, quei segmenti sono piuttosto degli “irrisolti”, nel senso che non sono riusciti ad essere altro. Alla stessa maniera anche quelle fenditure a cui tu fai riferimento non hanno saputo essere altro, o prodursi altrove.
E poi c’è da credere che per un siracusano del V secolo a. C. o un monaco basiliano del VII d. C quel tratto tra Scilla e Cariddi non fosse certo l’esercizio metaforico di un proprio prematuro esistenzialismo.
Chi sono i tuoi modelli? Sbaglio o i surrealisti – i più intellettuali tra gli artisti – hanno lasciato il segno?
Non credo di averne altri se non tutti. Almeno quelli alla cui arte io sia giunto a conoscenza; e senza alcuna fregola di disposizione conseguenziale. Non sarei in grado nella maniera più assoluta di dire con la dovuta franchezza se a condurre od educare il mio sguardo sia stata più una schiena del Bernini o una strofa di Borges, se il concerto n. 3 di Rachmaninov sia valso meno del muro della lattaia di Vermeer, oppure se il Canova mi abbia detto dell’amore più di quanto non abbia fatto Lucrezio o meglio ancora Puskin. Nel mio caso tenderei a pensare che identificare dei modelli sia un processo quanto meno ozioso: sarebbe come ostinarsi a distinguere il cerchio dall’acqua su cui si è prodotto.

Le tue opere sono un viaggio al di là dello spazio noto, rassicurante della vita quotidiana. Superato il confine, si diventa migranti?
Siamo tutti migranti del mondo, perché ci ostiniamo ad abitarlo. E le mie sculture non lo cambieranno di un solo millimetro: esse sono solo un goffo tentativo di meritarselo. Nazim Hikmet nella sua Alla vita scrive: “[…] Prendila sul serio / ma sul serio a tal punto /che a settant’anni, ad esempio, pianterai /degli ulivi / non perché restino ai tuoi figli /ma perché non crederai alla morte, /pur temendola, /e la vita peserà di più sulla bilancia”. Io pianto dubbi.
Il titolo della tua ultima mostra, “Minima fragmenta”, rimanda alle meditazioni della vita offesa di Adorno: “la scheggia nell’occhio è la miglior lente di ingrandimento”. Come i pezzi di vetro dello specchio in frantumi della filosofia, anche i tuoi “frammenti minimi” riflettono la conversione dell’umano in disumano dei nostri tempi “ultimi”, tra gassificazione dell’esperienza, conflitti e pandemie?
Non mi appassiona l’universale, prediligo il particulare, la scheggia, il pezzetto, il coccio, il frammento: lì credo si verifichi la mutazione delle cose; lì credo che si annidino le ragioni della metamorfosi con cui le cose sopravvivono a se stesse. Non faccio molto altro di più che osservare dei fenomeni che accadono e di cui facciamo parte, e ne cerco la grammatica. Niente di più assurdo, visto che essa non solo sa celarsi magistralmente fino a far dubitare della sua esistenza, ma anche perché pur scorgendola sarebbe una impresa inintelligibile figurarla (non tutti saprebbero essere l’Alighieri davanti al bagliore della Trinità). Con tutta sincerità sono certo di non averla mai trovata, e che la cosa si faccia via via più difficile: ma sai com’è fatto l’uomo: è l’unico bipede intelligente al mondo che non si applica.

Che cosa pensi della scultura contemporanea, è viva o morta?
Diciamo che è sotto terapia farmacologica. Come tutte le altre forme d’arte, specie quelle figurative. Anzi tra tutte è divenuta quella più anacronistica: dal momento che non può, né sa fare a meno della materia in una stagione del mondo in cui domina l’antimateria. In cui cioè una cosa non esiste in quanto tale ma solo nella misura in cui viene raccontata, e diffusa nella sua componente immateriale. Non mi riesce infatti di immaginare nulla di tanto compiutamente assimilabile all’antimateria quanto l’abuso di narrazione in cui siamo precipitati, e a cui abbiamo pensato bene di assegnare il nome di storytelling. La scultura è un esercizio (e non solo dello spirito) che non può prescindere dal suo gesto né da quel “soverchio” che la identifica con la propria materia: è proprio la sottrazione di essa, e in altri casi la sua aggiunta, a qualificare la scelta dell’artista di assegnare alla materia restante un’emozione, un assunto, una paura; e al fruitore la libertà di decodificare il segreto della sua bellezza. Mi verrebbe da dire che una scultura è fatta dagli scarti del materiale ancor più che dal suo esito; perché è lì che si realizza la facoltà, l’intelligenza, la natura precipua del suo artefice. È lo scarto tra la figura e le figure possibili a fare l’arte dell’opera; che per quanto suscettibile di una dilatazioni dei significati (il che non sarebbe affatto deplorevole) e della sua valenza estetica, non può essere pienamente assunta dalla sua sola proiezione: la scultura può vivere dignitosamente al Bargello o in uno smartphone, può agevolmente albergare in una galleria a Miami o in un post sotto due versi di Alda Merini, basta non sottrarla alla sua materia e alla generazione che da questa prende abbrivio. Altrimenti sarebbe una pratica inutile, facilmente assolvibile dal solo bla bla bla.
A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?
Alla scultura, ossia a guardare dove non si vede.