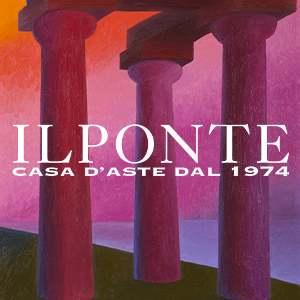Un artista che usa (anche) la pittura in senso spaziale. Per la nona puntata di Progetto (s)cultura parla Nicola Samorì. E se l’arte è un crimine contro il futuro, che ipoteca, le opere di Samorì, anticipando il tempo, riportano giustizia.
La scultura è il tuo primo amore: è da qui che hai cominciato a togliere, a levare?
La maschera di Tutankhamon – che durante l’infanzia divenne una fisima – è un guscio che protegge un pieno, ed è alla replica di questa forma cava che mi sono dedicato prima ancora di imparare a leggere. Senza dubbio in principio è stata la scultura, mentre il corteggiamento del colore è ancora in corso.
Sia come sia, i tuoi quadri densi, stratificati, sono così carichi di solchi da somigliare a rilievi.
In fondo un dipinto è sempre un rilievo. Non sono convinto del fatto che una scultura sia sempre pittura, ma sicuramente la pittura è sempre scultura. Anche la più piatta: basta sbucciarla.
I tuoi lavori scultorei mi hanno sempre fatto pensare a un nucleo generativo: la Pietà Rondanini. Il pentimento in limine mortis come extrema ratio di attivazione del senso.
Oltre un’opera così c’è solo la scomparsa. Il resto è tutto un retrocedere, come di fronte a un buco di Fontana. Ci sono opere che obbligano a tornare indietro; sono una strada senza uscita, anche se non è possibile distogliere lo sguardo. Penso agli ultimi autoritratti di Rembrandt: bisogna essere superiori al proprio mestiere, averlo calpestato, aver perduto quasi tutto per concepire questi acuti; eppure coltivare ancora una strana forza residua che sprona a dire. È il talento sconcertante che ha scavalcato se stesso. Facendo cento passi indietro cerco di dare un’ultima possibilità a una immagine. La minaccio per suscitare una ribellione.

Dove però Michelangelo finisce, tu inizi. Lui mirava al concetto, tu al vuoto che esso lascia.
Ripeto spesso che nella mia opera più che di “non finito” si dovrebbe parlare di “sfinito”.
Parlare del vuoto, e delle ferite da cui il vuoto si affaccia, significa rifarsi ai Tagli e ai Concetti Spaziali di Fontana, o alle guaine rinsecchite dei corpi del suo maestro Adolfo Wildt. Altri scultori, antichi e nuovi, da cui ti senti attratto?
Alcuni scultori e sculture che osservo: le ossa in marmo statuario di Matteo Civitali; ogni altorilievo che conosco del Bambaja; tante fusioni di Matthew Barney; il ritratto di Matthew Barney realizzato da Barry X Ball; quasi tutte le cere di Berlinde De Bruyckere e molti ammassi di detriti di Peter Buggenhout; i San Girolamo in marmo di Alessandro Vittoria custoditi a Venezia; pressoché tutto Donatello; decine di intagliatori di avorio e di legni duri, in particolare Joachim Henne; ogni peluria marmorea cesellata da Giuliano Finelli; la pelle di pietra di Girolamo Segato; i vetri di Andra Ursuţa; i pensatori dei sorrisi della facciata della Cattedrale di Reims; i legni di Michel Erhart e di Giovanni Tedesco; diverse opere polimateriche di David Altmejd, Matthew Monahan e Matthew Day Jackson. Per riposare gli occhi e preparare le dita osservo Lorenzo Bartolini e il suo allievo Paolo Visani di Cotignola, che colleziono.
In alcune opere al vuoto si giunge per effetto di pienezza. Penso ad esempio a Drummer, la scultura che qualche tempo fa campeggiava al centro dell’ex-Chiostro della Chiesa di S. Caterina a Formiello per la tua mostra Black Square. Lì il soggetto – la Morte come batterista – sembrava formato come gli obelischi napoletani, accatastando l’uno sull’altro elementi eterogenei. Con tanto di lapilli vulcanici a condire la pietanza.
Parlarne come di una pietanza è corretto. La fame e la nausea sono forze che agiscono di continuo: in pittura, per esempio, scelgo a volte prima in base all’olfatto, e successivamente ai colori. Certe materie mi inebriano, altre le trovo stucchevoli, altre ancora sorprendenti, come quando scolpisco il marmo bardiglio e si sprigiona l’odore di zolfo. Il profumo della pittura a olio si calma lentamente, mentre quello della scultura su pietra si placa subito. Ma c’è un odore minerale che chi scava i sassi conosce.

“Quello che è importante nel lavoro di Samorì”, ha dichiarato Demetrio Paparoni a proposito della tua pittura, “è il peso che il metodo assume nel far sì che l’opera incarni un significato”. Demetrio si riferiva a certe azioni performative che, in un attimo, sono in grado di cambiare il senso di un dipinto come un taglio o un’incisione. Immagino che anche la scultura abbia il suo “metodo”.
La svolta nella mia pratica di scultore ha avuto luogo nel momento in cui sono riuscito a dare una risposta a questa domanda: come è possibile imprimere alla pietra la stessa freschezza di un dito che entra nella pasta della pittura? I geodi sono la risposta; quelle cavità naturali che si formano all’interno della roccia e che preesistono a ogni possibile avvenimento umano. L’azione è ovviamente cronologicamente inversa, poiché quello che in pittura avviene in un attimo al termine di un lungo processo, in scultura è un millenario “gesto geologico” intorno al quale prende forma l’immagine.
Dove un Bernini, trovando una vena in un blocco di candido granito, si sarebbe messo le mani ai capelli, tu stappi una bottiglia di champagne
Certo, il “difetto” in questi casi è un dono, e incorniciare la cicatrice minerale è la vocazione di buona parte della mia scultura. Sono attratto da geodi, bolle d’aria, passaggi repentini di tono, difformità della durezza.
Tornando al processo, potresti distinguerne le fasi?
Realizzo le matrici per le sculture modellando in piccolo formato la cera mista ad altri materiali, e poi ne faccio l’impronta in silicone. Dentro il negativo in silicone verso alginato (usato comunemente dai dentisti per rilevare le impronte dei denti) che essicca in pochi secondi lasciando silenzi nel modellato, interruzioni e bolle d’aria. Il destino del futuro marmo si decide in pochi istanti e di ogni soggetto realizzo decine di repliche difformi; segue una sorta di casting che porta all’elezione di un solo modello nel quale riscontro la grazia necessaria per divenire pietra. Ogni pieno e ogni vuoto vengono trascritti con scrupolo nel marmo, che diventa una sorta di lente minerale su un episodio frutto di una rapida combinazione di caso e di controllo.
Nessun impressionismo, nessuna frammentazione.
L’apparente estetica del frammento si disinnesca quando si osserva una mia scultura da vicino, poiché quelle che sembrano rotture sono a tutti gli effetti brani di scultura totalmente finiti, spesso portati a lucido, come se il silenzio del corpo meritasse una cura maggiore.
Fai tutto questo da solo, come coi tuoi dipinti?
A differenza della pittura, la mia scultura spesso si avvale dei migliori laboratori italiani, fondamentali per la scansione dei modelli e la fresatura delle materie dure, oppure per la stampa 3D in materie leggere e resistenti. Tuttavia la pelle delle opere è interamente trattata da me, perché non sarebbe pensabile delegare ad altri la scrittura della superficie più sensibile. Quello che chiamiamo “artista” per me dovrebbe essere anche “primo artigiano” (come lo era in passato), colui che attraverso l’abilità e l’audacia riscrive la tecnica. Nelle mie opere l’idea non si esaurisce nella sua concezione, ma evolve di continuo, nel momento in cui l’attrito offerto dalla materia riduce gradualmente la sua resistenza.
A quali laboratori sei solito rivolgerti?
Il laboratorio col quale collaboro più attivamente, da una decina di anni, è la carrarese Torart di Filippo Tincolini e Giacomo Massari, dove hanno preso forma praticamente tutti i miei marmi in stretta collaborazione con Michele Basaldella, col quale si ispezionano le cavità dei massi e il loro disegno esterno, cercando a volte di portare la pietra verso i limiti di resistenza della stessa. Collaboro anche con WASP di Massalombarda, a pochi km dal mio studio, una eccellenza nell’ambito della ricerca sulle tecnologie di stampa 3D; è con Massimo Moretti, il fondatore dell’azienda, che ha preso forma il grezzo del gigantesco Drummer (cinque metri di altezza) esposto a Napoli nel 2020 e poi fuso in bronzo per Emilio Mazzoli.

Dalle amigdale del Paleolitico inferiore, gli strumenti del mestiere si sono un po’ evoluti…
La scultura è un’arte incline alla registrazione delle trasformazioni tecnologiche più di quanto non lo sia la pittura. A una sorta di non evolvibilità del pennello fa da contrappunto un aggiornamento costante dello scalpello che negli anni è quasi interamente sparito, diventando sempre più morbido. Una scultura senza scalpello quella attuale, si direbbe, tanto che non sembra possibile, oggi, leggere la virulenza dell’intaglio, perché il nostro braccio forte è diventato meccanico ed è completamente scomparso, se non in pratiche che sfiorano il naif, il colpo di subbia alla Michelangelo. Il Buonarroti spellava la pietra con una regolarità che prefigura il solco delle macchine, per esempio nel tratteggio mancino che si ammira nella base della Madonna Medici custodita nella Sagrestia Nuova in San Lorenzo a Firenze.
Certi effetti, per essere compresi, vanno osservati attentamente, da vicino.
Ogni volta che porto gli occhi alla parte bassa di quella scultura mi incanto nel leggere i fendenti che conservano una quota di energia e di sicurezza che fa venire i brividi. È come quando nella pittura ho capito che non potevano più esistere sciabolate come quelle sferzate da Mattia Moreni intorno al 1957; non che fisicamente sia impossibile, ma lo è culturalmente. Per ritrovare la necessità di gesti simili occorrerebbe una rivoluzione, forse un disastro globale, e la fine di una certa pigrizia indotta dalla meccanica dalla quale siamo aiutati, cullati, e in parte anestetizzati. Fuggire, ora, sarebbe folklore.
Per molti artisti la scultura è uno specchio: hai mai scolpito un autoritratto?
Ne realizzai molti da ragazzo, era un modo efficace per portare il sembiante fuori dalla testa. Incarnavo quasi sempre quello che non potevo essere: un Ercole piuttosto che un dandy. Poi seguì un silenzio che dura tuttora, e siamo a trent’anni buoni da quella giovinezza.

Hai mai pensato a una scultura da collocare nel cuore di una piazza?
Certo. Spesso la mia scultura, idealmente, abita il cuore di una piazza, anche se non lo ha ancora fatto. Immagino, per esempio, un monumento che invade la piazza centrale del mio paese (Bagnacavallo). Tutto parte dall’impronta in gesso che Canova realizzò sul corpo di un cavallo morente, custodita nel Mar di Ravenna. L’importante è tenersi alla larga dalle rotonde che, in particolare in Romagna, continuano a mietere vittime fra gli scultori.
Cosa pensi della scultura di oggi, italiana e non?
La scultura in Italia mi sembra in salute, forse più della pittura. Meno autori, ma con idee piuttosto chiare. Un po’ di nomi, cognomi e nomi d’arte che popolano il paesaggio: dalle tre “C” celebrate dal sistema – Maurizio Cattelan, Roberto Cuoghi e Giulia Cenci – a chi un sistema se lo è inventato di sana pianta come Jago, ma anche Fabio Viale; e poi Bertozzi & Casoni, Aron Demetz, Davide Rivalta, Chiara Lecca, Luca Francesconi, Diego Perrone, Luca Monterastelli, il formidabile Arcangelo Sassolino, senza dimenticare pilastri della nostra scultura contemporanea come Giuseppe Penone ed Enzo Cucchi. La scultura resta un piccolo polarizzatore perché può entrare nello spazio urbano (non la mia, non ancora), come la street art, e suscitare qualche flebile reazione, a meno che non si rovesci un monumento.
A cosa ti stai dedicando, a cosa ti dedicherai?
Ad allevare sfingi.