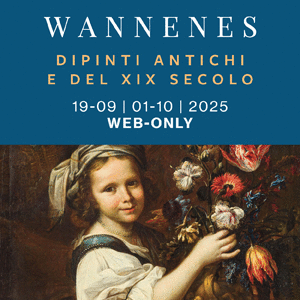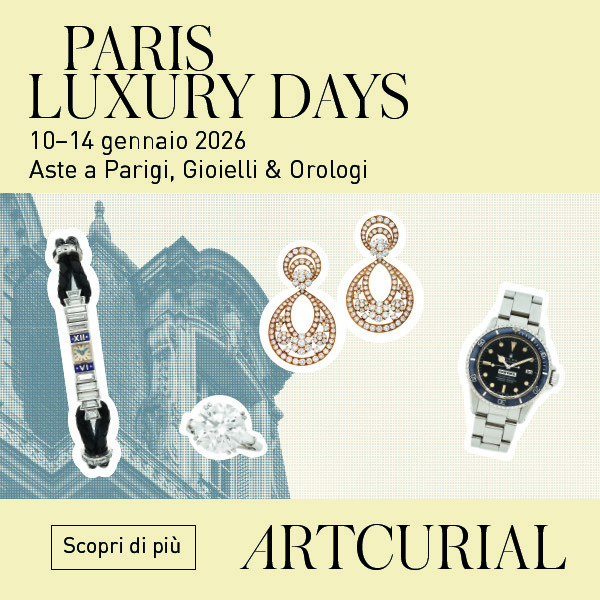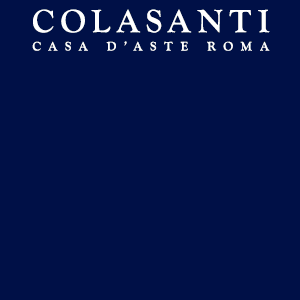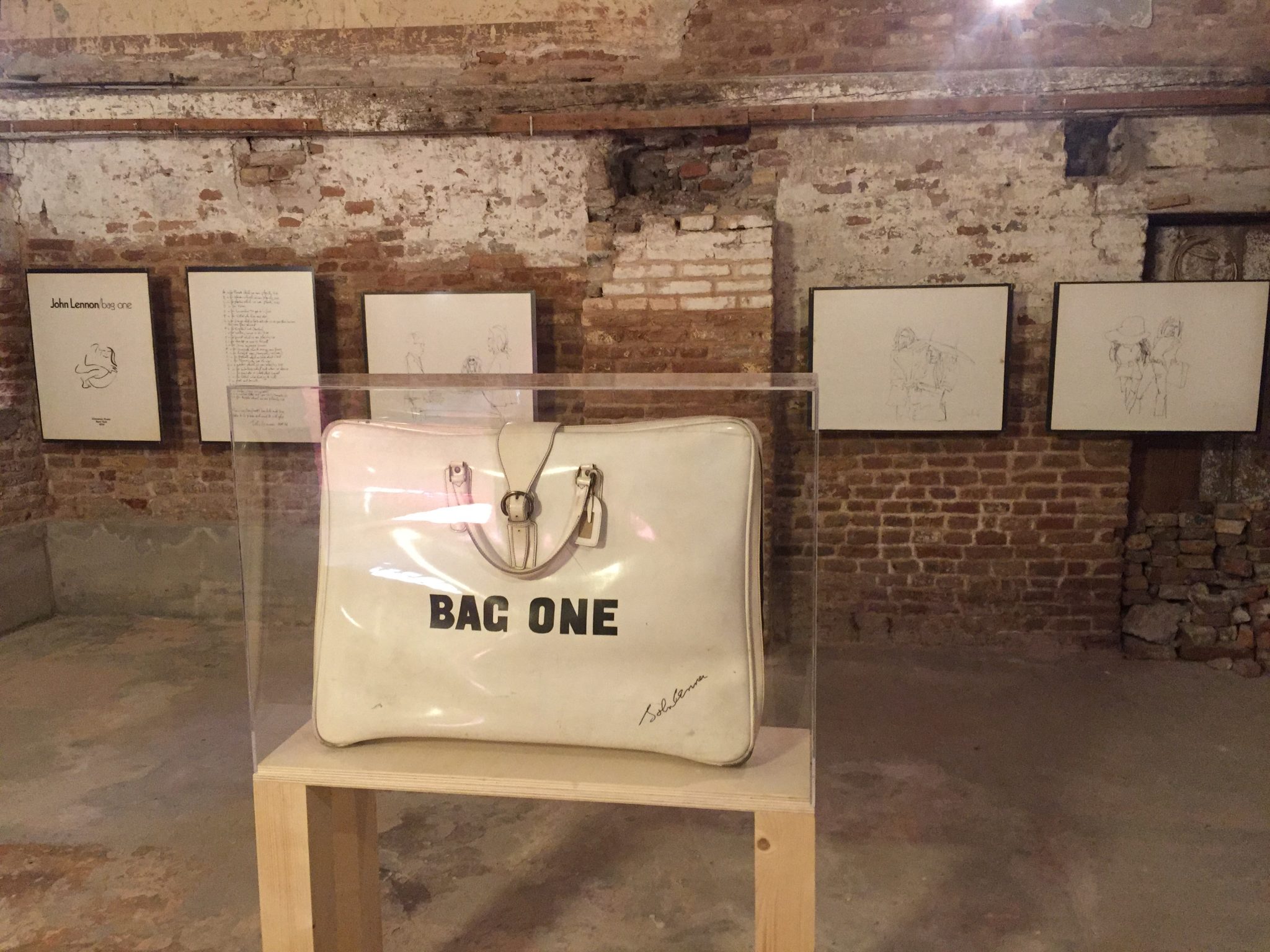Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri è il titolo del Padiglione Italia alla 18. Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della cultura e curato da Fosbury Architecture (Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino e Claudia Mainardi).
Per la prima volta un gruppo curatoriale costituito da architetti nati tra il 1987 e il 1989 porta a Venezia le istanze di una nuova generazione di progettisti under 40 (nove gruppi di progettisti e altrettanti advisor, professionisti provenienti da diversi campi delle industrie creative, per un totale di circa 50 persone con età media di 33 anni) cresciuta e formatasi in uno scenario di crisi permanente – la crisi culturale dell’Occidente innescata dall’11 settembre 2001, la crisi economica del 2007-2008, quella sanitaria degli ultimi anni, quella energetica e geopolitica di oggi e quella ecologica di domani – e che per questo ha fatto della collaborazione, della condivisione e del dialogo la base di ogni propria attività.
Una generazione consapevole, da un lato, dell’impatto e della responsabilità del settore delle costruzioni nella crisi ambientale e, dall’altro, della crisi di rilevanza dell’architettura e del progetto nella trasformazione di città e territori. Una generazione di progettisti che, rispetto alle precedenti, è cresciuta in un regime di scarsità di risorse e di opportunità, che vive come cruciale il tema della sostenibilità̀, e che sa che questo è l’unico contesto nel quale potrà operare ora e in futuro.

Spaziale. Ognuno appartiene a tutti gli altri porta al centro del Padiglione Italia un processo collaborativo ad ampio spettro, un progetto inclusivo che coinvolge figure di eccellenza e comunità locali, mettendo in scena le migliori ricerche portate avanti da architetti italiani under 40 in relazione a specifiche necessità territoriali. Per la prima volta, infatti, il Padiglione Italia è stato interpretato dai curatori come l’occasione per realizzare nuovi progetti: un attivatore di azioni concrete a beneficio di territori e comunità locali, oltre l’idea che una mostra debba essere solo “esibizione”.
All’interno del Padiglione Italia non viene dunque presentato un progetto finito, ma l’avvio di una serie di iniziative che avrà un impatto di lunga durata, restituendo una rinnovata immagine dell’architettura italiana nel contesto internazionale. La prima Tesa delle Vergini si presenta completamente vuota: scelta che ha permesso ai curatori di utilizzare solo la superficie strettamente necessaria e magnificare le qualità intrinseche di uno spazio che viene sistematicamente saturato dai contenuti che ospita. L’allestimento nella seconda Tesa raccoglie i nove progetti in un racconto unitario che mette a confronto le immagini delle esperienze locali, mostrandone luoghi e attori, con le installazioni realizzate dai progettisti disposte idealmente lungo un tracciato che ripropone la sagoma della penisola italiana.
Il lavoro di ciascun gruppo risponde a una serie di temi urgenti per il contesto italiano e la disciplina in generale: domande aperte, riconducibili allo scenario di transizione – non solo ecologica – che ci troviamo ad affrontare in questi anni; sfide ‘impossibili’ se prese a livello globale ma che affrontate nei contesti locali sono in grado di produrre riscontri immediati e tangibili. Eccoli sintetizzati qui sotto.
A Taranto la convivenza con il disastro viene raccontata sui tetti della città dal collettivo Post Disaster in dialogo con Silvia Calderoni e Ilenia Caleo

Nella Baia di Ieranto, oasi naturalistica del FAI nei pressi di Napoli, gli architetti BB – Alessandro Bava e Fabrizio Ballabio – con Terra-forma Festival mettono in scena la riconciliazione con l’ambiente

A Trieste la coesistenza multiculturale viene analizzata lungo il confine italo-sloveno da Giuditta Vendrame con Ana Shametaj

A Ripa Teatina, in provincia di Chieti, gli HPO con Claudia Dura- stanti coinvolgono la comunità̀ nel recupero del patrimonio incompiutoù

Nella terraferma veneziana, tra Mestre e Marghera, i Parasite 2.0 con Elia Fornari affrontano il tema dell’inclusione sociale lavorando sulla democratizzazione delle attività̀ ricreative

A Cabras, in Sardegna, il gruppo Lemonot lavora con Roberto Flore sulla transizione alimentare

A Librino, quartiere di Catania, Studio Ossidiana collabora con Adelita Husni Bey a un progetto di rigenerazione delle periferie

A Belmonte Calabro, a rappresentare le aree interne italiane, il collettivo Orizzontale con Bruno Zamborlin si interroga sul superamento del divario digitale

Infine, nella piana fra Prato e Pistoia, i progettisti (ab)Normal e CAPTCHA in collaborazione con Emilio Vavarella investigano i limiti della tutela del paesaggio e della sua riproducibilità̀