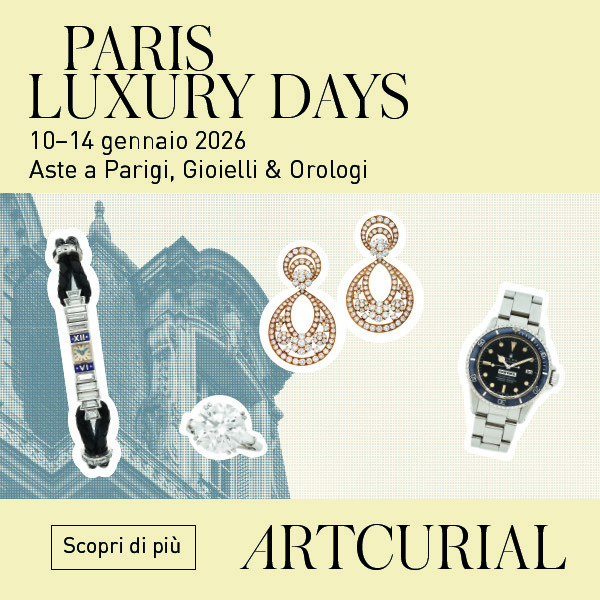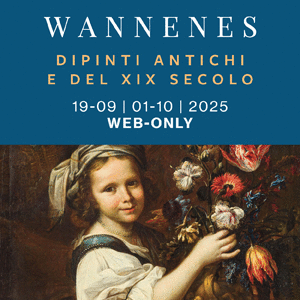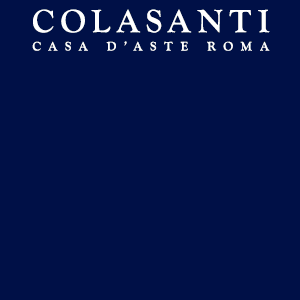Un restauro approfondito dell’ultima opera conosciuta di Caravaggio, Il Martirio di Sant’Orsola (1610), ha riportato alla luce dettagli a lungo nascosti, aprendo nuove prospettive interpretative sull’opera e sulla sua complessa composizione. Il dipinto, attualmente esposto alla grande mostra “Caravaggio 2025” a Roma, è stato oggetto di un intervento di pulitura che ha rivelato particolari finora invisibili, compromessi da secoli di danni e ritocchi.
La scena raffigura Sant’Orsola nel momento in cui viene trafitta da una freccia dal re degli Unni, Attila, dopo aver rifiutato la sua proposta di matrimonio. Nella composizione, la santa appare sorpresa mentre guarda la freccia che le trafigge il petto.
I precedenti restauri si erano limitati a un approccio conservativo. Ora, grazie all’uso di tecnologie avanzate, come i raggi X e l’imaging iperspettrale, è stato possibile identificare nuovi elementi che hanno guidato una pulitura più mirata.
Il lavoro, curato da Laura Cibrario e Fabiola Jatta, ha portato a tre importanti scoperte. La più significativa è l’emersione parziale del volto di un soldato, riconoscibile dal naso e dal profilo dell’elmo, situato accanto ad Attila. In un’altra sezione, il volto di una figura con un cappello, probabilmente un pellegrino, è ora visibile con maggiore chiarezza. Infine, è stato meglio definito un elmo sopra la testa di Sant’Orsola: la fessura per gli occhi indica che appartiene a un soldato in osservazione, e non è più un elemento ambiguo della scena.
“Queste tre figure arricchiscono il racconto del dramma di Sant’Orsola”, si legge in una nota di Intesa Sanpaolo, che possiede l’opera dal 1972. Il dipinto è solitamente esposto nel museo della banca a Napoli.

Realizzato appena un mese prima della morte dell’artista, l’opera fu commissionata dal principe Marcantonio Doria e inviata da Napoli, dove Caravaggio lavorava in fretta, diretto verso Porto Ercole, dove morirà il 18 luglio 1610. A causa della fretta, la vernice non era ancora asciutta al momento della consegna, e l’esposizione al sole causò danni irreversibili alla superficie.
Un primo restauro tra il 2003 e il 2004 aveva già chiarito alcuni elementi della scena, come la mano che si protende tra le due figure principali e la tenda sullo sfondo, che suggerisce un’ambientazione all’interno dell’accampamento di Attila.
Nonostante i progressi, le condizioni del dipinto restano problematiche. “È impossibile recuperare l’immagine intera”, ha spiegato la storica dell’arte Maria Cristina Terzaghi, curatrice della mostra. “Anche il nuovo volto emerso non è del tutto leggibile, ma oggi possiamo vederlo molto meglio.”

“Caravaggio 2025” non è solo un grande evento espositivo, ma anche un’occasione di studio. La mostra riunisce 24 opere, alcune provenienti da importanti musei internazionali come il Metropolitan Museum di New York, il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid e la National Gallery of Ireland, permettendo confronti diretti finora inediti.
La disposizione cronologica dei dipinti ha offerto nuovi spunti critici. Ad esempio, Davide e Golia della Galleria Borghese, da tempo oggetto di discussione sulla datazione, è stato messo a confronto con la Cena in Emmaus della Pinacoteca di Brera. Secondo Terzaghi, il confronto visivo rafforza l’idea che Davide e Golia appartenga agli ultimi anni di vita dell’artista.
Tra le sorprese, anche l’accostamento tra il Ritratto di Maffeo Barberini (ca. 1598), esposto per la prima volta, e Santa Caterina d’Alessandria della collezione Thyssen-Bornemisza, entrambi datati allo stesso anno. Due capolavori che rappresentano i momenti più intensi di una mostra che promette di restare a lungo nella memoria del pubblico e degli studiosi.