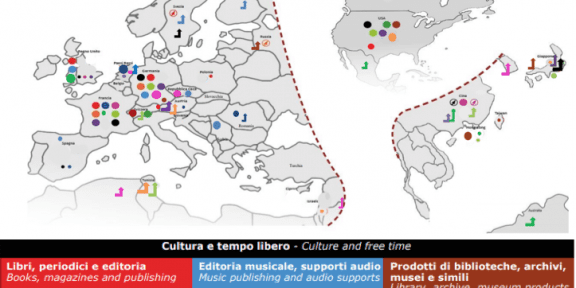Riflessione sulle dinamiche fra moda, responsabilità decoloniale ed etica della presenza: contro il mito dell’“ancestrale”
Riflessione sulle dinamiche fra moda, responsabilità decoloniale ed etica della presenza: contro il mito dell’“ancestrale”
Questo testo nasce da un rifiuto: il rifiuto di credere che il rinnovamento culturale possa avvenire attraverso la sola osservazione. Sostiene che i valori non possano essere restaurati prendendo in prestito simboli, né romanticizzando l’alterità. Possono essere ricostruiti solo attraverso una presenza condivisa, una collaborazione vissuta e una redistribuzione della voce. In caso contrario, la crisi dell’identità occidentale verrà semplicemente rivestita di intenzioni migliori.
Dopo il riconoscimento delle proprie violenze storiche, l’Occidente ha moltiplicato gli appelli al “ripristino dei valori”. Nella moda, questo appello assume spesso la forma di un ritorno alle culture indigene, ancestrali o cosiddette “tradizionali”: ai loro simboli, alle tecniche, alle cosmologie, alle estetiche. È qui che si annida un pericolo decisivo: il rischio che il rinnovamento diventi ripetizione, che ciò che viene presentato come riparazione etica finisca per riprodurre silenziosamente la stessa logica che pretende di contrastare.
Quando le culture vengono osservate, classificate, estetizzate e tradotte in quadri di riferimento occidentali senza essere vissute, condivise e co-costruite, il gesto resta estrattivo. La conoscenza, quando è separata dalla relazione, diventa un’altra forma di colonizzazione.
 Lo sguardo coloniale che sopravvive alla critica
Lo sguardo coloniale che sopravvive alla critica
La cultura occidentale non ha mai smesso di considerarsi portatrice di verità. Anche quando si autocritica, lo fa spesso da una posizione di superiorità epistemica. Edward Said ha diagnosticato questo meccanismo decenni fa in Orientalismo: l’Occidente non si limita a descrivere l’Altro, lo produce, lo fissa, lo rende leggibile secondo le proprie categorie. Ciò che viene definito “mistico”, “ancestrale” o “spirituale” spesso non è compreso, ma neutralizzato.
Questo sguardo persiste oggi sotto estetiche progressiste. Nella moda, le culture indigene vengono frequentemente ridotte a moodboard: silhouette sciamaniche, tessuti rituali, pattern simbolici privati della loro funzione cosmologica. Il linguaggio è rispettoso, ma la struttura resta invariata. La cultura è ancora lì per essere guardata, non qui per essere vissuta insieme.
La domanda di Gayatri Chakravorty Spivak – il subalterno può parlare? – rimane dolorosamente attuale. In molte narrazioni della moda, delle culture indigene si parla, raramente si parla con loro. Le loro voci vengono filtrate, curate, tradotte nel discorso occidentale, perdendo spesso la propria forza politica ed esistenziale. Il riconoscimento senza redistribuzione della voce non è riconoscimento. È appropriazione con intenzioni migliori.
 La conoscenza non è un dato: è tempo vissuto
La conoscenza non è un dato: è tempo vissuto
Uno dei più profondi fraintendimenti dell’Occidente nel rapportarsi alle culture non occidentali risiede nell’assunzione che la conoscenza possa essere estratta. Che possa essere documentata, archiviata, sintetizzata e riutilizzata senza essere incarnata. Ma la cultura non è informazione. È ritmo, gesto, memoria, terra e tempo.
L’antropologo-filosofo Eduardo Viveiros de Castro, attraverso il suo lavoro sul prospettivismo amerindio, destabilizza radicalmente l’epistemologia occidentale. Mostra come molte cosmologie indigene non organizzino il mondo attorno a un’unica natura universale interpretata da più culture (il modello occidentale), ma attorno a molteplici nature percepite da esseri differenti. Non si tratta di folklore. È un’altra ontologia.
Tradurre questi sistemi in narrazioni della moda occidentale senza abitarne la logica relazionale significa appiattirli. Il risultato è un consumo estetico mascherato da rispetto. In questo senso, la ricerca senza partecipazione vissuta non è neutra: è violenta nella sua astrazione.
 Moda e l’illusione dell’estetica etica
Moda e l’illusione dell’estetica etica
La moda occupa una posizione particolarmente sensibile. Opera sul corpo, sulla visibilità, sul desiderio. Non è mai innocente. Quando la moda dichiara di confrontarsi con culture indigene, la posta in gioco aumenta, non diminuisce. Troppo spesso la moda “decoloniale” si limita a un’etica di superficie: approvvigionamento, sostenibilità, citazione visiva. Per quanto necessarie, queste pratiche sono insufficienti. Senza collaborazione strutturale, co-autorialità e redistribuzione economica, rischiano di diventare alibi simbolici.
Achille Mbembe ci ricorda che le società postcoloniali sono ancora infestate da strutture di potere coloniali, anche quando il linguaggio cambia. Ciò che conta non è solo la rappresentazione, ma chi controlla il significato, la produzione e la circolazione. Nella moda questo significa porsi domande scomode: chi progetta? Chi trae profitto? Chi decide cosa una cultura “significa”? Se il sapere indigeno entra nella moda solo come fonte di ispirazione, resta subordinato. Una collaborazione autentica implicherebbe permettere a quel sapere di trasformare non solo l’estetica, ma anche i processi, le temporalità, le gerarchie e l’autorialità stessa.
Contro il mito dell’“ancestrale”
Uno dei gesti più insidiosi nel discorso contemporaneo della moda è la riduzione di intere culture all’aggettivo “ancestrale”. Apparentemente rispettoso, questo termine congela comunità vive in un passato senza tempo. Nega la loro contemporaneità, i loro conflitti interni, la loro evoluzione.
Come ricorda Stuart Hall, l’identità non è un’essenza ma una posizione. Descrivere una cultura come puramente ancestrale significa negarle il tempo presente. Significa trasformarla in una risorsa simbolica anziché riconoscerla come soggetto vivente.
La moda deve resistere a questa tentazione. Le culture non sono serbatoi di significati perduti in attesa di essere riattivati dalla creatività occidentale. Sono attive, complesse, moderne nei propri termini – anche quando rifiutano la modernità occidentale.
 Dall’esplorazione al riconoscimento
Dall’esplorazione al riconoscimento
Ciò che oggi è necessario è uno spostamento dall’esplorazione al riconoscimento. Il riconoscimento implica il ripristino della voce, dell’agency e dell’autorialità. Significa collaborazione a lungo termine piuttosto che ricerca a breve termine. Significa integrare le comunità nei processi vissuti della creazione, non posizionarle come oggetti di studio.
Bruno Latour sosteneva che il grande errore della modernità fosse l’illusione della separazione – tra natura e cultura, soggetto e oggetto, osservatore e osservato. Una pratica della moda realmente postcoloniale abbandonerebbe questa separazione. Comprenderebbe la creazione come relazionale, situata e responsabile. È un lavoro più lento. Resiste allo spettacolo. Rifiuta l’immediatezza delle tendenze. Ma è l’unica via che non riproduce la violenza che pretende di riparare.
Portare il passato senza ripeterlo
Ricostruire i valori dopo il riconoscimento non richiede di prendere in prestito simboli. Richiede di trasformare le relazioni. L’Occidente non ha bisogno di usare altre culture per sopravvivere alla propria crisi di senso. Ha bisogno di disimparare la propria posizione di arbitro del significato. La moda, se vuole essere qualcosa di più di uno specchio del collasso, deve diventare uno spazio in cui il sapere viene condiviso, non estratto; in cui la differenza viene incontrata, non consumata.
Il riconoscimento deve restituire voce, non solo visibilità. Altrimenti l’archivio di dubbio che la moda è diventata continuerà semplicemente ad espandersi – splendidamente progettato, eticamente formulato e strutturalmente immutato. E anche questo sarebbe colonizzazione – solo meglio vestita.
 Fashion, Decolonial Responsibility, and the Ethics of Presence: against the Myth of the “Ancestral”
Fashion, Decolonial Responsibility, and the Ethics of Presence: against the Myth of the “Ancestral”
This text begins from a refusal: the refusal to believe that cultural renewal can be achieved through observation alone. It argues that values cannot be restored by borrowing symbols, nor by romanticizing alterity. They can only be rebuilt through shared presence, lived collaboration, and the redistribution of voice. Otherwise, the crisis of Western identity will simply be dressed in better intentions.
The call to “restore values” after the West’s recognition of its historical violence has become increasingly insistent. In fashion, this call often takes the form of a turn toward Indigenous, ancestral, or so-called “traditional” cultures – their symbols, techniques, cosmologies, and aesthetics. Yet here lies a decisive danger: the risk that renewal becomes repetition, that what is framed as ethical reparation quietly reproduces the very logic it claims to resist.
When cultures are observed, categorized, aestheticized, and translated into Western frameworks without being lived, shared, and co-constructed, the gesture remains extractive. Knowledge, when detached from relationship, becomes another form of colonization.
 The Colonial Gaze That Survives Critique
The Colonial Gaze That Survives Critique
Western culture has never ceased to see itself as a bearer of truth. Even when it criticizes itself, it often does so from a position of epistemic superiority. Edward Said diagnosed this mechanism decades ago in Orientalism: the West does not simply describe the Other-it produces it, fixes it, renders it legible according to its own categories. What is named “mystical,” “ancestral,” or “spiritual” is often not understood, but neutralized.
This gaze persists today under progressive aesthetics. In fashion, Indigenous cultures are frequently reduced to moodboards: shamanic silhouettes, ritual textiles, symbolic patterns stripped of their cosmological function. The language is reverent, but the structure is unchanged. The culture is still there to be looked at, not here to be lived with.
Gayatri Chakravorty Spivak’s question-Can the subaltern speak?-remains painfully relevant. In many fashion narratives, Indigenous cultures are spoken about, rarely with. Their voices are filtered, curated, and translated into Western discourse, often losing their political and existential force in the process. Recognition without redistribution of voice is not recognition. It is appropriation with better intentions.
Knowledge Is Not Data: It Is Lived Time
One of the deepest misunderstandings in Western engagement with non-Western cultures lies in the assumption that knowledge can be extracted. That it can be documented, archived, synthesized, and repurposed without being embodied. But culture is not information. It is rhythm, gesture, memory, land, and time.
 Anthropologist-philosopher Eduardo Viveiros de Castro, through his work on Amerindian perspectivism, radically destabilizes Western epistemology. He shows that many Indigenous cosmologies do not organize the world around a single universal nature interpreted by multiple cultures (the Western model), but around multiple natures perceived through different beings. This is not folklore. It is a different ontology
Anthropologist-philosopher Eduardo Viveiros de Castro, through his work on Amerindian perspectivism, radically destabilizes Western epistemology. He shows that many Indigenous cosmologies do not organize the world around a single universal nature interpreted by multiple cultures (the Western model), but around multiple natures perceived through different beings. This is not folklore. It is a different ontology
To translate such systems into Western fashion narratives without inhabiting their relational logic is to flatten them. The result is aesthetic consumption masquerading as respect. In this sense, research without lived participation is not neutral-it is violent in its abstraction.
Fashion and the Illusion of Ethical Aesthetics
Fashion occupies a uniquely sensitive position. It operates on the body, on visibility, on desire. It is never innocent. When fashion claims to engage with Indigenous cultures, the stakes are therefore higher, not lower. Too often, “decolonial” fashion limits itself to surface ethics: sourcing, sustainability, visual citation. While these are necessary, they are insufficient. Without structural collaboration, shared authorship, and economic redistribution, they risk becoming symbolic alibis.
Achille Mbembe warns that postcolonial societies are still haunted by colonial structures of power, even when the language changes. What matters is not representation alone, but who controls meaning, production, and circulation. In fashion, this means asking uncomfortable questions: Who designs? Who profits? Who decides what a culture “means”? If Indigenous knowledge enters fashion only as inspiration, it remains subordinated. True collaboration would mean allowing that knowledge to transform not just aesthetics, but processes, timelines, hierarchies, and authorship itself.
Against the Myth of the “Ancestral”
One of the most insidious gestures in contemporary fashion discourse is the reduction of entire cultures to the adjective “ancestral.” While seemingly respectful, this term freezes living communities into timeless pasts. It denies their contemporaneity, their internal conflicts, their evolution.
As Stuart Hall reminds us, identity is not essence but positioning. To describe a culture as purely ancestral is to deny its present tense. It is to turn it into a symbolic resource rather than a living subject.
Fashion must resist this temptation. Cultures are not reservoirs of lost meaning waiting to be reactivated by Western creativity. They are active, complex, modern in their own terms-even when they reject Western modernity.
 From Exploration to Recognition
From Exploration to Recognition
What is required today is a shift from exploration to recognition. Recognition means restoring voice, agency, and authorship. It means long-term collaboration rather than short-term research. It means integrating communities into the lived processes of creation, not positioning them as objects of study.
Bruno Latour argued that modernity’s great error was the illusion of separation-between nature and culture, subject and object, observer and observed.
A truly postcolonial fashion practice would abandon this separation. It would understand creation as relational, situated, and accountable. This is slower work. It resists spectacle. It refuses the immediacy of trends. But it is the only path that does not reproduce the violence it claims to repair.
Carrying the Past Without Repeating It!
Rebuilding values after recognition does not require borrowing symbols. It requires transforming relationships. The West does not need to use other cultures to survive its crisis of meaning. It needs to unlearn its position as arbiter of meaning. Fashion, if it wishes to be more than a mirror of collapse, must become a space where knowledge is shared, not extracted; where difference is encountered, not consumed.
Recognition must give back voice, not visibility alone. Otherwise, the archive of doubt that fashion has become will simply expand-beautifully designed, ethically worded, and structurally unchanged. And that, too, would be colonization-only better dressed.