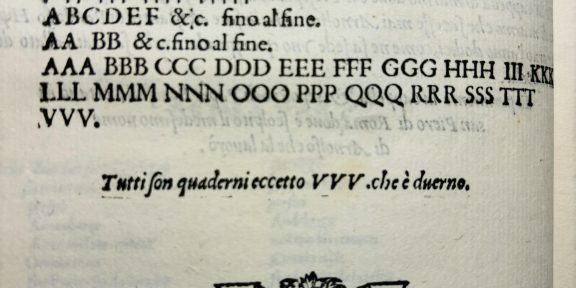Lo sa il cielo cosa dovrebbe inventarsi un giovane artista per riuscire a farcela. Eppure chi fa il mio mestiere si sente porre la fatidica domanda così sovente che è piuttosto facile ricordarsi cosa si è detto la volta precedente. E se è poi vero che una regola non esiste, non mi pare divisivo sostenere che se qualcuno la chiede è già manchevole di una caratteristica fondamentale: la sicurezza nel proprio agire. E senza quella, in questo settore, dove vogliamo andare?
Perché una strada tracciata non esiste e se ci fosse sarebbero tutti Picasso, come citava quel libro. Ma proviamo a spezzare il capello in quattro e, passando dallo spillo al missile, cerchiamo di cogliere qualche caratteristica dei fuoriclasse, quantomeno di quelli che mi vengono in mente. Iniziamo dalla base: studiare e viaggiare come Diego Velázquez, che partì dall’Andalusia e divenne uno dei più importanti pittori di sempre. Ebbe un’educazione religiosa ma anche linguistica e filosofica, studiò cinque anni con altri artisti imparando le proporzioni, la prospettiva e a dipingere come dio vuole con un pennello dalle lunghe setole. Tra il 1629 e il 1631 trascorse un anno e mezzo in Italia con l’intento di scovare e analizzare le opere d’arte presenti nel Paese, facendovi pure ritorno a metà secolo, giusto per non sbagliare. E sapete chi gli fece accrescere il desiderio di raggiungere la nostra penisola per esaminare le grandi opere? Peter Paul Rubens, conosciuto proprio a Madrid, l’anno prima di partire. E qui si coglie una buona nuova regola: frequentare persone che siano fonti d’ispirazione. Ma già che abbiamo richiamato l’attenzione sul Rubens internazionale, conviene ricordare che a Roma egli ricevette la commissione per la decorazione dell’abside di Santa Maria in Vallicella, opera finita poi al Museo di Grenoble, che riuniva in un unico dipinto cinque Santi e la Madonna.

Quando Rubens si accorse che la posizione del dipinto sull’altare attirava una luce eccessiva rendendolo poco leggibile, decise di ritirarlo e di sostituirlo con tre lavori realizzati su un supporto di ardesia, più adatta alle condizioni luminose della chiesa, creando così da capo la Madonna della Vallicella, San Gregorio Magno, Papia e Mauro, Santa Domitilla, Nereo e Achilleo. La tavola centrale, in particolare, è affollata come la precedente ma è più dinamica e luminosa, e presenta una composizione che sembra dilatarsi oltre i confini della cornice, anticipando soluzioni che saranno riprese dalle pitture successive. E come scrisse Giuliano Briganti “lo spazio sembra vibrare e dilatarsi per accogliere le gigantesche figure che lo occupano in tutti i sensi con l’eloquenza solenne del loro gestire e sfogarsi poi liberamente nella fuga prospettica della gloria angelica centrale ove i raggi della luce divina, che partono da un punto focale così alto e lontano da suggerire una profondità infinita, irrompono per i fessi delle nubi e tra i corpi degli angeli in controluce, disposti in una continuità vorticosa”. Ma più che la questione tecnica e compositiva a noi qui preme sottolineare la capacità di adattarsi al contesto e, se serve, quella di riprendere il discorso.

E, giusto per capirci e per ricollegarsi alla caratteristica precedente, è bene sottolineare che prima di arrivare a Roma e prendere tale matura decisione Rubens, nel maggio del Seicento, era partito per un viaggio in Italia che durò ben otto anni, visitando Venezia per studiare Tiziano, Veronese e Tintoretto, e Mantova, dove accettò l’incarico di pittore di corte che gli permise di arricchire la sua cultura figurativa con l’approfondimento delle opere dell’incredibile collezione ducale. Giunto a Roma, come un bravo alunno diligente, copiò moltissimi quadri, studiò Michelangelo e Raffaello, l’arte antica e quella contemporanea di Caravaggio, Carracci e Federico Barocci. Nel 1603 fu in missione per il duca di Mantova presso il re di Spagna, fece un breve soggiorno genovese e finì di nuovo a Madrid in compagnia del grande Diego spagnolo, tanto per chiudere il cerchio e continuare su un punto nuovo: far in modo di essere esclusivi e collezionati da persone influenti. Chardin, ad esempio, vantava tra i suoi numerosi acquirenti moltissimi monarchi, aristocratici, ministri e ambasciatori, al punto che il conte Carl Gustaf Tessin di Svezia ebbe a dire che le sue pitture erano acquistate dalla monarchia perché facevano inginocchiare i visitatori ancor prima.

Che altro? Essere innovativi come Fra’ Filippo Lippi che cambiò l’immagine devozionale di Maria sostituendo la foglia d’oro o la solita noiosa architettura a far da sfondo, con vari paesaggi atmosferici, di certo ben più piacevoli. Avere una forte personalità ed essere pure un po’ stravaganti, come per Salvator Rosa riportano le fonti. Che come scrive Luigi Salerno era “classico rispetto ai bamboccianti, bambocciante e pittore di genere rispetto ai classicisti”. Ed ebbe quel “connubio tra realismo e idealismo, fra genere e soggetto letterario, quella coscienza del genio artistico, quel sentimento romantico e quella speciale capacità emotiva, che la sua realtà non fu tanto idealizzata ma la sua idealità emotiva”. È sempre Salerno che scrive e che ci fa notare come il paesaggio alla Salvator Rosa divenne un vero e proprio genere. E verrebbe voglia di cambiar mestiere ma, anche se oggigiorno tira aria grama, è pur certo che nessuna regola va presa come assioma.

E ancora: essere geniale come Hans Memling che, in un dittico che sono tornato a rivedere, riflette la scena nell’armatura dove si compiace, con l’albagia di un supereroe. Del resto “il primo fondamento dell’essere apparecchiato in giuste occasioni a spendersi, è il molto apprezzarsi”, come ricorda un pensiero di Giacomo Leopardi. Proseguiamo.

Essere instancabili come Cy Twombly nel Ciclo delle Rose o in quello di Lepanto, che ancor più mi ha colpito, sempre a Monaco di Baviera, nella sala circolare di un museo fondamentale: il Brandhorst Museum. Si tratta di dodici dipinti creati per la Biennale di Venezia del 2001 che hanno come soggetto quella Battaglia di Lepanto che già Paolo Veronese nel 1572 aveva provato ad affrontare. Il ciclo è qualcosa di simile al lascito dell’artista in cui si condensano tutti i problemi importanti da Cy sistematicamente affrontati: la mitologia, il mar Mediterraneo, il cielo, il colore e la luce, e dal vivo fa veramente impressione.

Aumentiamo il ritmo, che anche la velocità conta. Conviene scegliere le parole giuste come Dürer nell’autoritratto, darsi da fare con chi conta come Tiziano con Carlo V, capire i meccanismi dell’economia, come fece il giovane Jeff Koons che prima di lavorare come artista fu addirittura un operatore di borsa a Wall Street. E torna utile anche accoppiarsi con la persona giusta, così si creano opere d’arte stando a letto, come fecero con il famoso Bed-in for Peace Yoko Ono e John Lennon. E anche se “non serve il compasso nell’occhio”, come diceva Michelangelo, “ma serve vedere istintivamente le proporzioni estetiche” non deve esserci posto per nessun tipo di discrasia: organizzazione, buon senso e ragione, sono parole d’ordine, e se si vuole essere il re della giungla non basta comportarsi da re, bisogna di fatto esserlo. E così giungiamo a conclusione: aver qualcosa da dire a tutti i costi, e dirlo bene. Fine della trasmissione. Oppure siate come siate, che a volte va bene anche non forzare. Ed è pur meglio un ristretto espresso amaro, che un dolce caffellatte annacquato. E buona estate artisti di tutto il mondo, anch’io presto parto per un viaggio.
PS: sapete dove riposano le ceneri di Cy Twombly? Proprio in Santa Maria in Vallicella a Roma.
Nicola Mafessoni è gallerista (Loom Gallery, Milano), curatore (Settantaventidue, Milano) e amante di libri (ben scritti). Convinto che l’arte sia sempre concettuale, tira le fila del suo studiare. E scrive per ricordarle. IG: nicolamafessoni