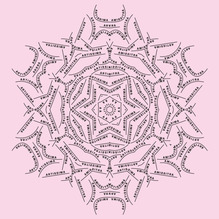C’è un luogo ai confini del mondo, dove una giovane manifestazione riesce a calarsi precisamente in un contesto site-specific ambientale, quello che l’arte contemporanea – ad ogni latitudine, molto spesso soltanto si sogna, invocandolo come un mantra: siamo ad Antofagasta, regione nel “Grande Nord” cileno, dove è in corso – fino al prossimo 14 settembre, la 12.ma edizione di Bienal SACO
Ideata nel 2004 come Corporación Cultural SACO, associazione per lo sviluppo di progetti artistici nella regione antofagastina, la manifestazione ha attuato come festival e si è trasformata in Biennale nelle ultime tre edizioni, mantenendo la direzione della fondatrice Dagmara Wiskyel, artista e curatrice polacca naturalizzata cilena che, ben cosciente delle difficoltà di portare l’arte contemporanea a queste latitudini, non ha abbassato l’asticella ma anzi, ha rafforzato relazioni e confronti tra la regione e il resto del mondo.
Un progetto complesso, come è complessa la geografia dove Bienal SACO opera: la più secca area desertica del mondo, in molte zone completamente sfruttata per l’estrazione di rame e litio, due eccellenze minerarie sulle quali il neoliberista sistema economico cileno ha puntato tutta la sua forza, attraendo da queste parti anche schiere di lavoratori da altre aree del Paese o da altri stati dell’America Latina, creando un panorama complesso di stratificazioni sociali, di disuguaglianze, di problematiche connesse anche ai temi della salute pubblica e della tutela di un ambiente che per alcuni, data la sua “scarsità” di vita è passibile del peggiore sfruttamento.
Proprio a partire da queste condizioni, Dagmara quest’anno ha scelto come titolo e tema della Biennale “Ecosistemi Oscuri”, Ecosistemas Obscuros in spagnolo: “Solo circa due decenni fa è emerso l’interesse per la “biosfera oscura”, i microrganismi del sottosuolo che sfidano ogni teoria sui limiti della vita. È qui che sono apparsi i poliextremofili, campioni di resistenza, che si trovano a proprio agio sulle pareti asettiche delle navicelle spaziali e sono pronti a viaggiare verso Marte, forse per un ipotetico incontro con i loro simili. Proprio loro, plasmati dalle condizioni estreme dello spazio, sono gli esseri che ci aspettiamo di trovare laggiù. Alcuni di questi organismi sopportano radiazioni cosmiche ai raggi X mille volte superiori a quelle letali per l’uomo e resistono a una pressione atmosferica seimila volte maggiore rispetto a quella della superficie terrestre. Altri digeriscono acidi o sospendono i processi metabolici per secoli, mantenendo intatta la struttura cellulare e la capacità di riprodursi non appena riattivano le funzioni vitali”, scrive la curatrice nella sua presentazione, citando Darwin e altri uomini di scienza che, solo fino a due secoli fa, erano erroneamente certi dei loro stessi sensi per determinare quello che poteva esistere o no, arrivando a classificare l’inospitale e meraviglioso deserto di Atacama, dove si colloca Antofagasta, tra gli ambienti terrestri dove non poteva esistere vita.
Eppure, in queste piccolo pezzo di Marte sul pianeta Terra, l’arte non solo è sbocciata come il deserto fiorito (fenomeno che accade nell’epoca delle precipitazioni un poco più a sud, nella regione di Copiapò, e che può rimanere inespresso per anni e anni, dipendendo appunto dai volumi delle piogge) ma continua a vivere in condizioni estreme, già che non esiste un museo, un centro culturale o una scuola d’arte o per curatori né tantomeno manifestazioni dedicate all’arte nell’arco di quasi 2500 chilometri, dalla costa di Valparaíso fino alla città peruviana di Arequipa.

E chi sostiene, allora, la Bienal SACO? Una parte dei fondi (circa 800mila dollari in totale, per ogni edizione, una cifra assolutamente inferiore rispetto a decine di altre colleghe nel mondo) arriva da Escondida BHP, società mineraria installata proprio nel deserto a due passi da Antofagasta, oltre che dal Ministero della Cultura cileno che, tra le altre cose, ha riconsegnato alla città La Molinera del Norte, grande struttura che ha servito la città come stabilimento per la molitura di grano e la produzione di farina e pane dal 1966 al 2016, quando è stata chiusa e abbandonata.
Oggi, ripulita e assolutamente perfetta secondo canoni che farebbero invidia a chiunque in Europa ricerchi le cosiddette location di “archeologia industriale”, La Molinera è il teatro della maggior parte degli interventi della Biennale SACO 1.2 che sono, a loro volta – e nemmeno a dirlo, site specific.
Prima di passare al resoconto della mostra, però, è doveroso ricordare che la sovvenzione a una attività culturale-critica da parte di una holding mineraria in una terra di miniere, non è certo una contraddizione in termini: quante realtà, nel mondo, vivono in un dualismo perenne tra produzione capitalistica (neoliberale) e tradizione? Quante città, nonostante inquinamento e qualità della vita non particolarmente sostenibile, scelgono le proprie aziende e le proprie atrocità ambientali? Siamo assuefatti, da un lato all’altro del globo, da ciò che da un lato distrugge l’esistenza originaria e, dall’altro, permette l’esistenza sul pianeta distopico che abitiamo, con buona pace delle ecosensibilità.

Ma ecco che proprio di sensibilità si compone “Ecosistemas Oscuros”: oltre cinquanta artisti, invitati dalla Turchia all’Italia, dal Brasile alla Corea, passando per Polonia, Argentina e ovviamente lo stesso Cile, compongono il parterre della Biennale SACO 2025, alcuni dei quali hanno passato ad Antofagasta veri e propri periodi di residenza, come nel caso dell’italiano Carlo De Meo e della curatrice Isabella Indolfi, che per SACO hanno progettato Ombre, opera monumentale realizzata nel cortile de La Molinera, in una collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di Santiago, la Biennale Seminaria e la stessa SACO, con il coordinamento di Marianna Fazzi. De Meo, giocando sull’assonanza tra la parola Hombre (uomo, in spagnolo) e l’italiana Ombre, ha creato una sorta di oasi di riflessione laddove i grandi silos marcavano il luogo con la loro immensa presenza: oggi segni circolari in un ambiente brullo, De Meo ha utilizzato queste forme per mettere a fuoco un mondo onirico composto di forme umane (la cui misura di partenza è il corpo dello stesso artista), in un groviglio di braccia, dita, mani, piedi realizzati con materiali di recupero, riparati da una serie di ombrelli neri, elemento ben contraddittorio nel deserto più arido del mondo, a loro volta creatori di un’ombra che si riconnette agli “Ecosistemi Oscuri” che possono metaforizzare anche – come scrivevamo poco sopra, problematiche sociali, politiche, ambientali.
A proposito di materiali riciclati o di recupero, SACO ha un’altra caratteristica da far impallidire l’ecosistema capitalista dell’arte contemporanea: tutte le opere, concretamente, si basano sulla circolarità, ovvero vengono realizzate ad Antofagasta e, al termine della manifestazione, nessuna cassa parte da qui per tornare nei vari studi, così come nessun dazio doganale è pagato per far arrivare le opere in mezzo al deserto di Atacama. Cosa significa? Che i materiali – legno, plastica, tessuti e chi più ne ha più ne metta, una volta terminata la funzione dell’opera vengo disassemblati e ritornano ad essere semplici componenti per il futuro: l’arte, insomma, è transitoria ed effimera, ed è per questo che chi partecipa alla Biennale SACO deve prevedere di “vivere” il luogo, immaginare cosa Antofagasta può offrire. Così, mentre il mondo dell’arte discute di sostenibilità, a SACO la praticano senza compromessi, senza ipocrisie.

Ancora nel cortile de La Molinera, altre due opere che con il tema del riuso hanno tutto a che vedere: Averío (Danno, in italiano), dell’artista ecuadoriano Darwin Guerrero, è un’installazione che prende spunto dai giochi-dondolo per i più piccoli che si trovavano nel Parque Brasil di Antofagasta: piccole altalene a forma di papera, disegnate dall’architetto Jorge Tarbuskovic, che sono state sostituite da una serie di strutture più grandi e più grossolane. L’installazione, in questo caso, attraverso una serie di papere “mutilate” senza possibilità di accogliere i più piccoli, diventano la risposta alla perdita e alla memoria non solo della città, ma anche del cortile spoglio e un po’ inquietante della vecchia Molinera. Un ready made realizzato artigianalmente con la manodopera locale con la quale SACO ha costruito un vero e proprio atelier di produzione circolare di cui si è servito anche l’artista-musicista turco Mustafa Avcı che, nel 2018, per il film Yuva, passato anche al Festival del Cinema di Venezia, ha vinto il Premio come Miglior Colonna Sonora al 30.mo Festival Internazionale del Cinema di Ankara.

A pochi passi dagli Averíos di Darwin, Mustafa monta una serie di strutture sonore utilizzando lampade prese esattamente durante le fasi di riqualificazione della Molinera, ritraendo per sottrazione il vento del deserto.
SACO, insomma, sembra davvero essere stata capace di cambiare le carte o, per meglio dire, di mostrare una grande coerenza con il proprio, complesso, contesto, non limitandosi ad essere “solamente” una Biennale che ogni due anni cala sulla città come un disco volante ma, soprattutto, promuovendo progetti e un’attività culturale costante, per esempio con il programma espositivo “Museo sin Museo”, che utilizza spazi normalmente destinati ad altri scopi come piattaforme espositive, di dialogo e incontro e “Escuela sin Escuela”, che dal 2012 aiuta lo sviluppo artistico nella regione, contribuendo alla crescita della scena creativa locale con workshop, laboratori, conferenze, arrivando ad invitare ad esporre nella propria Biennale, accanto ad artisti internazionali, i creativi locali, come è stato in questa edizione per cinque partecipanti della locale Escuelita de Collage, creata da Francisco Baeza. Un guanto di sfida per tutte quelle realtà che, dall’alto di grandi patrimoni e dal centro del mondo, promuovono irreali inclusioni.