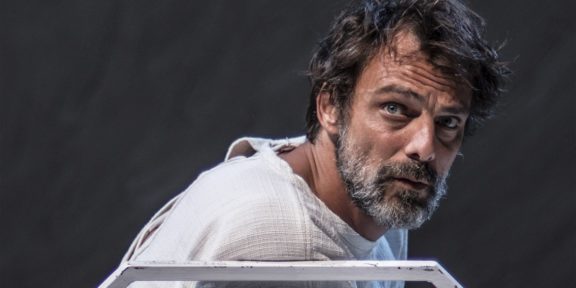Terzo capitolo di una trilogia dedicata alla figura del supereroe, Wonder Woman è l’unico a concentrarsi su un personaggio femminile
Andato in scena al Teatro Vascello di Roma fino al 19 gennaio, Wonder Woman, scritto da Antonio Latella e Federico Bellini e diretto dallo stesso Latella, è un lavoro corale, tagliente, apertamente militante. Terzo capitolo di una trilogia dedicata alla figura del supereroe, dopo I tre moschettieri e Zorro, è l’unico a concentrarsi su un personaggio femminile. In scena, le quattro giovanissime attrici – Maria Chiara Arrighini, Giulia Heathfield Di Renzi, Chiara Ferrara, Beatrice Verzotti – sono chiamate a sostenere un dispositivo teatrale esigente, rilanciando con forza la domanda che attraversa l’intero progetto: che cosa significa oggi essere un supereroe e perché continuiamo ad averne bisogno?
Latella costruisce una drammaturgia stratificata che mescola mitologia, cultura pop, atti processuali, richiami epici e linguaggi della piazza. Il fulcro è un fatto reale: un caso del 2015 ad Ancona, in cui una giovane peruviana, vittima di uno stupro di gruppo, viene di fatto trasformata in imputata dalla sentenza della Corte d’Appello. Le quattro giudici, tutte donne, assolsero infatti gli aggressori giudicando la ragazza “troppo mascolina” per risultare sessualmente appetibile. Fortunatamente, in Cassazione il giudizio è stato ribaltato condannando i ragazzi, ma la violenza perpetrata durante il processo, fredda e codificata, resta un marchio indelebile su istituzioni e cultura ancora profondamente intrise dal dominio sessista.
Il Teatro Vascello accoglie il pubblico con una scena spoglia, che mostra tutta la potenza di un dietro le quinte scarno e spietato. È una dichiarazione di intenti che diviene chiara quando le luci di sala, invece di spegnersi, molto lentamente si alzano sulla platea. Lasciandole ben accese per tutta la durata dello spettacolo, che è al tempo un processo e un rito al quale non è possibile sottrarsi, gli autori ci impediscono di sparire nel buio, di nasconderci, di assolverci, e ci impongono di guardare nell’abisso.
Le interpreti scendono tra il pubblico, con una marcia evidenziata dai tacchi delle loro scarpe rosse, e si allineano in proscenio. La parola si innesca rimpallando tra le quattro: “comincia tu”, “dillo tu”. È una staffetta, una testimonianza condivisa, una voce plurale che legge un documento giudiziario. Si apre una ricostruzione a perdifiato in quello che diviene un concerto per dolore e corpo, un vortice di frammenti e immagini di quella terribile notte: il branco, l’alcol, gli ordini, le frasi che restano incise, “non accavallare le gambe!”.
Quando i documenti si sbriciolano nella memoria e il racconto esce dall’aula del tribunale, incontra la lingua burocratica della polizia. Per la ragazza è tutto nuovo, non ha strumenti per proteggersi, idee per cavarsela, piani da seguire. Un’esperienza devastante per la singola donna che incontra la violenza strutturale, di Stato, che la circonda insinuando, deridendo, colpevolizzando. Ma allo stesso tempo è un film che abbiamo visto ripetersi infinite volte come un incubo ossessivo. “Perché se denuncio che mi hanno rubato la macchina mi credete, se dico che mi hanno stuprata no?”
La solitudine di quella notte emerge nel corpo femminile usato, gestito, amministrato da un sistema che lo confonde in un “Bla bla bla” che invade ogni cosa. Nella sua evaporazione referenziale, la ripetizione di quelle poche sillabe si distingue come uno dei momenti scenici più alti e travolgenti. Le quattro donne emettono ritmicamente quei suoni come resti inceneriti di un discorso fin troppo ripetuto. Una polvere che diventa una canzonetta e poi un gioco, un coro, un verso animale o un grido goliardico, un mormorio o un’invocazione rituale, una bestemmia o un urlo d’orrore. Prestando rabbia, voce e saliva a questa valanga, le attrici materializzano una violenza senza contenuti, nitida, lucida, riconoscibile. Ma è proprio incarnando coi loro corpi tesi parole che hanno perso senso, che le quattro mostrano l’importanza della loro presenza, rendendoci partecipi non più solo di un fatto, ma della storia di tutte.
Nel finale, quando il filo rosso del microfono traccia sul palco una linea di continuità e di divisione, inizia una vestizione simbolica. Protette dagli abiti di una tradizione combattiva, le quattro oltrepassano ogni immaginario confine si liberano dalle loro scarpette rosse, simbolo delle manifestazioni del 25 novembre, a tratti consolatorio e troppo spesso pacificante. In una danza collettiva che le mescola, raddoppia e unisce, le quattro scendono idealmente in piazza: urlano slogan, parole d’ordine e il canto cileno Un violador en tu camino, diventato inno globale contro la violenza di genere, esplode con tutta la sua potenza.
Nel nostro immaginario, Wonder Woman è un’icona pop, è l’eroina che abbiamo amato e imitato. Ma ora, grazie a un rito che affonda nel mito e ci parla come un post sui social, non agisce più da sola catturando più i cattivi con il suo lazo. È diventata una donna tra noi, una sorella tra tante che ci puntano addosso il dito, costringendoci a guardare, a restare, a prendere posizione. Il mantra “Spegni quella cazzo di tv” risuona ancora usciti dal teatro, come l’eco di un urlo necessario davanti agli orrori sempre più violenti che stanno travolgendo le nostre società.