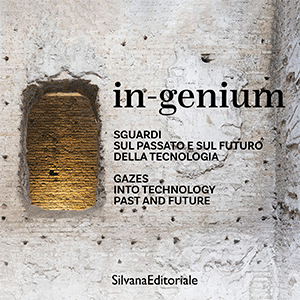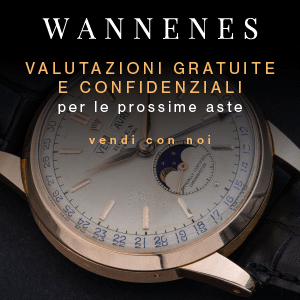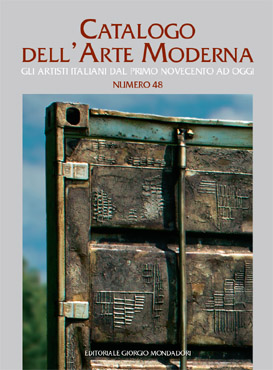Pittore dell’anima fra Avanguardia e tradizione toscana, la mostra curata da Rudy Chiappini, Dominique Vieville e Stefano Zuffi, ripercorre il rapporto di Modigliani con la ritrattistica. A Palazzo Ducale, fino al 16 luglio 2017.
Genova. Talento “maledetto” dedito all’alcool e alle donne, minato dalla tubercolosi che ne causerà la morte prematura a soli trentasette anni, il livornese Amedeo Modigliani (1884-1920) è riuscito a tradurre in pittura la spiritualità arcaica dell’essere umano, a utilizzare la fascinazione dell’avanguardia cubista per l’arte africana come mezzo espressivo per indagare radici che nell’Europa dell’ebbrezza positivista sembravano ormai smarrite. Al pari della narrativa di Cesare Pavese, anche la pittura di Modigliani è disperatamente concentrata sul recupero del Mito: ma mentre lo scrittore langarolo ne cercò i significati e il compiersi ineluttabile – fondamento di una società il cui ordine appariva irrimediabilmente minato dal “dèmone della modernità” e dalla violenza che aveva ormai avvelenata la politica -, il pittore livornese, più anziano di ventiquattro anni (e la cui scomparsa in giovane età gli impedì di assistere ai totalitarismi), vi estrapola l’essenza intima dell’individuo, quel carattere “soprannaturale” che l’umanità dei primordi ha per un attimo posseduto, libera da qualsiasi costrizione.
Modigliani assegnava all’arte lo scopo di “lottare contro ogni vincolo”: quelli estetici dell’accademismo, certo, ma anche quelli morali imposti dal conformismo. Osservando quei volti africani e levantini, dalla leggera sfasatura delle proporzioni – che, al pari dello strabismo di Venere, conferisce loro una bellezza senza tempo -, il pensiero corre a quei Miti inquietanti cantati in prosa poetica da Blaise Cendrars, il cui enigmatico silenzio affascina e respinge insieme. Pur lontano dalle agitazioni di piazza, Modigliani fu un uomo libero e anticonformista, nell’arte come nella vita.

La piccola ma significativa mostra di Palazzo Ducale, attraverso sessanta opere racconta il suo percorso pittorico, dagli esordi nella natia Livorno fino ai frenetici anni parigini. Incoraggiato dalla madre – Eugenia Garsin -, a coltivare l’innato talento per la pittura che dimostrò di possedere sin dall’infanzia, catturò l’attenzione di Giovanni Fattori, il quale notò subito le novità stilistiche che caratterizzavano le sue prove. Da Livorno si trasferì a Firenze dove frequentò la Scuola libero di Nudo, per passare nel 1902 all’Accademia di Belle Arti di Venezia, altra città di mare, e come Livorno sospesa fra Oriente e Occidente. Infine, l’avventura francese. Quando vi giunse nel 1906, Parigi era ancora il faro della cultura mondiale: a Montmartre gli ultimi impressionisti ancora in vita lavoravano fianco a fianco con i cubisti, mentre Proust, con la sua Recherche, era il cantore di un Ottocento corrotto, ma che il senso della memoria sapeva comunque addolcire. E ancora il teatro d’avanguardia ispirato al Modernismo e ai Fauves, con i Ballets Russes di Sergej Pavlovič Djagilev. Montmartre era il fulcro di una vita notturna che di lì a poco si sarebbe spostata nei dintorni di Montparnasse, su quel Carrefour Vavin che avrebbe attirati anche Gertrude Stein e i coniugi Fitzgerald. La Belle Époque rifulgeva ancora in tutto il suo splendore, anche se all’orizzonte si profilavano le crisi balcaniche che avrebbero accesa la miccia della Prima Guerra Mondiale, e la conferenza di Algeciras aveva contribuito a isolare vieppiù l’Impero Prussiano sullo scacchiere europeo, avallando l’influenza francese e spagnola sul Marocco. A ciò si aggiungeva il sempre più marcato antisemitismo che dall’affaire Dreyfus serpeggiava in Europa. Anni difficili, di angosce politiche e sociali, che la complessa, sensibile e raffinata personalità di Modigliani tentò di arginare rifugiandosi nella pittura, di cui si servì per indagare quell’essere umano che stava perdendo i suoi connotati più profondi.

Concentrandosi sui ritratti più intimi, la mostra permette di apprezzare il modo in cui Modigliani dipinse l’anima dei suoi soggetti, andando oltre le apparenze naturalistiche dei volti; volti caratterizzati da quegli occhi senza pupille, a simboleggiare lo sguardo interiore; gli uomini e le donne di Modigliani, infatti, guardano dentro di sé, novelli Tiresia apparentemente ciechi, in realtà assorti nel riandare con la memoria a un passato sanguigno ed eroico (simile a quello dei Dialoghi con Leucò).
Così come la spigolosa morbidezza dei nudi femminili non manca d’incantare ancora oggi; li avvolge un silenzio atavico, un’atmosfera calda e sensuale che però va oltre l’aspetto erotico; si tratta di Dee Madri sulle quali le luci di Parigi non lasciano tracce, staccate come sono dalla quotidianità e sospese su quegli sfondi scuri che sembrano quinte beckettiane, ma anche metafore inconsce di quell’allontanamento dalla realtà socio-politica dell’epoca, cui infatti Modigliani fu sempre lontano. E quella femminea carnalità sembra essere l’estremo rifugio dove lenire le angosce quotidiane, fisiche e morali, che affliggevano il pittore. C’è qui di il tentativo di riportare l’umanità all’“età del Mito”, delle certezze rassicuranti che si presentavano sottoforma dei cicli naturali, un po’ come il ritornare della luna e dei falò. Sul fondo della poetica pittorica di Modigliani si adagia il dolore per una deriva sociale ormai irreversibile. Struggente, a questo proposito, il Grande nudo disteso (Ritratto di Céline Howard), la cui posa sensuale riporta alla lezione di Tiziano mutuata da Goya e Manet. È lei la Venere del Novecento, vera nella carnalità come nell’anima.

Si tratta di una pittura estremamente fisica, plastica, al punto che sembra sul punto di abbandonare la bidimensionalità della tela per traslarsi nella tridimensionalità della scultura. Il tratto è essenziale, ispirato ai Primitivi toscani, ma aggiornato sulla scorta del Cubismo e della fascinazione per l’arte africana. Una ricerca estetica raffinata, estremamente personale, indice però di uno stato interiore assai tormentato. Per lenire l’angoscia, Modigliani fu un assiduo frequentatore della vita notturna di Parigi, in compagnia di molti colleghi, fra cui Pablo Picasso e Jean Cocteau, ma fu con il polacco Moïse Kisling (1891-1953) – anch’egli di origini ebraiche e inquilino del casamento di Montparnasse dove abitava il livornese -, che strinse un’amicizia particolarmente intensa. Cinque sue opere, oltre al ritratto che gli fece Modigliani e due opere in collaborazione, sono visibili in mostra, a testimoniare il sodalizio artistico che legò i due colleghi.
Minato da una grave malattia polmonare, che la vita sregolata ha contribuito ad acutizzare, Modigliani morì a Parigi il 22 gennaio 1920; a pronunciare l’elogio funebre, c’era appunto Kisling, consapevole di stare dando l’addio a un artista, ma soprattutto a un uomo.
Tutte le informazioni: www.palazzoducale.genova.it