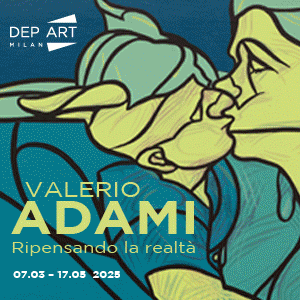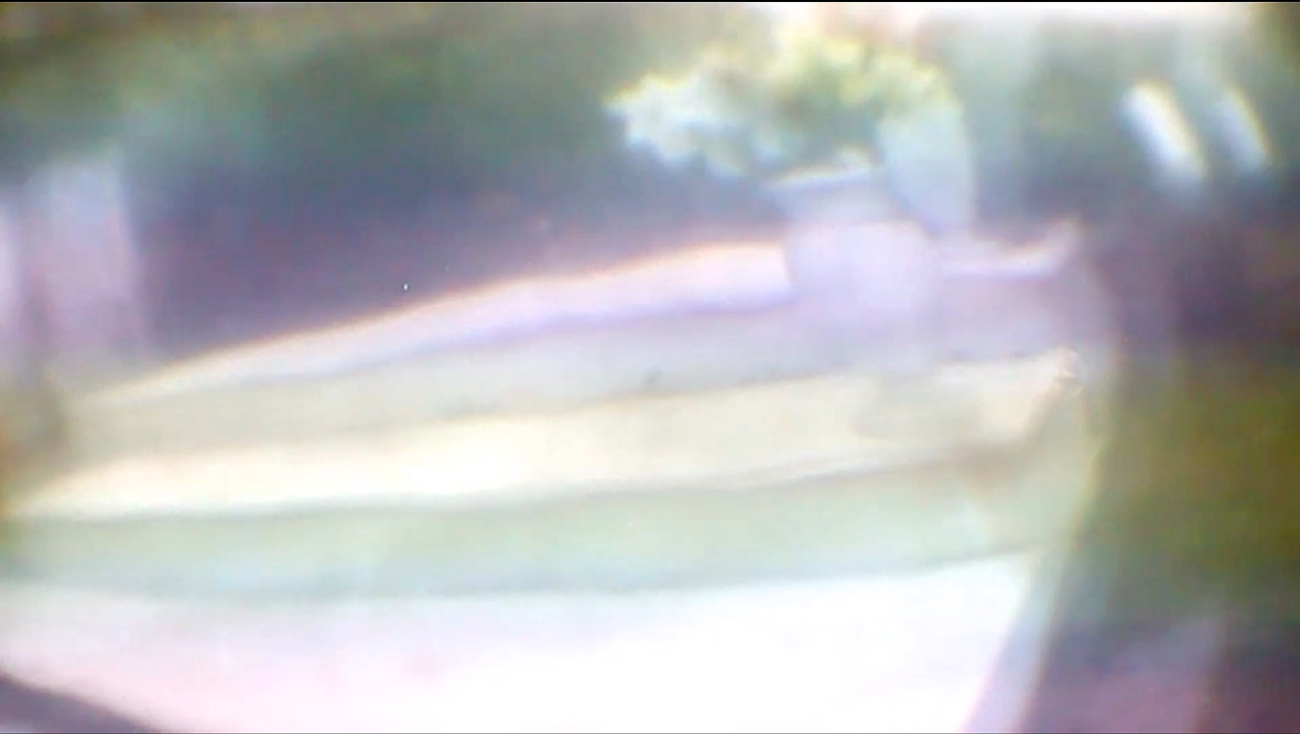Fra tradizioni sciamaniche millenarie e sensibilità per la salvaguardia dell’ambiente, l’arte contemporanea mongola costituisce una delle presenze più interessanti di questa Biennale. Padiglione Mongolia, presso l’Istituto Santa Maria della Pietà, Castello. mongolia-pavilion-venice-biennale.com
Venezia. Terra misteriosa e ancestrale, la Mongolia, per secoli tagliata fuori dall’immaginario occidentale, stretta fra il gigante sovietico e quello maoista, e approdata alla democrazia soltanto negli anni della perestrojka voluta da Gorbaciov. L’introduzione dell’economia capitalista, dopo un decennio di scompensi, sembra cominciare a portare i primi segni di cambiamento nel Paese, con un costante aumento del PIL, tuttavia “bruciato” per ripianare il debito pubblico. In ogni caso, la Mongolia sta vivendo una fase assai dinamica, aiutata anche dalla demografia: circa il 59% della popolazione ha un’età inferiore ai 30 anni. E il Padiglione conferma questi rapporti, con tre dei suoi cinque artisti nati negli anni Ottanta.

All’interno di una Biennale che celebra l’Arte Viva, gli artisti coordinati da Gantuya Badamgarav hanno lavorato riallacciandosi all’antichissima cultura sciamanica mongola, investendo queste radici di un potere salvifico e redentore delle disfunzioni della società contemporanea. L’arte celebra la vita rifacendosi alle sue manifestazioni più arcaiche, al suo stretto rapporto con la natura e le sue risorse, in modo da sensibilizzare la coscienza della società sulle problematiche ambientali, e non distruggere, in nome degli investimenti stranieri, il patrimonio ecologico. È tangibile l’impegno civile di questi artisti nel trovare un punto di equilibrio fra sviluppo economico e salvaguardia della natura, che, non dimentichiamo, ha un ruolo importantissimo nell’antica cultura sciamanica, i cui simboli e immagini sono il fil rouge del Padiglione: le opere possiedono una potenza espressiva che va al di là del significato visibile, affondano le radici in un passato lontano ma ancora vivo, e proiettano quest’aura anche verso l’osservatore.
Il titolo stesso Lost in Tngri (Persi in Paradiso), è sospeso fra il concetto spirituale di aldilà, e l’idea di un territorio incontaminato dove sia ancora possibile un’esistenza in armonia con se stessi, gli altri, e la natura. Su questa scia, si pone la suggestiva e scenografica istallazione di Chimeddorj Shagdarjav (1954), I am a bird (2016) che ha per soggetto una lunga fila di esemplari di un trampoliere molto comune in Mongolia; un’opera concepita dopo aver vissuto suo malgrado l’epoca delle ideologie, il cui clima rivive, anche sfumato, nell’impostazione: l’istallazione simboleggia la marcia dell’uomo verso un futuro migliore, ma a disorientare l’osservatore, il fatto che il trampoliere sia stato “ridisegnato” come fosse un “fucile a due zampe”; niente a che fare con l’angoscioso filmato di The Wall, con i martelli in parata nazista; Shagdarjav ha voluto simboleggiare con sottile ironia le “distrazioni” in cui l’uomo può incorrere durante il cammino, e che lo potano a dimenticare la missione del progresso civile in nome di altri interessi; ma poiché il fucile è distorto, non può sparare: un messaggio di speranza per un futuro di pace.

Anche Karma (2016), l’istallazione di Enkhtaivan Ochirbat (1977) segue un’ottica sociopolitica, ma con un approccio estetico molto più concettuale: è stata pensata come una sottile metafora della fragilità del potere, simboleggiato dalla sedia malferma al centro di un pavimento su cui è riprodotto il deserto. Il fatto che la seduta contenga un minuscolo acquario con alcuni pesci che vi nuotano, ne fa, pur in equilibrio precario, l’unico luogo accogliente in mezzo a una natura inospitale: metafora disillusa e amara di cosa sia realmente il potere, e come le sue logiche non sempre corrispondano agli interessi del popolo che dovrebbe invece rappresentare.
La sperimentazione del linguaggio artistico continua con Reexist (2017), una composizione musicale di Davaajargal Tsaschikher (1988) della durata di dieci minuti che assembla suoni della natura alla musica elettronica e alla musica tradizionale mongola. Alla base di quest’opera dall’afflato ancestrale, il riferimento all’antichissima cultura sciamanica che mette in comunicazione lo spazio fisico e lo spazio spirituale; se la morte è realtà accertata dall’esperienza e altrettanto inevitabile, non significa però che inevitabili siano le sue conseguenze, perché lo sciamanesimo suggerisce la possibilità di un “riassorbimento” dell’anima nel grande mosaico della natura, del vento che stormisce nel deserto o fra i pioppi. Da qui, il richiamo al titolo, dove l’aggettivo “persi” lo si può intendere nel senso di un abbandono spirituale.

La riflessione sul delicato equilibrio dell’ecosistema è al centro di Karma of Eating (2017) la complessa istallazione di Munkhbolor Ganbold (1983), che confronta l’antica cultura sciamanica con la situazione presente; la sapienza degli antenati era in grado di vivere grazie alle risorse della natura, ma nel pieno rispetto di esse, senza logiche di sfruttamento. Da una decina d’anni a questa parte, la millenaria pratica della pastorizia ha travalicati i limiti dell’equilibrio, le greggi si sono moltiplicate a ritmo vertiginoso, e il depauperamento dei pascoli sta provocando la desertificazione di aree sempre più vaste. Uno scenario di morte si stende su questa composita installazione; una desolazione che vuole essere d’incitamento al popolo e al governo mongolo, affinché cambino le politiche di utilizzo delle risorse naturali.
Allo stesso modo, il settore minerario è in continuo aumento, con l’apertura di nuove imprese cinesi, russe e canadesi. L’apertura di nuovi bacini causa profonde ferite al paesaggio e all’ecosistema; attraverso due video, Bolortuvshin Jargalsaikhan (1982) documenta questa devastazione ambientale. Evocativo il titolo del primo video, Raped, che rimanda alla violenza commessa sulla natura.
Da quanto osservato in questo Padiglione, l’arte mongola si presenta come attenta alle nuove tecniche espressive, con largo uso del video, ma quel che più conta, è il fatto che sia capace di racchiudere l’essenza della cultura ancestrale e sia permeata di coscienza civile e sensibilità verso le problematiche del Paese. Non si tratta di un’arte pensata per il mercato, ma per riflettere e scuotere le coscienze, che ha quindi mantenuto la sua vera missione. Per questa ragione, gli artisti mongoli sono fra quelli che meglio hanno saputo rispondere al significato della 57a Biennale, e agli occhi degli occidentali, poco abituati a frequentare questa lontana cultura, si presentano come una piacevole (ri)scoperta dell’arte intesa come strumento di progresso civile.

mongolia-pavilion-venice-biennale.com