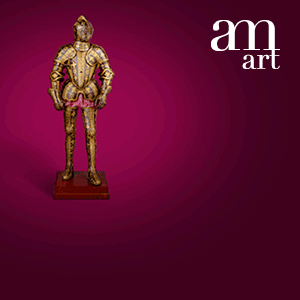Già nel titolo, l’istanza di una riflessione, già sul palco, l’immagine sfumata di un rito nuziale; si scruta, si osserva e si delinea, inevitabilmente, la necessità di operare una drastica scelta tra apparenza e sostanza. A farsene portavoce è Agostino Toti, anziano professore ante litteram che, sullo sfondo di una Sicilia di primo Novecento, cristallizzata nelle proprie consuetudini, pone contro tutti il suo credo filosofico e morale: “Altro è la professione, altro è l’uomo”.
Destrutturando, attraverso le sue azioni, il discutibile sistema di valori posto alla base della società e del vivere comune, si scaglia, con l’ingenuità inconsapevole di un bambino, verso la stasi dei ruoli sociali, che incatenano l’uomo alla sfera pubblica, annientando gli istinti e gli impulsi vitali.
“Io ho mia moglie quando c’è il sole”, dice riferendosi scherzosamente alla sua ombra. Individuo solo, animato da un alto valore etico e da saldo sentimento filantropico, decide allora di far del bene, prendendo in sposa Lillina, giovane per la quale nutre un affetto filiale e che beneficerà della sua pensione, una volta defunto. Ma la ragazza, intrattenendo già da tempo una relazione amorosa con Giacomino Delisi, ex alunno del professore, è rimasta incinta di quest’ultimo. Essere o apparire? A nulla valgono le rassicurazioni di Agostino sull’onestà e le buone intenzioni dell’amato e Lillina si ritrova presto ripudiata dalla sua tradizionale famiglia di origine. Una tradizione dettata dagli usi, dalla limitante definizione dell’opportuno, nettamente lontana e distante dal non conforme. Con cruda enfatizzazione, impartita dal crescendo di una lugubre marcia funerea, si prospetta il momento di alta tensione drammatica, in cui la vergogna della moglie del bidello, madre della ragazza, troverà una pallida consolazione nell’atto salvifico operato dal Toti, che la sposerà accettando come figlio anche lo stesso Giacomino.
Smorza i toni la comicità caricaturale delle serve Rosa e Filomena, non a caso interpretate da un uomo, avvolte in pesanti scialli neri, timorate di dio, intente unicamente nell’accendere e spegnere ceri, camminando a passi svelti e decisi nei vari ambienti della casa. Odore di incenso, aria rarefatta, pugni battenti sul petto, mani che sgranano rosari, come simboli inequivocabili di una tipica religiosità meridionale lacerante, più esibita che sentita. Maldicenze, coadiuvate dalla naturalezza di un nucleo famigliare sui generis e dallo scandalo di un apparente ménage à trois, vanno insinuandosi, nel tentativo di intaccare un’unione burocraticamente inaccettabile ma moralmente ineccepibile. Intanto, da una panchina trasfiguratasi in altare, prega e si dispera Rosaria, sorella di Giacomino, che, con la subdola complicità di un rappresentante ecclesiastico, desidera per lui il fidanzamento con una donna perbene e un futuro onorato. “E’ giusto di zucchero?”, domanda aspramente a padre Landolina che sorseggia del caffè, frase che, nella sua banalità quotidiana, rievoca invece un’aridità d’animo e di pensiero che nessuna zolletta riuscirà mai ad addolcire.
Angoli che non è concesso smussare, dogmi culturali che non si possono ammorbidire, concezioni claustrofobiche che vincolano l’uomo al volere di una maschera, all’idolatria della forma e che condurranno Giacomino, personaggio relegato nel corso della pièce ad una funzione quasi marginale, ad essere protagonista di un ultimo, amaro conflitto, perpetrato tra la sua coscienza e il sentire altrui. Un’opera che nasce all’insegna della lentezza della mente ma, soprattutto, del movimento, reso faticoso dall’imponderabile fardello di maschere incapaci di denudarsi; un’opera che non fa mistero della miscellanea fra sacro e profano ma, al contrario, la disvela svanendo, infine, in quella stessa sbiadita foschia con cui si era aperta.
INFO: www.diablogues.it