
Qualche giorno fa decido di mettere ordine nell’archivio con annessa bibliotecona e, nel tentativo di snellire il pondo gettando al macero qualche decina (e decina e decina) di riviste e pubblicazioni d’arte, m’imbatto in un numero singolare di ArtNews (“the most widely read art magazine in the world”…), una special issue del gennaio 1994 dedicata ai 200 più rilevanti collezionisti d’arte del mondo. Copertina marmorizzata di un bel verde malachite… molto Russia postcomunista.
Sospendo le “pulizie di primavera” e mi addentro in un buon 80% di pagine pubblicitarie e rari articoli patinatissimi, ma di ottimo livello.
Subito, uno scritto sub vocem “Vasari Diary” a titolo Mastering the Masters di Ginger Danto (corrispondente da Parigi per ArtNews, New York Times, International Herald Tribune, Village Voice e altro, oggi tornata a N.Y.) intorno ai festeggiamenti del Louvre per il suo bicentenario; il grande Museo rende omaggio ai suoi più illustri visitatori: gli artisti, in particolare quelli che si fecero sedurre dall’inarrivata ricchezza di opere d’arte di tutti i tempi e luoghi là collazionata. Da Turner a Picasso e la magnifica mostra Copiér-Créer che illustra la fama del Louvre attraverso le copie dei suoi quadri più famosi dal 1793 al 1993. Rifulge un’incredibile tela di Cézanne “La pietà di Tiziano” del 1864 che abbacina, totalizzandolo, il gesto pietoso della ricomposizione del corpo di Cristo ancora così trionfante nella mano del pittore cadorino.
Bei tempi! Che mostre… Certo – si dirà – è Parigi.
Ma anche in Italia, vent’anni fa, non si viaggiava così male, anche se erano gli ultimi fuochi; è l’oggi che, trascinandosi perpetuamente nelle fanghe della malapolitica culturale, sgomenta. Il pensiero va – per associazione di “genere” – a quella derelitta (perché davvero esigua) mostrina milanese su Cézanne che pare abbia sconvolto i botteghini e che da poche settimane si è conclusa e a quelle modeste invenzioni per impressionismi à gogo (e à-porter) che da qualche lustro imperversano fra i peana degli amministratori pubblici e delle famiglie da Gardaland, inesauste in terra veneta e recentemente anche ligure…
Procedo nell’opulenza di una visione che fu. Una lacrima albeggia sul ciglio.
Dal 13 gennaio al 19 febbraio, l’Associated American Artists (20West 57th Street, N.Y.) ospita l’opera grafica completa di Adolph Gottlieb. “Poco più in là”, sempre Gottlieb è celebrato con Pictography into Burst da Knoedler & Company. A Santa Monica, presso la Shoshona Wayne Gallery, furoreggia Bruce Nauman sino al 22 gennaio ed è ancora osanna per Nauman da Leo Castelli che con lui allestisce la mostra del 25° anniversario della galleria a 420West Broadway. Mentre da Pace Prints, Chuck Close (a cui sarà dedicato un pezzo in ArtNews a firma di Deidre Stein) delizia i palati con la raffinata esposizione di incisioni Alex/Reduction Block. La Pace Gallery, invece, ospita ben quattro strepitose rassegne da dicembre sino a febbraio: Dan Flavin, Robert Ryman, una pantagruelica Sculptors’ Maquettes e Henry Moore, giusto per far capire. Dalla sua il fibrillante Gagosian dall’headquarter di Madison Avenue offre una panoramica di “ultimi dipinti” di Arshile Gorky che – dalle poche immagini – pare sublime.
Partono i primi strilloni per Art Basel 1994 con un logo oggi impensabile: P(ART)Y.
Indi un interessante intervento (Who’s the Judge?) su un presunto falso Calder, Rio Nero del 1959, che un giudice decide esser buono. Articolista Robin Cembalest.
Il principale dealer di Calder, il newyorkese Klaus Perls, vendette l’opera nel 1967. Nel 1991 i quattro proprietari di un lavoro dal medesimo titolo, che aveva qualche inceppo nella fluidità dei movimenti, contattarono Perls, preoccupati per il loro investimento.
Questi, controllando la propria immagine d’archivio con quella presentata dai quattro mercanti, dichiarò che l’opera in loro possesso era un falso (“a copy”). Non così la pensava l’intermediario londinese che la vendette per 500.000 dollari (bei tempi!…un mobile assai meno complesso di questo, Yellow Eye, Red Dot è passato di mano lo scorso novembre da Sotheby’s N.Y per oltre un milione: oggi Rio Nero in asta sarebbe stimato non meno di due milioni – in galleria assai di più -, e sono buona), né l’ex proprietaria di Washington che l’aveva ereditata dal padre (il quale a propria volta la acquistò da Perls). A seguito della catastrofica sentenza, i quattro chiesero di essere risarciti, senza successo. Da qui il complicato seguito giudiziario avviato per frode contro il mediatore britannico.
Il giudice chiamato a dirimere la vicenda dichiara che, stanti le prove circostanziali occorse e i pareri di altri esperti, non v’era motivo di non supporre che quell’opera fosse proprio il Rio Nero originario. A nulla valgono le proteste dell’avvocato dei quattro proprietari per cui “il giudice non tiene conto dell’enorme influenza di Perls nel mercato dell’arte tale per cui, se questi afferma che quel Calder è falso, ha ragione anche se sta sbagliando” e quindi quell’opera (originale o copia che sia) non è più vendibile. Il giudizio procederà con un appello degli attori che non avrà esito per loro positivo, come apprendo poi dal sito dell’International Foundation for Art Research (IFAR).
Il commento finale di questo breve excursus giudiziario è di uno dei protagonisti: “La giurisprudenza anglosassone si fonda sull’assunzione di prove certe, ma le opinioni intorno all’autenticità di un’opera d’arte sono questioni che investono la sfera del giudizio personale”.
Sagge parole. Chissà se questo genere di argomenti ha mai sfiorato i nostri maggiorenti accademici o ministeriali al momento di investire oltre tre milioni di euro pubblici (grazie al cielo, non interamente versati) per un’operetta da sì e no cinquantamila, quel piccolo cristo devozionale in legno di tiglio malamente quanto velocemente attribuito a Michelangelo che ora sosta in attesa di giudizio nelle catacombe del Polo Museale Fiorentino. La Corte dei Conti sta per arrivare a un impietoso redde rationem. Ma, c’è da scommetterci, i “convenuti” non perderanno né faccia né valsente per risarcire, oltre l’onore patrio, le casse della Cultura impoverite non soltanto dalle mannaie tremontiane. Intanto, da due anni, il cristino che suscitò per qualche mese lo scalpore e il delirio delle folle (oltre che l’apprezzamento incolpevole – perché diede all’operazione ancora maggior lustro mediatico – del Presidente Napolitano e del Papa), il cristino, insomma, non è più esposto, dopo gli allori planetari, neppure in una bacheca di risulta. Ed è pur vestigia (di bottega) del primo Cinquecento fiorentino. Anche se fosse arte minore, è forse storia minore?
Pace.

Procedo nella selva di réclames che – ohibò – trattano perlopiù di pittura e di figurazione. Altro che America minimalista. Sembra andare per la maggiore una tendenza post-pop/post-surrealism/vetero-expressionist con esempi non tutti pessimi, ma quasi, come Debra Kelly, Don Heddy, George Fischer, James Guçwa, Jean-Claude Gaugy, Armando Morales, Silvio Dela Cruz, Leonardo de Valenzuela, il dolente Javier Marin e Juan Kelly (tonnellate di arte messicana e ispano-americana con Art Miami in corso; Juan Kelly dipinge mucche in improbabili tableaux vivants con meloni, angurie e varia frutta esotica…).
L’astrazione (per dire) è bandita.

Ed ecco l’arguta presentazione dell’attrice teatrale Jane Alexander che poco tempo prima di questa issue è stata insignita del prestigioso incarico di Direttore del National Endowment for the Arts, l’agenzia federale indipendente di supporto alle arti e agli artisti. Lo scritto è ancora dell’ottima Cembalest, oggi Executive editor della rivista, penna di punta dell’art scene in particolare newyorkese (assomiglia a un’Angela Vettese con acconciatura e outfit più glamorous).
Inoltrandosi nell’analisi di come l’Alexander sia potuta arrivare a tale vetta, con antagoniste come Lauren Bacall sostenuta da Ted Kennedy e la potente Deborah Sale che coprì la direzione del Federal Council on the Arts and Humanities sotto la presidenza Carter, Cembalest giunge alla conclusione che l’appoggio dichiarato di Hillary Rodham Clinton non poté essere sufficiente. L’esame è indicativo delle politiche culturali statunitensi e offre un panorama interessante delle tensioni fra destra e sinistra anche in merito di arti e propri rappresentanti, tutto costruito a colpi di fioretto intorno a ciò che per gli americani (tradizionalisti anche quando progressisti) è un personaggio pubblico nazionale e a come deve essere percepita la sua immagine. Le questioni dell’arte, qui come altrove nel mondo, paiono secondarie.
Metà del pezzo è speso per questa disanima, l’altra metà verte sulle attività della Alexander e sulle sue preferenze culturali: non è cool e non le importa esserlo. Ama arte neo-espressionista e pittori e scultori californiani e del New-Mexico. Non sembra piacere alla créme newyorkese.
La provincia in rimonta (o la provincia è sempre in rimonta negli Stati Uniti)?
Intercetto la pubblicità dell’ennesima fiera d’arte in corso a gennaio a New York; questa al Puck Building in Lafayette Street a Houston: Outsider Art Fair. Art Brut: artisti autodidatti, visionari, intuitivi, fuori dagli schemi. Provvista di relativi talks sponsorizzati dal Museum of American Folk Art.
Con mio enorme piacere, vedo che questa fiera resiste e proprio quest’anno festeggiò il primo ventennale (costo del biglietto solo raddoppiato dal 1994, esemplare!).
L’Art Brut ha preso piede e cerca di conquistare i propri spazi.
Qui da noi, oggi, ne sta raccontando con un linguaggio sperimentale spiazzante ma suggestivo l’ottimo Davide W. Pairone.

M’infilo quindi in una succosa intervista a tale Fabian Marcaccio, artista argentino trentunenne dal faccino tenebroso e ammiccante, trasferitosi a New York dalla madrepatria. Particolare la foto di lui seduto languidamente intento nel suo studio, un loft mattoni-e-finestroni al nono piano in Chrystie Street a Manhattan, Lower East Side. Il critico Meyer Raphael Rubinstein (vigliacca se trovi un gentile nell’artbiz statunitense) analizza i teloni del sudamericano con molta indulgenza. C’è una commistione di arte gestuale ed espressionismo astratto di ritorno piuttosto convenzionale. Francamente non capisco perché concedere così tanto spazio a quello che pare un gregario nella compagine newyorkese dell’arte. Se si considera poi che questo è uno dei soli tre articoli che presentano l’opera di un artista contemporaneo – un secondo su Chuck Close (che tratta di una mostra) e il terzo su David Salle (piuttosto portato al gossip di genere) –, la questione merita attenzione.
Il seducente Marcaccio (che alcuni anni dopo sarà noto per la manipolazione poco ardita di frammenti digitali e per l’invenzione dei Paintants e dei Draftants, tecniche che mischiano generi e materiali) “esagera le possibilità dell’astrazione, lasciando che le sue tele letteralmente cadano in pezzi”. La tela è utilizzata nella sua forma più grezza (sacconi di juta a maglia molto larga, perlopiù commercial wall coverings) talché sia possibile stracciarla e intriderla di pennellate di pigmenti siliconici i quali hanno, a detta dell’artista, “un effetto contemporaneo” e rendono la superficie tridimensionale e martoriata. Alcune opere non sono male, ma nel complesso sembra davvero una pittura da salotti (meglio: salottoni).
Marcaccio assomma una serie di caratteristiche iconiche che stuzzicano il pubblico engagée statunitense, benché ciò non serva a spiegare questo agiografico focus. Nel 1986, a 22 anni, emigra da un’Argentina in cui da poco è ripristinata la democrazia (“la pittura mi salvò dalla depressione per la situazione politica in Patria”) e arriva a N.Y dove la festa è finita, l’AIDS detta le regole e l’East Village è storia passata.
Terminati i soldi di una borsa di studio, decide di rimanere trovando occupazione come operaio in imprese di demolizioni. Un lavoro che deve aver esercitato un certo fascino sulla sua produzione artistica. Si dice amante di Peter Halley e del neo-espressionismo italiano (?) e tedesco, influenzato più dall’arte europea che da quella d’origine e interessato all’arte anacronistica, ma non concettuale, quanto piuttosto alla pittura. I suoi quadri iniziano sempre con una larga pennellata (“spazzolata”, per la precisione), corposa e intuitiva, la sua firma: da lì tutta l’opera prende l’avvio e sta poi allo spettatore (“it’s up to you”) immaginare il senso del lavoro.
Le nebbie sembrano diradarsi. Intravvedo qualche spiegazione per questa intervista all’artista della porta accanto.
Dopo una serie di comparse in collettive di varia umanità, finalmente, nel 1992 Marcaccio prende il volo. Viene agganciato da nomi illustri quali Annina Nosei, John Good, Tony Shafrazi e partecipa alla rassegna “Slow Art” al P.S. 1. Nel 1993 iniziano anche le personali in Europa. Nel 1994 le sue quotazioni sono ancora contenute e vanno da 1.500 a 10.000 dollari.
I critici newyorkesi, attirati dalla novità e dal trend in ascesa della pittura gestuale (con un tocco di figurazione sarebbe meglio…) spendono per lui frasi criptiche ma di grande effetto. Barry Schwabsky afferma che l’opera di Marcaccio non è satirica o ironica (!), ma piuttosto “una commedia di sincerità iperbolica”. All’argentino questa insondabile opinione piace: la ritiene parte della “natura paradossale del suo lavoro”.
Basta. Ho capito. Se si legge bene la rivista – con l’occhio postumo – si capisce dove ArtNews vuole parare nel gennaio 1994 e dove in realtà sottilmente conduce il lettore.
C’è da trovare uno sbocco al minimalismo che imperò nei decenni precedenti all’ultimo del secolo. La pittura e i giovani pittori “fanno per noi”. E sono una potente panacea allo sconforto in cui “i” Koons e i loro sistemi di industria dell’arte cominciano già a gettare il pubblico della tradizione.
In Italia si segue la medesima traccia, lanciando un caso in realtà inesistente: noi non abbiamo attraversato una così stretta colonizzazione dell’arte concettuale, anche se i nostri migliori artisti degli anni ’60 e ’70 prendono le mosse dallo Spazialismo e procedono con Azimuth verso l’azzeramento delle prospettive poetiche precedenti, mentre il Pop non fa particolare scuola. Del resto, e non a caso, Gnoli emigra in fretta. Secondo me, tutta la nostra ostentata contrapposizione fra pittura e media concettuali (questione che si è trascinata almeno sino a metà degli anni ’90 del secolo scorso, e per alcuni anche in seguito) è un po’ una bufala, ma con una simile affermazione mi si smontano le ragioni costitutive della Transavanguardia, il che non può essere, accidenti…
Comunque sia, benché il nostro giovane di belle speranze abbia continuato nella sua carriera americana a sondare le prerogative dei siliconi e delle telone a maglia larga, non pare abbia però sfondato come le premesse sembravano adombrare. Una sua (bella, per la verità) “spazzolata” del 1993 (The Revolution is your uncle, cm. 87×107) ha fermato il martelletto a 6.250 euro (ca. 8.500 dollari) in un’asta di Christie’s ad Amsterdam nel 2010. Non è cosa insolita tradire le aspettative, non tutti raggiungono i vertici, soprattutto nella Grande Mela. Forse Marcaccio non era così maudit: sposò un’amica argentina di gioventù, Gaia Solomonoff – architetto con un suo studio oggi avviatissimo al 530 West 25th Street – a cui ha l’ardire di rimanere fedele da allora.
O forse, in realtà, la sua pittura è più ironica che sincera. Chissà…
Mi vengono in mente decine di paragoni nostrani, ma preferisco soprassedere.
Dribblo l’intervista all’avvocato Eugene Stevens, uno dei maggiori collezionisti di arte contemporanea dello Stato dell’Ohio, per pura invidia. La sua casa strepitosa è, nel tempo, trasformata in piccolo (si fa per dire) museo d’arte alle porte di Cleveland nel sobborgo di Pepper Pike. Mi scivola l’occhio solo sui “nomi”: Anthony Caro, Joel Shapiro, David Salle, Anselm Kiefer, Eric Fischl, Susan Rothenberg (acquistata da Sperone Westwater), Sigmar Polke, Francesco Clemente. La galleria è meta di continuo pellegrinaggio di mercanti, studiosi, direttori museali e esperti d’arte. Il paròn de casa posa raggiante davanti a una rastrelliera di vini pregiati.
Supero altre pubblicità di due fiere d’arte newyorkesi a breve; nella selva di gallerie colgo una rassegna su Manzù a Montreal presso la Dominion Gallery, e giungo finalmente al pezzo centrale di Artnews di Godfrey Barker (editorialista del Daily Telegraph e corrispondente da Londra per ArtNews) Wiser and Better, panoramica sul mercato dell’anno precedente e indagine sulle prospettive per quello appena iniziato.

E’ bene riportare il senso dell’articolo per le evidenti affinità con il presente: prima fra tutte quella dovuta allo smarrimento generale in un momento (ora come allora) di trepidazione per la ripresa economica che stenta ad arrivare dopo un periodo prolungato di crisi, benché allora meno grave di quella odierna. Dall’altra parte sembra, il 1994, un anno “profetico” per il mercato dell’arte – ancora privo dei protagonisti dei cosiddetti Paesi emergenti del III millennio – e decisivo per la definizione dei nuovi assetti collezionistici. Interessante anche per comprendere la psicologia degli scambi (e della ripresa degli stessi) in momenti di angustie e di depressione imprenditoriale.
Barker apre subito con l’affermazione che il 1993 consegna un mercato più saggio e migliore (si direbbe sotto il profilo morale). Dopo il crollo economico e dei consumi degli ultimi tre anni, finalmente, i più colti e oculati collezionisti tornano a conquistare la ribalta delle sessioni d’asta anche se in maniera più composta e attenta alla privacy (presso tutte le maggiori case d’asta le battute più importanti si risolvono ormai al telefono) e con acquisti non di elevatissima portata economica. Cautela e anonimato sono le parole chiave.
Tutti i più nobili Auctioneers affermano (forse scaramanticamente) che, benché i fatturati siano ancora lontani rispetto agli anni d’oro (gli ‘80ies…), il parco dei clienti è sempre costante se non addirittura in aumento, così come in aumento sono le transazioni complessive: una pantera in agguato che sembra aspettare l’occasione più propizia per scattare sulla preda. Ora si pensa due volte prima di spendere milioni per opere mediocri, mentre la qualità diventa in assoluto il primo requisito anche per le fasce intermedie di acquisto.
Il tono da saggio articolista va in crescendo e lascia presto dietro sé qualche pudore azzardando un ottimismo da navigato connoisseur.
Il 1993 non è anno “da numeri”. Il top lot è costituito da una Natura Morta con Mele (ca. 1890-4) di Cézanne venduta da Sotheby’s New York durante il mese di Maggio per 28,6 milioni di dollari. Né si è ancora vista l’esplosione (annunciata l’anno precedente) del settore dell’arte contemporanea – che per noi del III millennio sarebbe in realtà post-war -, ma già David Hockney supera le aspettative e si sente che pubblico e clientela cominciano a prendere confidenza con un settore destinato a grandi sorprese.
Il mercato degli Impressionisti e dell’Arte Moderna è ancora quello trainante, soprattutto nella fascia più elevata delle proposte. Molti dealers sono assai soddisfatti del fenomeno di sano ridimensionamento degli scambi di opere di modesto valore artistico e storico che invece – garanti le firme prestigiose – venivano letteralmente bruciate nel decennio precedente. Anzi, si chiede persino maggior durezza: “il differenziale tra il meglio e il peggio di questo mercato non è ancora sufficiente” sibila un dealer londinese di caratura.

E’ comunque indicativo il fatto che il Cézanne da podio non doveva avere molte speranze di vendita secondo i mediatori, perché tentò invano durante tutto il 1992 di raccattare 25 milioni di dollari con un tour planetario promosso dal suo proprietario, l’armatore greco George Embiricos (mancato nel 2011 e dalla cui collezione provengono i “Giocatori di carte” di Cézanne venduti dagli eredi al sultano del Qatar per 158 milioni di sterline – ca. 250 mil. di dollari -, cifra che proiettò la tela verso la vetta dell’opera d’arte più pagata di tutti i tempi). Il tour “promozionale” non andò a buon fine: ciò impedì una stima superiore ai 10 milioni da parte della prudentissima Sotheby’s. E altrettanto inaspettata fu la vendita di un’opera di Matisse per 14,3 milioni di dollari (medesima asta), Fatma la Mulatresse (1912), forse la prova meno riuscita di tre di identico soggetto (uniche testimoni del passaggio matissiano in Marocco, dai più considerato un giro di boa nella vita dell’artista: un viaggio interiore), ma di importanza fondamentale per la storia dell’arte. La strenua volontà di possesso dimostrata in asta per questo lotto – insieme al positivo esito della vendita del Cézanne ed altri particolari lavori di Degas e ancora Matisse l’autunno successivo – confortano il mercato in merito alla ripresa della volontà di acquisire opere particolari e scelte. Il che è sempre buon segno.

Segno confermato dall’ottimo andamento (oltre le aspettative) dell’incanto Sotheby’s della collezione di 88 opere di Picasso (“minori”) di Stanley J. Seeger, anch’egli mancato nel 2011, tutte acquistate in asta fra il 1981 e il 1991. E tutte vendute ben oltre il prezzo di acquisto con un profitto complessivo di oltre 4 milioni di dollari. Asta gemellata dall’omologa del collezionista Kurt Seligmann di arte Dada e surrealista con battute più che raddoppianti la stima.
E mentre l’arte contemporanea, come si disse, doveva ancora raggiungere quel senso di “appartenenza” oggi globale per il collezionismo d’assalto, a Novembre 1993 uno Study for a portrait of Lucien Freud del 1964 di Bacon volava ben oltre il doppio della stima di partenza, aprendo così una timida porta verso i futuri fasti del genere, anche se per il momento limitati a artisti defunti e già ben acclimatati nella hall of fame della storia dell’arte.
Ma tutti gli agenti del mercato (dai collezionisti ai galleristi alle case d’asta) sono infinitamente grati che la piega “immorale” presa dall’arrembaggio senza quartiere degli anni ’80, allorquando si andava alle sessioni d’asta londinesi più cool come ad una vernice del Met, a una festa del Club 54 o a una sfilata della settimana della moda di Milano, sia questione morta e sepolta. Stephen Mazoh, mercante newyorkese, dirà: “E’ un mercato con discernimento e discrimine e assai più in salute quello che non comprende denaro irresponsabile”.

Denaro irresponsabile di tasca giapponese che rimarrà fuori dalla scena (e forse mai più vi rientrerà come negli anni ’80) per diversi anni ancora, e denaro irresponsabile di molti Paesi UE (dell’allora UE), che, 11 su 12, sono in forte recessione.
I compratori italiani – fortissimi nel settore dell’Antico su ogni piazza mondiale – sono assenti a causa della nuova situazione politica in Patria, annichiliti dagli scandali di Tangentopoli: l’articolista sostiene preferiscano non uscire alla ribalta delle cronache degli incanti patinati, non è davvero il momento più opportuno.
Fuori da queste considerazioni, a rimpinguare il novero un po’ dilavato della “buona” clientela, rimangono i compratori britannici (con la “testa di ponte” Regina Elisabetta che, tuttavia, pur investendo molta liquidità in cavalli, proprietà immobiliari e yachts, non è affatto interessata all’arte), i Latino Americani e i Cinesi che risentono di un’informazione lacunosa ma si attestano già come i più tenaci acquirenti di “pittura”.
Molti sono in attesa dell’evolversi rapido del mercato alla ricerca di una situazione più favorevole alla vendita, che si preannuncia vicina. Il che deve finalmente favorire anche tutti coloro che per acquistare arte agli scandalosi prezzi degli anni 1980-90 si indebitarono fortemente con le banche e ora (se non son già saltati) devono rifarsi dei propri costosissimi investimenti.
E’ anche vero che “ciò che era grande 60 anni fa, oggi non lo è più” e anche le piccole carte di Tiziano o Parmigianino che potevi acquistare a meno di 5000 dollari negli anni ’70 ora valgono 500 o 1000 volte tanto. Quindi c’è sempre speranza per tutti, a patto che la qualità sia rispettata.
Ed è ancora l’Impressionismo a trainare l’intero mercato dell’arte, mentre il settore contemporaneo sembra davvero prossimo a una svolta positiva come mai prima, dopo aver consolidato la base dello scambio. Ciò che importa è acquistare arte per possedere ciò che di meglio il mercato offre (asta Seeger). Come sentenzia un anonimo dealer: “Anyone who is still thinking of art as an investment would do better on the Cuban national lottery”. E il mercante Arij Gasiunasen che si aggiudica Le basier IV (1969) di Picasso per 650.000 dollari e che attribuisce il successo dell’asta Seeger all’alta qualità estetica dei lotti, aggiunge sornione: “People are tired of not spending money”.
I 200 nomi d’oro del collezionismo internazionale secondo ArtNews sono sciorinati in ordine alfabetico e presentano una buona percentuale di relativamente giovani compratori e appassionati d’arte contemporanea. Gli Stati Uniti la fanno da padroni (ma va’?), ma anche l’Italia può vantare nomi eccellenti (qualcuno oggi scomparso): Giovanni Agnelli, Angelo Baldessari, i marchesi Annibale e Marida Berlingieri, Attilio Codognato, Giorgio Franchetti, Giuliano Gori, Carlo Monzino, il conte Giuseppe Panza di Biumo. Otto in tutto.
Fra gli happy fews: Jean-Paul e Monique Barbier-Mueller, Claude Berri, Christiaan Braun, il sultano del Brunei, Edward Cox, Gilles e Marie-Françoise Fuchs, David Geffen, J. Paul Getty II, Dakis Joannou, Leonard e Ronald S. Lauder, sir Andrew Lloyd Webber, Steve Martin, Paul Mellon, François de Menil, David e Peggy Rockefeller, una serie di Rotschild, Charles Saatchi, il barone Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. I soliti noti.
La gran parte sono amministratori (o eredi, il che per gli statunitensi è quasi identica cosa) di imperi immobiliari, bancari o petroliferi con una quota significativa di professionisti di media, advertising e publishing.
Lo status quo è garantito da una fascia compatta di possidenti che non presentano alcun homo novus nelle proprie file e che ritengono il collezionismo questione legata all’investimento più che all’estro, anche in vista di cospicue donazioni pubbliche. Non compare Russo e pochissimi sono anche i collezionisti d’Estremo Oriente, mentre i petroldollari di quello Vicino sono ancora quasi certamente investiti in estates e Ferrari. 200 compattissimi che testimoniano la salute e la confidenza dell’Occidente nei confronti del proprio indistruttibile mercato dell’arte.
Un teatrino che nell’arco di pochi anni sarà scompigliato da cotali eventi economici e sociali che ribalteranno i poli della cultura imprenditoriale e sconvolgeranno quelli della finanza mondiale. E anche quelli della Cultura visiva tout-court se si pensa all’effetto dirompente dell’entrata in scena degli YBA e degli artisti cinesi della Stars Painters Society, appena inseritisi nell’agone.
Fa un certo effetto vedere come eravamo e come pensavamo forse non saremmo mai diventati. Mancano sette anni al crollo delle Torri Gemelle e alla guerra senza quartiere contro Bin Laden e Al Qa‘ida. E mancano molti anni al crollo delle speranze USA nella capacità di sostenere la propria cultura e il proprio stile di vita attraverso una sempre più aggressiva spregiudicatezza nelle speculazioni finanziarie. Ma mancano ancor più lune all’imprevedibile (ma è davvero così?) piega del mercato dell’arte dei nostri giorni di crisi orbe terraquea e dei suoi records senza apparente stanchezza, delle fortune cinesi costruite sull’arte del proprio Paese, finalmente, proprio nel momento in cui la Grande Muraglia sta perdendo un po’ di smalto dopo anni di corsa impazzita verso la vittoria. Ma i giochi, a ben vedere, sono sempre i soliti.
Quanti di questi 200 sono ancora collezionisti? Salvo i deceduti, tutti, credo, anche se non più in classifica, spodestati da imperi che nessuno poteva supporre si sarebbero creati in un battito di ciglia e che avrebbero scalzato dinastie ormai centenarie e patrimoni sedimentati.
L’arte è sempre un buon investimento se è di qualità e non tradisce allorquando ci sia necessità. Offre sempre la chance di rigenerare se stessa attraverso lo scambio e permette ai suoi conquistatori di vivere della luce riflessa del suo immarcescibile valore.
Ma, il valore dell’arte, qual è?














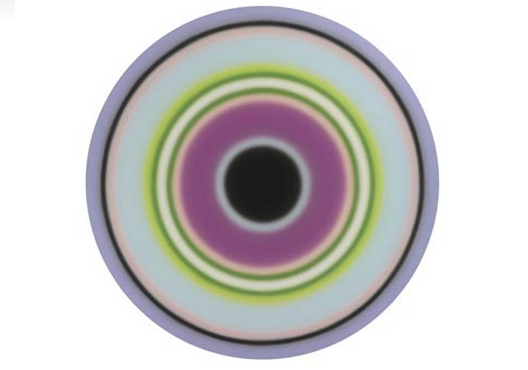



3 Commenti
Il suo valore e dato dall emozione che trasmette . Come ricevere una carezza , oppure donare amore , non conta il bacio in se ma solo la bellissima sensazione che senti nel darlo . L arte e passione , per la vita , per l amore e la gioia di conoscere, per la semplicice curiosità di guardare con gli occhi ma sentire con il cuore.
Grazie, Irish, che occhio! Nella stesura del pezzo ho accomunato i due miliardaroni (uniti dall’affaire della vendita degli eredi Embiricos dei “Giocatori” di Cézanne a 250 mil. di dollari), invertendo le didascalie e rimanendo per un po’ indecisa su chi inserire nel pezzo. Al momento di trasmetterlo, pensando che la morettona non si addicesse, in quella foggia chanellosa (né l’omone in doppiopetto-quattroante), a un sultanato del Qatar, ritenni il vero ritratto di Embiricos già inviato alla Redazione plausibile per un uomo di origini mediorientali. Quindi avevo pensato che l’arabo fosse il greco e viceversa. Invece mi hai beccato, accidenti, e te ne ringrazio. Vedi, a volte, i pregiudizi…
Complimenti!
bellissima la passeggiata nel tempo passato; però attenzione il gentil signore in doppio petto non è George Embiricos , ma Hamad bin Khalifa Al Thani (sultano del Qatar)