
Devo festeggiare l’arrivo di una nuova libreria che mi caverà d’impaccio nel settore, ampiamente sfrondato nei mesi scorsi, delle riviste di critica d’arte della mia bibliotecona. Mi ci vorranno due giorni di lavoro serrato per riorganizzare la montagna di materiale che ora finalmente diventerà più accessibile per la ricerca.
E, difatti, come sempre accade quando gusti con un piacere sottile e unico il momento dello sfoglio del libro che non vedi da tempo o forse non hai mai letto perché non era tuo e ti arriva dal passato, sono centinaia le suggestioni che allettano lo spirito e fanno scalpitare la polemica. La prima sensazione è che da una ventina d’anni a questa parte, nel mondo della critica d’arte italica, il problema dei problemi, la questione delle questioni (a che serve la critica nel III millennio?) non solo non abbia avuto soluzione o svolta, ma forse non abbia mai cercato una soluzione né una vera svolta.
Alle quali siamo, però, oggi, volenti o nolenti, obbligati.
Scelgo per ArtsLife la disanima di un articolo apparentemente senza spigoli a firma di Ela Caroli, mancata undici anni or sono, critica e giornalista de “L’Unità”, del “Corriere del Mezzogiorno” e – per quest’occasione di analisi – redattrice della rivista “Quadri & Sculture” (un nome, un programma), edita dal 1993 al 2001, direttore responsabile Duccio Trombadori, figlio del critico Antonello e nipote del pittore Francesco (quel Duccio per cui ebbi parole durissime proprio l’anno scorso, qui su ArtsLife, per la sua mediocre apparizione nel Padiglione Italia sgarbiano all’ultima Biennale veneziana, “raccomandato” da Giuliano Ferrara). L’edizione di cui tratterò è quella del mese di Dicembre 1993, anno 1, n. 6 e si ricollega esplicitamente alla prima nota già pubblicata in questa rubrica (The Way We Were – Wiser and Better, della fine dello scorso maggio).
Merita un appunto introduttivo, e non del tutto peregrino, il redazionale del suddetto Direttore Responsabile circa la necessità che la Biennale veneziana, con riferimento alle polemiche relative a quella appena chiusa (del 1993, condotta da un Achille Bonito Oliva in piena forma) che la vorrebbero d’impronta più internazionale e con un curatore “che parli inglese”, divenga invece dimostrazione ancor più evidente di un’italianità che subì un torto secco nella seconda metà del Novecento. Le non scorrette rivendicazioni di Trombadori intorno alla necessità di esaltare l’arte italiana cogliendo l’occasione della successiva edizione del Centenario (1995, che sarà diretta dal maître Jean Clair con il contributo di Maurizio Calvesi e Gillo Dorfles) cozzano con un dictat che più antistorico non si può: “in Italia, la Biennale ha da essere italiana”. Con ciò cancellando la prima virtus della Biennale, che acquista, anzi, valore (e sempre più con il tempo) per essere la vetrina, puranco “fieristica”, dell’arte di Paesi altrimenti ignota al pubblico.
Prima di rivendicare il protagonismo della “misura italiana” (come pretende Trombadori), bisognerebbe intendersi intorno a quale sia tale misura. E quali siano i suoi traduttori. ABO riuscì nell’intento di impostare, svecchiando, il percorso culturale tradizionale della kermesse, depistando il visitatore, scombinando le carte, aprendo a chi non aveva ancora avuto voce con la semplice ma astuta delocalizzazione. Facendo insomma della Biennale un “evento” più che una mostra. Questione da cui più nessuno saprà tornare indietro e dovrà – qui sì – misurarsi sempre in futuro.
Ma la misura italiana di Trombadori qual è? Sotto quale tetto si rifugia? Chi ne sarebbero i profeti e chi i cantori? Sembra un quesito passato di moda con il tempo (son quasi vent’anni…) eppure è straordinariamente attuale. Nel medesimo numero si trova un (in)aspettato puntello alla tesi trombadoriana volta a smascherare il grano dal loglio in un articolo di Angelica Caulì demolitore della Transavanguardia descritta come “finta pittura”, perfetta per una società opulenta che, pur di emergere anche attraverso i simboli dello status conquistato, si accontenta già di indossare finti Rolex e finti Chanel e quindi si acclimata anche a un succedaneo dell’arte, una “pittura in stile” garantita dal marchio DOC del movimento bonitoliviano. Movimento che, dopo la pubblicazione di un testo cardine del dicembre 1982 per Politi Editore, diventa addirittura internazionale, invade i mercati e coinvolge Stati Uniti, Francia, Belgio, Canada ma anche Israele e Argentina (ricordate il buon Fabian Marcaccio su Artnews e la sua passione per il neo-espressionismo italiano?) e soprattutto Germania (…), tutte nazioni in fregola per l’ “inattualità della pittura”.
Con buona pace di tradizioni consolidate (e indifferenti ai nostri lidi, in particolare la Germania) che della pittura non hanno mai fatto una questione di “merito” ma solo di opportunità storica.
E se si toglie la Transavanguardia, che la fa da padrona per tutti gli anni ’80, dopo il battesimo con l’articolo del suo mèntore su Flash Art nell’ottobre del 1979, e buona parte dei ’90 in Italia, chi ci resta? Quale “maniera italiana” rimane alla fine del II millennio?
Nella rivista, a parte una breve ed esplorativa incursione di un Vito Apuleo, incerto se glorificare o stigmatizzare gli intellettualismi di Tirelli (salvati in corner perché di elevata purezza formale), si grida al buon tempo andato, alla pittura (e scultura) che sa dire cose “nuove” all’Italia riferendosi a De Chirico con un “audacissimo” scritto di Renato Guttuso (probabilmente spiazzato dalle nuove correnti pittoriche e pronto a mettersi al riparo del “più classico di così si muore”). Il pictor optimus a confronto con l’ “artista commercialista”…
E così ci siamo giocati la possibilità (almeno con Quadri e Sculture) di costruire il nuovo: il rifugio nella tradizione (grandioso, straordinario, ineludibile cassetto di opportunità soprattutto per la cifra italiana) non era e non è sufficiente per evolvere in novus ciò che fu optimus. La polemica (tutt’altro che spenta e il terribile Padiglione Italia alla Biennale dello scorso anno né è un lampantissimo esempio) si è fermata alle teorie e ai principi propositivi. Se pur v’era qualche ragione nel pretendere un posto al sole, senza il passaggio all’atto pratico, senza la materia dell’arte, l’inno alla maniera italiana si è smorzato fra le indifferenti legioni di artisti e artistini nazionali che migrarono concettualmente (non sempre con sperimentazioni da deridere) verso lidi più internazionali e, in qualche caso, trovarono una fortuna che in Patria non avrebbero potuto certo concepire.
Nel frattempo, la critica – che avrebbe dovuto strutturare la “maniera”, come è giusto e opportuno che sia – si è data alla macchia, chi contraendosi nelle mestizie dell’età dell’oro che non ritorna, chi, la maggioranza, adeguandosi al mercato o all’opportunità del momento.
Colpa nostra, quindi. Di che ci si lamenta?
Ma mi accorgo che non ho ancora affrontato il tema di questa nota, e sto divagando. In apparenza.
A pagina 4, Ela Caroli condensa in non molte battute un’intervista ben educata al “ricciolo scuro” del giornalismo italiano, Enrico Mentana, fresco di nomina (autunno 1993) alla direzione del TG5, già palpitante di fervore per l’arrivo in Mediaset e per la contiguità con il Berlusconi delle meraviglie. Pronto a far (ri)parlare di sé più per il suo stile di anchor-man spigliato e persuasivo che, almeno per ora, per i contenuti del suo lavoro. Il titolo, un poco ambizioso, del pezzo “Mentana, L’Arte e Tangentopoli – Cultura, industria e pubblicità secondo il direttore del TG5”.
Dopo un ìlare incipit sul palazzetto neo-gotico della Capitale che ospita gli uffici del nuovo arrivato, aperti su un delizioso roof-garden, l’elegante “mitraglia” televisivo – già oggetto di invidie dei colleghi che si vedono in breve scalzati dal rampantismo più di facciata che di sostanza del sempre corretto giornalista – è interrogato amabilmente, ma tiene subito a precisare con (finta?) modestia che, come molti della sua generazione è di media cultura (artistica), formatasi perlopiù sui testi liceali arganiani “con qualche sottolineatura fatta in vista dell’interrogazione” e, proprio a voler eccedere, forse addirittura sulla storia sociale dell’arte di Hauser.
Mentana ostenta poca dimestichezza con le questioni dell’arte: qualche cenno ai battibecchi Zeri-Sgarbi (bei tempi… il pensiero torna alla poderosa, immensa figura dello straordinario studioso romano), un accenno alla (sciagurata) costituzione dei “giacimenti culturali”, l’arresto di Sisinni (chi si ricorda più dell’onnipotente direttore generale del Ministero dei Beni culturali che impazzò per lo Stivale, sornione, sin da quando era portaborse di Spadolini?).
Polemizza poi con la sua città natale, Milano, votata solo alle immagini culturali di vasta eco, assorbita com’è in quella che sembra essere l’unica risorsa spendibile a livello internazionale, la Scala, mentre languono le grandi collezioni pubbliche e latita il contributo fattivo del privato. Emblema dell’Italiano che conosce poco le proprie ricchezze artistiche ed è tuttavia sempre in prima fila alle “occasioni che contano”.
Ela Caroli ribatte che, a ben vedere, il telegiornale di Mentana non si occupa granché di questioni di cultura e arte. E qui si apre il risvolto forse più interessante dell’intervista. Cito letteralmente: “Credo che in TV la rappresentazione dell’arte oltre che inutile sia proprio dannosa. Cosa si può presentare in un minuto o poco più se non pura promozione pubblicitaria? […] in questa civiltà impazzita si ritiene che qualsiasi cosa sia assolutamente importante solo se passa in tv. Sai, un minuto televisivo corrisponde a dodici righe di testo scritto: non si può pensare che ad argomenti così seri, che meritano ben altre esposizioni e approfondimenti, ci pensi la televisione. Che possiamo fare se l’opinione pubblica è incolta – attenta, lo dico nel senso letterale del termine – se l’istruzione scolastica non ha provveduto a trasmetterle almeno la conoscenza dell’orizzonte artistico in cui siamo…”.
In queste brevi frasi intrise di buon senso (spicciolo, direi piuttosto) ecco tutta l’economia (intesa nel senso letterale – quello greco – del termine) di una generazione di informatori di “potere” che ha decretato con grande nonchalance, ammantata di pudicizia da matrona novella sposa, la superiorità presunta di un argomento sopra gli altri, talmente “superiore” da non poter essere divulgato con i mezzi volgari e involgarenti del(l’allora) tubo catodico. E così, con altrettanta giovialità, ne è stato del tutto estromesso, relegato a poche scolorite apparizioni, in genere notturne o in canali di quarto ascolto.
L’arte e la cultura come genere di nicchia.
Altro che divulgare, informare, educare…
Ela Caroli insiste, compìta: “Ma l’orizzonte […] dal dopoguerra in poi non è stato forse praticamente disegnato da Agnelli? Autostrade, automobili, cemento, asfalto […]; solo dopo le bombe all’Accademia dei Georgofili e al Velabro si è pensato di vietare il parcheggio sotto i monumenti, almeno quelli di eccezionale importanza storica”.
Mentana anguilleggia dando pienamente ragione alla collega e anzi constatando che l’Italia repubblicana (parliamo ancora della Prima Repubblica…) è l’unico “regime” (sic) che non lascerà monumenti significativi ai posteri e non presenta, in architettura così come in arte, uno stile unitario e riconoscibile.
E ciò – con scarto concettuale non del tutto comprensibile – è un peccato perché, secondo il riccioluto neo-direttore e secondo una corrente di pensiero che ancor oggi trova molti favori, l’arte, in Italia, è un vero business, a partire dalle possiblità che potrebbero offrire le scuole di restauro, le imprese di tutela e conservazione del patrimonio, ecc.
Ma nel 1993 è un business solo di facciata, lamenta il Nostro, tant’è che le aziende che sgomitavano per sponsorizzare appuntamenti artistici ora sono quasi tutte sotto inchiesta, falciate da Tangentopoli e quindi (e perché “quindi”?) la loro opera di mecenatismo era solo d’apparenza, d’immagine.
Per quale altro scopo le aziende, coinvolte in Tangentopoli o meno, dovrebbero sponsorizzare eventi culturali o restauri non è dato sapere. E francamente non si capisce perché dovrebbe essere considerato “di facciata” il mecenatismo di un’Impresa che si lega – che so – a un Museo o a un monumento. E’ più che evidente che trattasi del consueto ritorno d’immagine, senonché, meglio questo genere di “ritorno” che quello legato alle veline e ai calciatori, oso dire io. Ma forse sono troppo snobbish?
Ennesimo salto logico: “… Anche I papi hanno fatto i propri interessi, gli stessi grandi razziatori di opere d’arte, Napoleone o Hitler … mostravano almeno di possedere un gusto, qui c’è un decadimento generale, siamo in mano ai tombaroli o alla miriade di mercanti che vendono agli stranieri”.
Giuro che non ci capisco una benemerita acca, di quest’accrocchio un po’ confuso di idée sui concetti di sostegno privato al patrimonio pubblico, diffusione dell’arte, e cosa spetti a chi e perché…
Ma si capisce subito dopo, in un’illuminante passaggio tratto da un libriccino delle edizioni Sellerio, che non casualmente Mentana ha a portata di mano (e d’intervista), le memorie di Steno (Stefano Vanzina, popolarissimo sceneggiatore e regista). Siamo nell’Italia del ’44; a Palazzo Venezia, Roma liberata, si organizza alla bell’e meglio una mostra d’arte per le truppe americane che sbalordiranno di fronte ai capolavori ammonticchiati come perle di un baule di pirati: La Flagellazione di Piero, La Fornarina di Raffaello, Lorenzo Lotto, Masaccio, Masolino, Tiziano, Antonello da Messina… Il top del top a disposizione dei liberatori.
“Guarda un po’ che razza di mostre si facevano a quel tempo!”
Questo è, infine, il messaggio. L’Italia dell’arte è il Passato: meraviglioso, straordinario, irripetibile, irraggiungibile, iconico, senza ritorno, senza possibilità di evoluzione. L’arte italiana sembra essere nell’immaginario che più collettivo non si può di uno fra coloro che reggeranno le sorti dell’informazione pubblica (“generalista” o meno) congelata ai capolavori dei Grandi, anzi ai soli nomi dei Grandi. Che vanno (giustamente) omaggiati e riveriti, ma per cui ogni confronto con il presente è perso in partenza.
Mentana, di cultura media (appassionato amante di Caravaggio, anch’esso colto nella sua temperie più modernista della facies rivoluzionaria che mischiò formalmente sacro al profano e un mito personale crescente che sbaraglia ogni critica), è il vessillifero di quello che ora vediamo essere alla radice della nostra latitante cultura contemporanea, l’incapacità della nostra civiltà artistica di evolversi ancor più che in passato, dove almeno la querelle fra antichi e moderni riproponeva sempre nuovi approdi, alla fine. Qui la querelle è definitivamente estromessa, defunta.
Siamo costretti – noi modernissimi, più moderni del tempo che stiamo attraversando – a vedere con gli occhi della tradizione, dell’ossequio, dello stupore. Tutto legittimo e financo doveroso; ma tragicamente disastroso se si pensa all’occasione perduta di una nuova arte, di una nuova “maniera italiana”, che, privata ormai della spinta della divulgazione canonica (quella scolastica), già in partenza di quella mediatica, è contestata senza offrire alternative da una critica d’arte che spegneva gli ultimi fuochi professionali con Celant e Bonito Oliva e accendeva le luci sulle starlettes televisive (di rincalzo) come Sgarbi, Caroli, Daverio, concedendo così all’arte e alla cultura una dimensione esclusivamente ludica o di passatempo marginale.
Non c’è tempo, in tv, per approfondire temi così importanti, come se trattare della possibile rinascita delle Brigate Rosse o della chiusura di una grande acciaieria – per non parlare degli scandali, qui in realtà appena accennati, di Tangentopoli di quegli stessi mesi del mite autunno romano trascorso in amabile conversazione sul roof-garden di un palazzetto neogotico – fosse invece indegno di approfondimento e opportuno per dodici righe di testo e un minuto di “comparsata”.
Questa è la cultura del disimpegno, abilmente velato da umile insipienza, che ha relegato l’arte a una questione di pochi eletti, anzi, per meglio dire, pochi tenaci, pochi meschini, pochi illusi che ancora i giovanotti di belle speranze e dal sorriso dolce potessero concedere un passaggio del loro prestigioso calendario informativo a questioni troppo alte per loro.
Talmente alte che, a forza di guardare verso il cielo, se n’è persa la traccia, come i palloncini dei bimbi alle sagre, sfuggiti fra le lacrime e la tranquillizzante litanìa del genitore, stanco del piagnisteo: “Buono, caro, se fai il bravo, forse te ne compro un altro…magari fra un po’”.











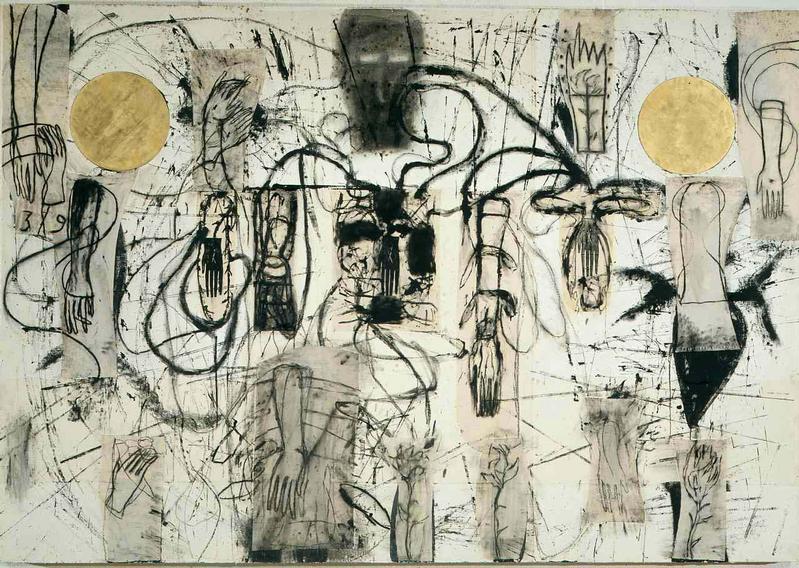
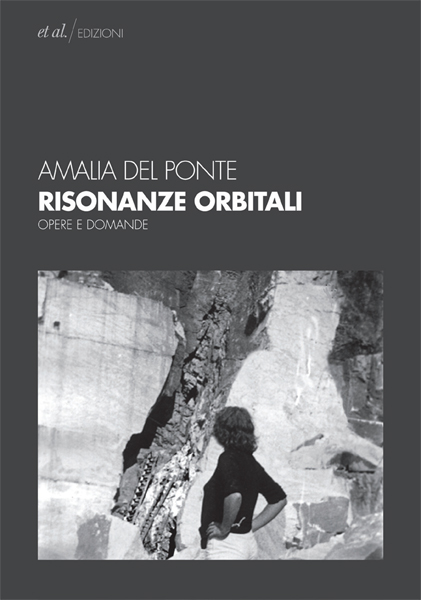




2 Commenti
Le generalizzazioni sono sempre dannose. “Credo che in TV la rappresentazione dell’arte oltre che inutile sia proprio dannosa. Cosa si può presentare in un minuto o poco più se non pura promozione pubblicitaria?”. Bene, questa è una stronzata pazzesca. I programmi di Daverio, per dirne una, non sono servizi da un minuto e ti danno la possibilità di vedere, per bene, luoghi o esposizioni che non potresti godere mai. E gli approfondimenti di Report, per dirne un’altra, sono molto più seri e completi di tante inchieste strapagate sui quotidiani, schiavi dell’edicola e del sensazionalismo cretino. Basta scegliere, come in tutto, non è il mezzo il problema. 🙂
Concordo con te, caro Giacomo (anche se non amo particolarmente il Daverio, mentre concedo che il format che presenta sia interessante – ma non l’ha inventato lui) in particolare relativamente a quanto affermi su Report come interessante (quanto sconvolgente) fu anche il reportage Rai di Iacona e la sua troupe qualche settimana fa sullo “stato (desolante) dell’arte”.
Tuttavia, qui, il nostro ex-ricciolone credo volesse intendere che le notizie culturali non sono da TG (ovvero da un minuto e via) il che è altrettanto assurdo (tu l’hai detto in modo più esplicito…) perché ciò esclude dalla quotidianità e dalla consuetudine un settore che dovrebbe essere parte integrante della vita di tutti noi, ogni giorno, colti, incolti, acculturati, incapaci di capire e non intenzionati a capire.
Rendere l’arte “quotidiana” (l’idea di una quotidianità della notizia culturale) anche attraverso i mezzi di informazione più popolari è solo un profitto per tutti, non un torto per l’arte.
Grazie del tuo commento.