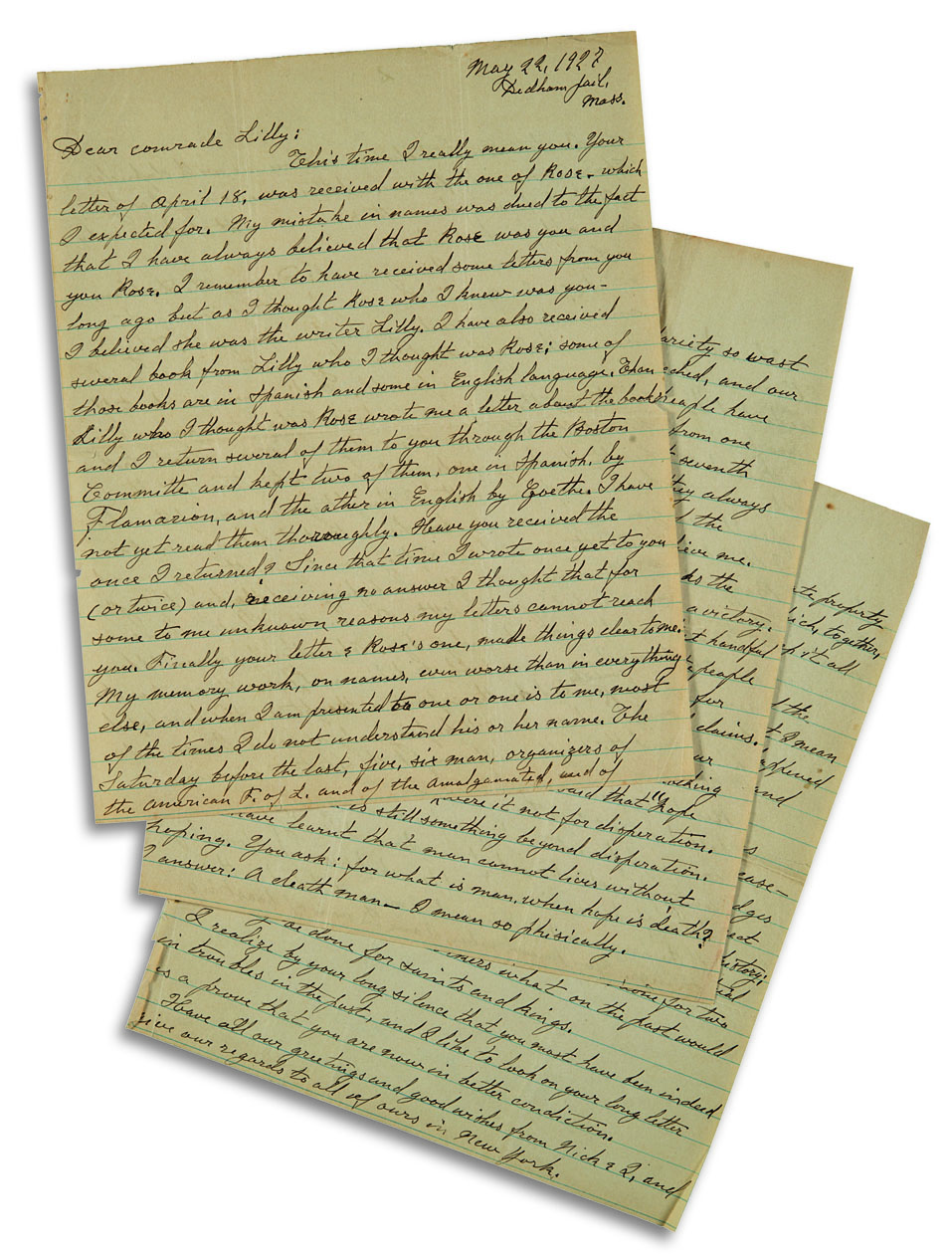“E ora l’uomo, dopo essere ritornato in sé, consideri ciò che egli è in paragone a ciò che esiste; si contempli come sperduto in questo remoto cantuccio della natura; e da questo piccolo carcere dove si trova rinchiuso, intendo l’universo, apprenda a stimare al giusto valore la terra, i regni, le città e se stesso. Che cos’è un uomo nell’infinito?”
B. Pascal, Pensieri
Uno sguardo rivolto in là. Sempre più in là.
Uomini e donne tratteggiati dai contorni anonimi e confondibili con quelli di migliaia d’altri. Friedrich, il grande pittore tedesco, invita ad immedesimarsi e a partecipare della vista di cui godono i suoi personaggi, invita a scrutare l’immensità dell’infinito che questi hanno dinnanzi. Paesaggi sublimi, privi di contorni ma densi di carica evocativa; tanto sublimi da riuscire a suscitare, in chi li osserva, una profonda inquietudine.

«Che cos’è, in fondo, l’uomo nella natura? Un nulla rispetto all’infinito, un tutto rispetto al nulla, un che di mezzo tra il tutto e il nulla»
B. Pascal, Pensieri
Contemplare il sublime. Contemplare noi stessi.
Blaise Pascal offre, tramite i suoi pensieri, un suggerimento circa la postura da mantenere dinnanzi alla vista di tale spettacolo infinito: «L’uomo non è che una canna, la più debole della natura; ma è una canna pensante. Non c’è bisogno che tutto l’universo s’armi per schiacciarlo: un vapore, una goccia d’acqua basta a ucciderlo. Ma, anche se l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe ancor più nobile di chi lo uccide, perché sa di morire e conosce la superiorità dell’universo su di lui; l’universo invece non ne sa niente».
Dinnanzi ad un universo tanto potente, l’uomo si accorge, nonostante la sua debolezza, di essere qualcosa di più rispetto ad esso; d’un tratto si è come vincolati a guardarsi in faccia: così piccoli ma così grandi al tempo stesso.

Come la canna di Pascal, così le figure di Friedrich: contemplando, dal loro minuto punto di vista, la vastità della natura, mantengono la schiena eretta e lo sguardo alto, come se dinnanzi ad essa si riconoscesse la propria nobiltà.
Non solo. Il nostro occhio ricade quasi sempre su di esse, come se si venisse richiamati ad un’esperienza di condivisione della medesima condizione. Contemplare il sublime. Contemplare se stessi.

«L’impossibilità di resistere alla potenza naturale ci fa conoscere la nostra debolezza in quanto esseri della natura, cioè la nostra debolezza fisica, ma ci scopre contemporaneamente una facoltà di giudicarci indipendenti dalla natura, ed una superiorità che abbiamo su di essa»
I. Kant, Critica del giudizio
Chi, se non Kant, è riuscito a comprendere con grande acume l’intimo legame tra la nostra piccolezza e l’immensità della natura, così come scorta da Friedrich e Pascal? Così fragili, così precari, ma irriducibili alla mera natura. Tuttavia, la grandezza e la superiorità dell’uomo non conducono al dominio indiscriminato della forze della natura, in un impiego devastante delle sue ricchezze. No, tutt’altro: non è un invito a diventarne padroni, ma a diventare padroni di noi stessi.

«In tal modo la natura [..] è giudicata sublime in quanto [..] incita quella forza che è in noi (e che non è nella natura) a considerare come insignificanti quelle cose che ci preoccupano (i beni, la salute e la vita). [..] La natura qui non è dunque chiamata sublime se non perché eleva l’immaginazione a rappresentare quei casi in cui l’animo può sentire la sublimità della propria destinazione, anche al di sopra della natura»
I. Kant, Critica del giudizio
Diventare padroni di sé stessi; compiere un viaggio all’interno della propria sublimità. Si scorge qui una destinazione, dice Kant.
Come si configura questa destinazione? Esiste o non esiste? Probabilmente qualsiasi risposta a tali domande deluderebbe ogni aspettativa. D’altro canto, però, vi è qualcosa di innegabile: la grandezza di questa domanda, che scuote non appena ci si rivolge verso la propria interiorità, riemergerà, e riemergerà con sempre maggiore forza, nonostante qualsiasi tentativo violento di metterla a tacere.

Un cenno, una voce esile ma potente al tempo stesso. Leopardi, tramite le sue mirabili poesie, scorge, in tutta la sua prepotenza, lo stravolgimento di tale domanda. Ascoltando i suoi versi, così lontani nel tempo ma così vicini al cuore, si avverte il tremante richiamo a lasciarsi travolgere dalla sublimità di un così grande pensiero…
Il pensiero dominante (Giacomo Leopardi)
Dolcissimo, possente
dominator di mia profonda mente;
terribile, ma caro dono del ciel; consorte
ai lúgubri miei giorni,
pensier che innanzi a me sì spesso torni.
Di tua natura arcana
chi non favella? Il suo poter fra noi
chi non sentì? Pur sempre
che in dir gli effetti suoi
le umane lingue il sentir propio sprona,
par novo ad ascoltar ciò ch’ei ragiona.
Come solinga è fatta
la mente mia d’allora
che tu quivi prendesti a far dimora!
Ratto d’intorno intorno al par del lampo
gli altri pensieri miei
tutti si dileguàr. Siccome torre
in solitario campo,
tu stai solo, gigante, in mezzo a lei.
Che divenute son, fuor di te solo,
tutte l’opre terrene,
tutta intera la vita al guardo mio!
Che intollerabil noia
gli ozi, i commerci usati,
e di vano piacer la vana spene,
allato a quella gioia,
gioia celeste che da te mi viene!
Come da’ nudi sassi
dello scabro Apennino
a un campo verde che lontan sorrida
volge gli occhi bramoso il pellegrino;
tal io dal secco ed aspro
mondano conversar vogliosamente,
quasi in lieto giardino, a te ritorno,
e ristora i miei sensi il tuo soggiorno.
Quasi incredibil parmi
che la vita infelice e il mondo sciocco
già per gran tempo assai
senza te sopportai;
quasi intender non posso
come d’altri desiri,
fuor ch’a te somiglianti, altri sospiri.
Giammai d’allor che in pria
questa vita che sia per prova intesi,
timor di morte non mi strinse il petto.
Oggi mi pare un gioco
quella che il mondo inetto,
talor lodando, ognora abborre e trema,
necessitade estrema;
e se periglio appar, con un sorriso
le sue minacce a contemplar m’affiso.
Sempre i codardi, e l’alme
ingenerose, abbiette
ebbi in dispregio. Or punge ogni atto indegno
subito i sensi miei;
move l’alma ogni esempio
dell’umana viltà subito a sdegno.
Di questa età superba,
che di vote speranze si nutrica,
vaga di ciance, e di virtù nemica;
stolta, che l’util chiede,
e inutile la vita
quindi più sempre divenir non vede;
maggior mi sento. A scherno
ho gli umani giudizi; e il vario volgo
a’ bei pensieri infesto,
e degno tuo disprezzator, calpesto.
A quello onde tu movi,
quale affetto non cede?
anzi qual altro affetto
se non quell’uno intra i mortali ha sede?
Avarizia, superbia, odio, disdegno,
studio d’onor, di regno,
che sono altro che voglie
al paragon di lui? Solo un affetto
vive tra noi: quest’uno,
prepotente signore,
dieder l’eterne leggi all’uman core.
Pregio non ha, non ha ragion la vita
se non per lui, per lui ch’all’uomo è tutto;
sola discolpa al fato,
che noi mortali in terra
pose a tanto patir senz’altro frutto;
solo per cui talvolta,
non alla gente stolta, al cor non vile
la vita della morte è più gentile.
Per còr le gioie tue, dolce pensiero,
provar gli umani affanni,
e sostener molt’anni
questa vita mortal, fu non indegno;
ed ancor tornerei,
così qual son de’ nostri mali esperto,
verso un tal segno a incominciare il corso:
che tra le sabbie e tra il vipereo morso,
giammai finor sì stanco
per lo mortal deserto
non venni a te, che queste nostre pene
vincer non mi paresse un tanto bene.
Che mondo mai, che nova
immensità, che paradiso è quello
là dove spesso il tuo stupendo incanto
parmi innalzar! dov’io,
sott’altra luce che l’usata errando,
il mio terreno stato
e tutto quanto il ver pongo in obblio!
Tali son, credo, i sogni
degl’immortali. Ahi finalmente un sogno
in molta parte onde s’abbella il vero
sei tu, dolce pensiero;
sogno e palese error. Ma di natura,
infra i leggiadri errori,
divina sei; perchè sì viva e forte,
che incontro al ver tenacemente dura,
e spesso al ver s’adegua,
nè si dilegua pria, che in grembo a morte.
E tu per certo, o mio pensier, tu solo
vitale ai giorni miei,
cagion diletta d’infiniti affanni,
meco sarai per morte a un tempo spento:
ch’a vivi segni dentro l’alma io sento
che in perpetuo signor dato mi sei.
Altri gentili inganni
soleami il vero aspetto
più sempre infievolir. Quanto più torno
a riveder colei
della qual teco ragionando io vivo,
cresce quel gran diletto,
cresce quel gran delirio, ond’io respiro.
Angelica beltade!
Parmi ogni più bel volto, ovunque io miro,
quasi una finta imago
il tuo volto imitar. Tu sola fonte
d’ogni altra leggiadria,
sola vera beltà parmi che sia.
Da che ti vidi pria,
di qual mia seria cura ultimo obbietto
non fosti tu? quanto del giorno è scorso,
ch’io di te non pensassi? ai sogni miei
la tua sovrana imago
quante volte mancò? Bella qual sogno,
angelica sembianza,
nella terrena stanza,
nell’alte vie dell’universo intero
che chiedo io mai, che spero
altro che gli occhi tuoi veder più vago?
altro più dolce aver che il tuo pensiero?