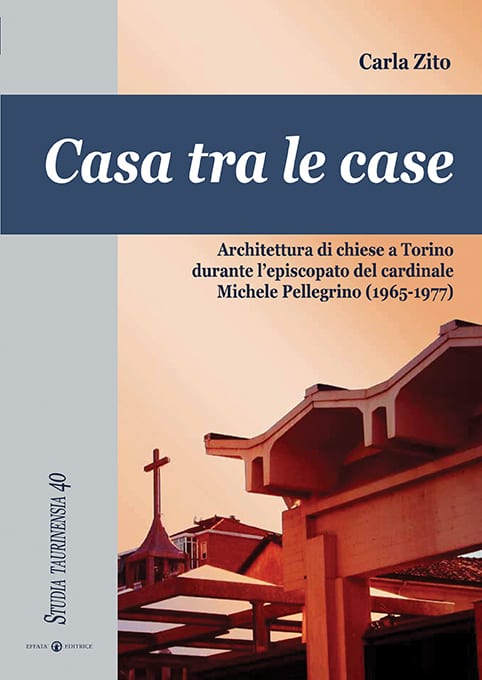Oggi non si scherza. L’ex enfant, toujour prodige, Massimilano Gioni non finisce di stupirci. Non perché ci meraviglia con visioni altre, ma piuttosto per via che insista nel proporci la sua ormai insopportabile correctness. Egli fa parte di quella, ahinoi, nutrita schiera di intellettuali animati da una profonda avversione per l’homo occidentalis la cui cultura è vista come un incessante susseguirsi di sopraffazioni e la cui sola esistenza rappresenta un’offesa per l’intero genere umano e per il pianeta stesso.
Già Allan Bloom, nel suo saggio del 1987, La chiusura della mente americana, aveva sottolineato i profondi scardinamenti prodotti dalla ventata di apparente liberazione e creatività dei fab sixteen. Ed ecco i perversi effetti: tutti i tic della cultura liberal, allora appannaggio degli studenti, li ritroviamo ora nei maîtres à penser.
La Terra Inquieta (Milano, La Triennale 28 aprile – 20 agosto 2017) è il titolo della mostra che non vuole solo essere una banale testimonianza della condizione dei migranti, ma si propone di analizzare il rapporto tra rappresentazione, identità e fotografia, ponendo l’attenzione sul ruolo dell’artista come testimone degli eventi storici e sulle modalità di raccontarli. Posto innanzi all’inflazione di immagini banali e superficiali propalate dai media, l’artista è chiamato a sviluppare un linguaggio che sia il risultato di incroci linguistici tra giornalismo e documentarismo, testimonianza autobiografica e letteraria.

Questo il postulato ideologico che informa l’esposizione e gli artisti chiamati a rappresentarla. Un’estetica tesa a superare i limiti della decostruzione postmoderna, orientata a praticare “una nuova politica della verità”, come enunciato da T.J. Demos nel suo testo in catalogo che accompagna la mostra. Ecco scodellato l’intento ideologico del progetto che non si accontenta banalmente di fare la ola allo spostamento selvaggio ed in controllato di popolazioni, ma si propone piuttosto come un radicale progetto di sovversione e minamento dall’interno di quel che resta della martoriata Europa.
Mentre si critica il capitalismo mondialista e liberista che teorizza la libera circolazione delle merci ma non delle persone e ci si esorta ad abbattere le frontiere, si radicalizza il portato critico alzando il tiro sul multiculturalismo -peraltro fallito- in quanto prodotto di una logica culturale del capitalismo multinazionale. Si prefigura per noi una disidentificazione nell’indistinto e, per contro, si teorizza una rivendicazione identitaria dei migranti invitandoli a riconsiderare le condizioni storiche dell’età delle dominazioni imperiali e ad un esame degli effetti alienanti della sua eredità…
Il manifesto perfetto per Jihadi John!

Ecco, se poi passiamo dai testi alle opere, queste sono in perfetta sintonia con i dettami critici, ergo la mostra è bella! Il solito sapiente e un po’ cinico mix di outsider ed insider tipo Francis Alÿs la cui suggestiva opera Don’t Cross The Bridge Before You Get To The River, copertina del catalogo, nasce da una collaborazione con i bambini che vivono sulla sponda africana dello stretto di Gibilterra che dista solo tredici chilometri dall’approdo europeo. Peccato però che da lì non passi nessuno! Preferiscono tutti la più confortevole via siciliana.
Kader Attia ci riserva invece la solita retorica mortuaria installativa con una serie di maglioni, scarpe, jeans, T-shirt sparsi sul pavimento a simboleggiare l’improvvisa scomparsa di chi li indossava. Che dire, poi, del lavoro di Khaled Jarrar alle prese con le brutali strutture difensive attraverso le quali i cittadini palestinesi devono districarsi: una documentazione fotografica della serie di canali sotterranei di cui si servono per entrare illegalmente a Gerusalemme. Canali che in realtà non vengono usati per andare a fare la spesa, ma piuttosto per perpetrare attentati terroristici ai danni della popolazione civile israeliana!
Ecco, in sintesi, “La nuova politica della verità.” Ecco, infine, il comune denominatore di tutte le opere esposte la cui peculiarità consiste principalmente nell’omettere qualsiasi riferimento ai massacri perpetrati in nome e per conto dell’Islam verso le stesse popolazioni nei luoghi di provenienza dei migranti e alla sistematica persecuzione dei cristiani. Ah, dimenticavo, naturalmente nessun accenno ai sanguinosi, perlopiù endogeni, attentati che martirizzano le nostre città ed i loro abitanti, che cominciano a vivere sotto assedio come manco Jena Plissken poteva presagire.

Un’ultima considerazione circa il bello ed esaustivo catalogo redatto, come a sottolinearne la transnazionalità, in inglese, relegando la traduzione in italiano in appendice e invertendo il naturale ordine dato che la mostra è prodotta sul bel suolo patrio. Questo è tutto, mi pare.
Inquieti saluti
L.d.R.