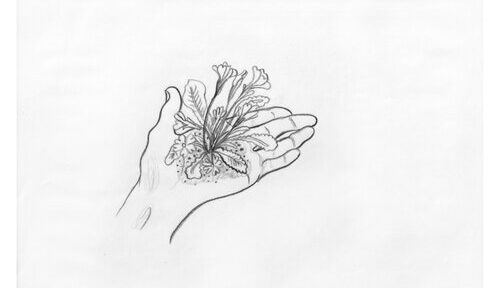L’Accademia di Belle Arti di Carrara ha conferito il titolo di Professore Accademico a Maurizio Cattelan e lui ha promesso di presentarsi con la fronte affittata. I soldi dello sponsor – Huawei -, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, serviranno a pagare venti borse di studio. Ha detto che in questo modo, vendendo la sua fronte a un marchio, potrà fare una buona azione: «E’ un cerchio che si chiude. Alla Biennale del ‘93 vendetti lo spazio di un billboard a un marchio di profumi. Oggi il billboard sono io. La dimostrazione vivente che l’arte può essere stupida, ma anche utile».
Per certi versi, questa non è nemmeno più una provocazione. Oggi, molte opere d’arte vengono utilizzate per pubblicizzare prodotti commerciali, e fanno da sfondo a computer e cellulari. In fondo, è nella logica del mercato che non guarda in faccia a niente e a nessuno. Ma il problema che si pone questa volta è un altro. E’ Cattelan l’opera d’arte? Davvero l’Ego generation si è talmente sviluppata che pensa di trasformare il proprio Ego nella stessa opera d’arte, quasi che l’artista del capitalismo avanzato, nell’evoluzione sfrenata del mercato iperliberista, fosse diventato esso stesso un prodotto? Oppure c’è ancora una differenza fra l’arte e chi la pensa e la crea, fra l’artista e l’uomo marketing?
Può essere che le provocazioni del mondo contemporanmeo abbiano finito per rendere futili molte di queste domande. Gunther Von Hagens, il dottor morte come l’hanno chiamato, si è servito persino di corpi veri di volontari che si sono donati alla scienza dopo morti, così da permettere di illustrare con chiarezza il corpo umano vivisezionato così come non era mai stato fatto. Perché dovremmo stupirci ancora di qualcosa? Però, questa volta le risposte non sono così scontate come può sembrare. Perché ne vale il significato stesso dell’arte.
Secondo Cattelan «è come innamorarsi. Nel momento in cui la vedi sai che la tua vita non sarà più la stessa: è quell’idea capace di colonizzarti la mente e di cui è impossibile liberarsi. L’esperienza di un’opera d’arte è qualcosa che ti segna per sempre, tanto quanto un colpo di fulmine per una persona che non conosci. L’arte come l’amore è un elemento che non si può replicare con l’intelligenza artificiale».
Questa definizione sembra quasi rendere corporea l’opera d’arte, qualcosa che vive e risponde alle tue esigenze terrene. C’è qualcosa di vero, perché nella storia l’arte è stata definita in tanti modi diversi e opposti, ma anche simili a questo, in epoche fra di loro lontane. Forse, la prima definizione che conosciamo è quella di Aristotele che identifica nell’arte «il principio di imitazione del mondo sensibile, bisogno naturale dell’uomo e comune a tutti i viventi». Per lui l’arte non è solamente fonte di piacere, ma strumento di conoscenza. Tanti secoli dopo, per Immanuel Kant, il bello artistico è ciò che permette di provare un piacere disinterssato e una felice comunione tra l’intelletto e l’immaginazione, portando a ritenere l’oggetto bello universale. Secondo Walter Benjamin, invece, l’arte è tale se possiede una collocazione spazio-temporale che le fa assumere il ruolo di una testimonianza storica. Lev Tolstoj diceva: «L’arte è una attività umana per cui una persona, servendosi di determinati segni esteriori, trasfonde consapevolmente i sentimenti da lei provati in altre persone, che a loro volta ne sono contagiati e li provano».
Sono tutte definizioni abbastanza rituali, concetti filosofici che cercano di spiegare la creazione e la fruizione dell’opera. Perché una cosa è indiscutibilmente accertata: muove da un sentimento e ne smuove altri. Ma secondo Plotino, che visse nel 200 dopo Cristo, l’opera d’arte non è nient’altro che l’idea, «l’immagine perfetta che l’artista ha in lui e sulla quale fonda il suo lavoro». La bellezza quindi risiederebbe nell’archetipo, non nella forma. Avrebbe potuto ancora affermare questo avendo visto Michelangelo o Caravaggio? Per lui l’opera d’arte era l’immagine interiore dell’artista, non la resa materiale. Se fosse così, c’è qualcosa di più interiore di noi stessi, di ciò che siamo e appariamo? Vittorio Sgarbi in fondo è andato oltre: «L’arte è la creazione dell’uomo in competizione con Dio. La capacità di creare vita con le immagini. David è una persona vivente».
Il grande artista crea la vita, dunque. Certo, se guardiamo all’Italia, il suo paesaggio e le sue città, il suo splendore infinito e dolente che le ruspe della civiltà moderna riescono appena a deturpare ma non a distruggere, vien da pensare davvero che milioni di artisti anonimi e non hanno inventato nei secoli qualcosa fuori dal tempo, disegnando vigne e monumenti e dolci salite coi cipressi fra ville antiche, qualcosa che non ha fine, perché questo forse è la bellezza. L’unica cosa che resiste oltre la nostra fine. L’Italia è un’opera d’arte. Ma può un uomo rappresentarla con se stesso? Può un artista rappresentare la sua opera con il suo corpo? O la mercificazione del corpo non è nient’altro che la deriva di una società che ha paura della bellezza, perché il prodotto dev’essere consumato, e la bellezza non si consuma. Picasso diceva: «L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità».
E’ un modo come un altro per raccontare una creazione, per tornare in fondo a quello che diceva Aristotele sulla fonte di piacere (la menzogna) e lo strumento di conoscenza (la verità). Se è così, il corpo di un artista non potrà mai essere un’opera d’arte. Potrà essere merce, immagine, scandalo, vita. Il corpo umano perde la sua bellezza, e non solo perché invecchia. La perde perché non ha la potenza di un’opera d’arte. Il capolavoro ha in sé l’eternità, oltre all’universalità, che è quello che nessuno di noi potrà mai possedere. Neanche Cattelan.