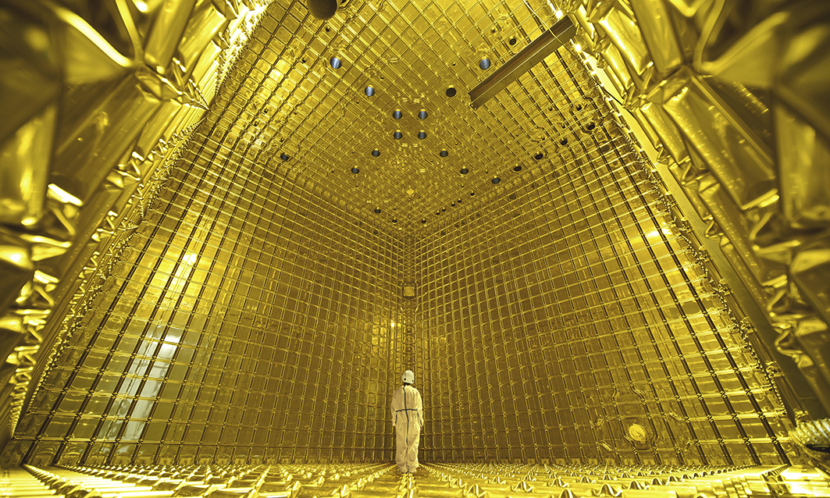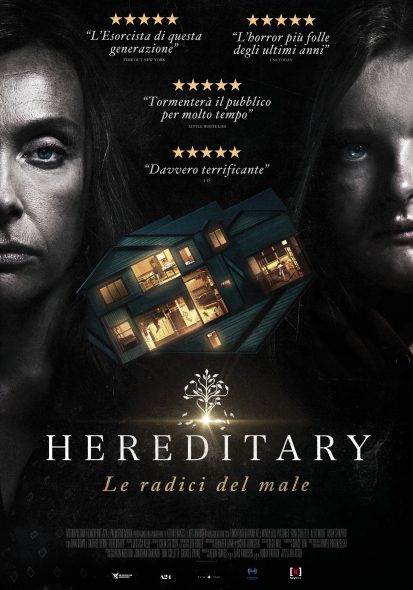 “Hereditary. Le radici del male”: è al cinema l’horror cult con Toni Collette. La recensione
“Hereditary. Le radici del male”: è al cinema l’horror cult con Toni Collette. La recensione
Hereditary: le radici del male ha preparato il suo pubblico da mesi con la diffusione di una serie di trailer che hanno sedimentato immagini iconiche e dettagli del film, creando un crescente interesse nei confronti della pellicola: lo schiocco del palato di Milly Shapiro, le espressioni di crescente disagio e i pantaloni palazzo di Toni Collette, le disturbanti miniature e, neanche a dirlo, una magione in legno al limitare del bosco.
Annie, miniaturista di grande talento, e la sua famiglia – il marito Steve (Gabriel Byrne), il figlio Peter (un untissimo Alex Wolff) e la figlia borderline Charlie (Milly Shapiro) – affrontano la scomparsa della nonna e matriarca Ellen, con cui Annie rivela già dall’elogio funebre non avere avuto un rapporto sano e disteso.
Il lutto sembra scatenare in ogni membro della famiglia traumi inconsci, appetiti ferini e paure sempre meno sussurrate.
Potrebbe essere l’ennesima rappresentazione della famiglia come culla di ogni disagio, un viaggio junghiano nelle esplosive dinamiche familiari, ma in questa casa al limitare del bosco sembra esserci qualcosa in più, una presenza atavica, terribile, pronta a giocare con la vita di ogni membro di questa famiglia.
Hereditary non è solo una nuova manifestazione dell’estetica ormai sempre più definita della casa di produzione A24 ma ne rappresenta l’attuale summa. Vi troviamo l’accurata ricerca filologica nella goezia (la magia nera) che ha reso iconico e agghiacciante The VVitch e l’inesorabile avanzata del male che si perpetua come un virus o peggio come una tara genetica che ci ha fatto innamorare di It Follows.
Ari Aster completa la sua visione con il confronto fra l’horror contemporaneo e la tragedia greca. I protagonisti della pellicola di Aster hanno la stessa paura di un male sovrastante che è propria degli eroi tragici (pensiamo a Ifigenia e Eracle, citati anche in Hereditary), un male che sembra giocare con le loro vite (come facevano gli dei dell’Olimpo) solleticando qua e là i nostri poveri protagonisti con oscuri vaticini, che Aster non manca di disseminare per tutta la pellicola.
Hereditary mostra inoltre un’attenzione al dettaglio degna di Hitchcock (d’altronde la protagonista Annie è una precisa miniaturista), l’agnizione finale (che ha fatto tremare come foglie al vento boschivo tutti gli spettatori) tira perfettamente le fila di tutte le storyline: perché il rapporto fra Annie e il figlio Peter è così corrotto? Cosa lega Charlie alla nonna defunta? Che peso hanno i traumi familiari di Annie sugli eventi attuali? Il crescente fandom sta già relazionando tutti gli indizi, le frasi e le fugaci visioni di cui Ari Aster ha disseminato Hereditary: il culto ha già i suoi molti adepti.
Hereditary è diventata la next best thing nell’horror contemporaneo anche grazie alle interpretazioni memorabili di Toni Collette, Alex Wolff e della mefistofelica Ann Dowd (la zia Lydia di The Handmaid’s Tale).
Toni Collette sposa fino all’ultima nevrosi il personaggio di Annie e ne travasa traumi, paure e (inconsci) istinti materni nella demoniaca follia finale. Le sue maschere di terrore puro sono il vero manifesto del film.
Alex Wolff (In Treatment, My Friend Dahmer) è invece il volto giovane (quel neo sul labbro è già marchio di fabbrica) da segnarsi e tenere d’occhio, il suo Peter – dimesso per tutta la prima parte del film nei confronti della Charlie di Milly Shapiro – è il personaggio che subisce l’arco evolutivo maggiore e, neanche a dirlo, quello che ci spaventerà di più. Chiude Ann Dowd, un personaggio quasi polanskiano (sembra uno dei volti che affollano il salotto del finale di Rosemary’s Baby), rassicurante per i primi dieci secondi poi folle ed esaltato come si richiede a una caratterista del suo calibro. Hereditary rafforza con un nuovo e vivido tratto la nuova estetica horror prodotta dall’americana A24 (che si chiama così perché i fondatori si trovavano sull’autostrada A24 Roma-Teramo quando decisero di mettere su l’azienda), nota per lasciare grande libertà ai propri registi, molto spesso esordienti come Ari Aster, permettendo loro di portare sempre qualcosa di nuovo e significativo all’interno di un genere longevo e prolifico ma che solo pochi anni fa stava per appiattirsi e consumarsi nello schema del franchising, con sempre meno idee e un rosario infinito di sequel, reboot e prequel di cui nessuno ha mai sentito il bisogno.
Hereditary rafforza con un nuovo e vivido tratto la nuova estetica horror prodotta dall’americana A24 (che si chiama così perché i fondatori si trovavano sull’autostrada A24 Roma-Teramo quando decisero di mettere su l’azienda), nota per lasciare grande libertà ai propri registi, molto spesso esordienti come Ari Aster, permettendo loro di portare sempre qualcosa di nuovo e significativo all’interno di un genere longevo e prolifico ma che solo pochi anni fa stava per appiattirsi e consumarsi nello schema del franchising, con sempre meno idee e un rosario infinito di sequel, reboot e prequel di cui nessuno ha mai sentito il bisogno.