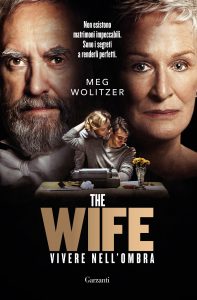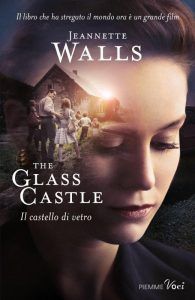The Wife – Vivere nell’ombra di Meg Wolitmer e The Glass Castle di Jeannette Walls. Quando il libro è davvero meglio del film
The Wife – Vivere nell’ombra di Meg Wolitmer e The Glass Castle di Jeannette Walls. Quando il libro è davvero meglio del film
«L’hai visto il film? Sì ma il libro è più bello!», quante volte l’abbiamo detto? Tante, troppe. È una banalità, lo diciamo per darci un tono. Spesso il libro nemmeno lo abbiamo letto. La maggior parte dei film di Hitchcock è tratta da romanzi o racconti (Jamaica Inn, Rebecca e Gli Uccelli da Daphne du Maurier, Psycho da Robert Bloch, Marnie da Winston Graham – quello di Poldark), e nessuno si sognerebbe di dire “era meglio il libro”. Ma anche Apocalypse Now, Il Padrino, Il laureato, Blade Runner, Lo squalo… Chi li hai letti di libri!
A volte però è vero, al di là della chiacchiera da salotto, ci sono alcuni film che nonostante l’impegno produttivo, l’ottimo cast e le migliori intenzioni proprio non ce la fanno a superare il soggetto letterario da cui sono tratti e, cosa ben peggiore, finiscono per essere dei film mediocri (quando va bene).
Sono usciti in sala di recente due film molto attuali per l’era delle rivoluzioni fatte con gli hasthag, parlano di donne oppresse e classi sociali. The Wife – Vivere nell’ombra, tratto dall’omonimo romanzo di Meg Wolitmer (edito da Garzanti) e The Glass Castle, dal bestseller di Jeannette Walls (edito da Piemme). In entrambi i casi i film mancano il bersaglio e, con un tonfo sordo, finiscono diretti nel cestone delle pellicole dimenticabili. I romanzi invece hanno una ricchezza e una complessità che vale la pena di non sottovalutare. Nel caso del romanzo autobiografico di Jeannette Walls è anche inutile sottolinearlo, sta ben ancorato nella classifica dei libri del New York Times dal 2005.
 The Wife – Vivere nell’ombra descrive in maniera estremamente acuta le dinamiche di un matrimonio (o forse di tutti i matrimoni, in un certo senso), nella perenne illusione di una quiete immobile. Meg Molitzer tratteggia il ritratto di un uomo apparentemente innamorato delle donne, delle parole, ma in realtà innamorato solo di sé stesso, restituendo così un romanzo sulle dinamiche del potere. “Di norma, i padroni del mondo sono sessualmente iperattivi, benché non necessariamente con le loro mogli”, riflette la protagonista del romanzo, Joan Castleman (nella versione cinematografica una sempre splendida Glenn Close – nominata per questo ruolo ai Golden Globe e quasi sicuramente anche ai prossimi Oscar).
The Wife – Vivere nell’ombra descrive in maniera estremamente acuta le dinamiche di un matrimonio (o forse di tutti i matrimoni, in un certo senso), nella perenne illusione di una quiete immobile. Meg Molitzer tratteggia il ritratto di un uomo apparentemente innamorato delle donne, delle parole, ma in realtà innamorato solo di sé stesso, restituendo così un romanzo sulle dinamiche del potere. “Di norma, i padroni del mondo sono sessualmente iperattivi, benché non necessariamente con le loro mogli”, riflette la protagonista del romanzo, Joan Castleman (nella versione cinematografica una sempre splendida Glenn Close – nominata per questo ruolo ai Golden Globe e quasi sicuramente anche ai prossimi Oscar).
Meg Wolitzer ha dato vita a un racconto agrodolce alimentato da temi dolorosi. La rabbia, emozione tipica dei senza potere, nelle mani di Wolitzer diventa inaspettatamente divertente; un umorismo nero e gelido ovviamente. Il romanzo ripercorre la storia del matrimonio dei Castleman dai tempi del loro primo incontro, un amore (!?) lungo 45 anni. Lui professore già sposato e con un figlio, lei sua giovane studentessa.
Lui scrittore di dubbio che cerca di inutilmente di lanciare la propria carriera e lei autrice talentuosa ma remissiva che ben presto si mette al suo servizio come ghostwriter. Ironicamente il romanzo è quasi un omaggio all’idea che i cliché siano cliché proprio perché sono veri, e Joan è una narratrice ferita ma cinica quanto basta per sfidare il lettore a ricostruire il puzzle della sua storia. Una storia sul prezzo dell’amore e della fama, sulla natura del matrimonio e sul peso dei compromessi, raccontata con una prosa al contempo aspra e brillante.
Il film di Björn Runge (qui la recensione) cerca di mantenersi in bilico sulle note dolenti della frustrazione di Joan senza però affondare mai realmente la lama negli altri aspetti del suo carattere: il cinismo, lo humor sprezzante e il disincanto. Discorso simile si potrebbe fare per The Glass Castle. Il film di Destin Daniel Cretton con Naomi Watts e Brie Larson non brilla per sensibilità e non rende affatto giustizia al memoir di Jeannette Walls.
Discorso simile si potrebbe fare per The Glass Castle. Il film di Destin Daniel Cretton con Naomi Watts e Brie Larson non brilla per sensibilità e non rende affatto giustizia al memoir di Jeannette Walls.
Un’infanzia nomade, per descrivere il soggetto in estrema sintesi. All’età di quattro anni Jeannette Walls si era già trasferita assieme alla sua bislacca famiglia undici volte. Guidati da un padre eccentrico e da madre dall’indole artistica e distratta, Jeannette e i suoi tre fratelli hanno viaggiato attraverso gli Stati Uniti, dall’Arizona alla California, attraverso città minerarie e vivendo all’aperto nel deserto, sempre in fuga (il padre aveva manie di persecuzione, tra le altre cose), spesso con pochi minuti per raccattare le poche cianfrusaglie che possedevano.
Il romanzo restituisce un racconto spontaneo e personale su un’infanzia di disagi, segnata dalle figure di un padre alcolizzato e una madre spesso depressa, entrambi -a loro modo- grandi sognatori. Anche in questo caso c’è però un inaspettato taglio umoristico e la narrazione non cade mai nel pietismo (al contrario di quanto accade nel film). Jeannette non prende le distanze dai fallimenti dei proprio genitori, ma in modo quasi inaspettato rende loro omaggio, nel suo processo di emancipazione riesce a fare pace col proprio passato e a essere solidale con le lotte e i demoni di quella sua famiglia così tremendamente disfunzionale, ma sempre unita. Quella di The Glass Castle è una narrazione appassionante, piena di vita; Jeannette Walls ha una scrittura magnetica, riesce a usare registri differenti tra loro in maniera inaspettata e naturale al contempo. Il romanzo possiede una complessità, di forma e contenuto, che ne lo rende irresistibile, trasforma il dramma in lievità senza banalità alcuna o trucchi retorici, tutte qualità che mancano alla sua versione cinematografica, troppo descrittiva e marziale.