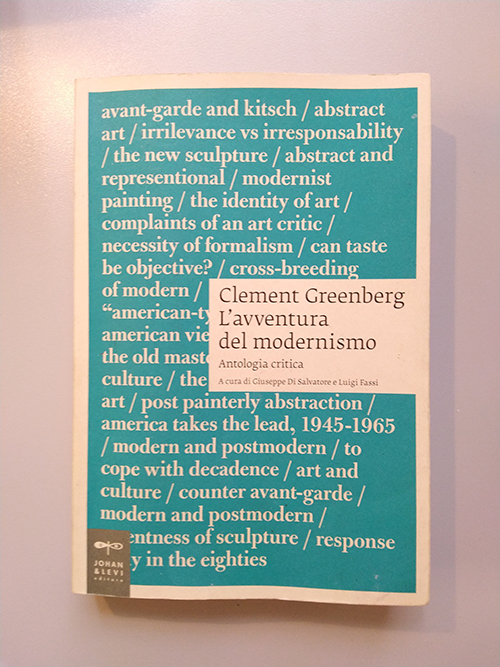Il critico americano Clement Greenberg (1909-1994), inventore del modernismo e grande sostenitore dell’arte astratta, fu profetico. Mise in luce, già a partire dagli anni Sessanta del Novecento, la pochezza dell’arte concettuale e di tutte le sue stravaganze e provocazioni. Quelle che ora sono osannate dai curator alla moda e vengono esposte nelle fiere très chic. Greenberg non venne perdonato dall’intellighenzia più ortodossa e progressista, quando in tarda età si rivelò un solido conservatore. Capace di sbertucciare Duchamp e la progenie di minimalisti, in nome della grande arte e contro la non-arte. Oggi, in tempo di peste, il suo insegnamento ci è di conforto. Perché in fin dei conti, come chiosava, la pittura è l’unica arte d’avanguardia in grado di salvarci
I curator più cool e i direttori dei musei del contemporaneo lo hanno dimenticato. Almeno hanno dimenticato l’ultimo Greenberg, quello di fine anni Settanta e primi Ottanta, quello meno digeribile, più ostico e meno scontato. Per i laudatores del concettuale, il solo Greenberg potabile è il fondatore del modernismo, l’inventore dell’espressionismo astratto. Ma in quanto tale estromesso dai tempi, essendo superato il moderno – dicono loro – dal contemporaneo. Insomma, Greenberg per chi lo ha letto o ha finto di averlo letto, è solo un buon critico d’arte del Novecento. I cui pensiero aleggia sul primissimo Dopoguerra, appunto in quel decennio in cui l’astrattismo americano divenne la corrente artistica più importante nel mondo, definita dalle categorie della “piattezza” e della “bidimensionalità”, qualità imprescindibili delle opere d’arte moderna che lui stesso aveva teorizzato.
Kantiano, ma anche marxista, da principio Trozkista poi elitista, Greenberg, il più grande critico di quegli anni, fu archiviato non appena il suo armamentario teorico apparve insufficiente a giustificare la Pop Art e il Minimalismo. E ancor più bellamente estromesso dal club degli intelligenti, quando affilò il suo pensiero critico contro il concettuale e l’arte contemporanea – sebbene all’epoca la definizione “contemporanea” ancora era da venire – smontando Duchamp e tutta la progenie di epigoni. Invecchiando, Greenberg assunse sempre più spesso un tono da buon conservatore e questa fu la sua maggior colpa, proprio nel momento in cui l’arte diventava il territorio per antonomasia del pensiero progressista.
L’attualità di un profeta contro l’arte insensata
Riletto oggi Greenberg appare un gigante, profetico, capace di resistere alle temperie del relativismo e di controbattere punto su punto allo slittamento dell’arte contemporanea verso l’orrendo e l’insensato. Sebbene votato all’astrattismo, il suo discorso vale per la pittura di ogni genere e appare confortante l’approccio teorico che, in nome della oggettività della bellezza e del gusto in grado di riconoscerla, fonda l’arte di tutti i tempi e non solo quella delle avanguardie a lui care. Greenberg è infatti convinto che la qualità nell’arte sia un fatto oggettivo e, dunque, che si possa distinguere tra arte buona e arte cattiva in ragione dell’esperienza estetica che essa suscita; inoltre sostiene che l’arte è sufficiente a sé stessa (l’arte per l’arte), cioè non ha bisogno di ulteriori fini, soprattutto di ordine morale, né di ulteriori contenuti, politici o sociali, essendo quello estetico un valore autonomo e dunque il solo valore da perseguire.
Ed è per questo che gli appare così futile e inutile, l’arte minimalista e concettuale (da lui definita “non-arte”) che si nega a priori qualsiasi implicazione estetica, sottraendosi alla sfera del gusto, e che cerca fuori dal proprio perimetro una giustificazione. E gli appare altrettanto disdicevole l’ideologia dell’innovazione che vuole a tutti i costi non solo l’innovazione (che da sempre ha contraddistinto l’arte, con il fine di mantenere una continuità con la tradizione), bensì l’esasperazione di questa innovazione. Così da renderla sorprendente e spettacolare, e questa necessità di innovazione sorprendente e spettacolare a tutti i costi è diventata una convenzione; quella che egli definisce “novelty art”, l’arte della novità, un’arte che per questo motivo diventa kitsch.
Contro il ready made di Marcel Duchamp
Duchamp, secondo Greenberg, è il responsabile di questa degenerazione. I primo ad aver ripudiato la differenza tra arte alta e arte bassa, cercando di eludere la differenza tra il buono e il cattivo, ritirandosi da un’arte difficile per un’arte facile. E lo ha fatto, per “frustrazione”, nel modo più spregiudicato, mascherando la ritirata dal difficile al facile sotto le spoglie del “difficile in maniera più abile, aggressiva, stravagante”. L’arte fintamente difficile è evocata “da una fila di scatole, da un semplice bastone, da una pila di rifiuti, da una porta socchiusa, dalla sezione trasversale di una montagna, da una parete vuota…”. Come se la difficoltà di mettere a fuoco qualcosa come arte equivalesse alla difficoltà dell’arte veramente nuova e originale, “come se la difficoltà esteticamente estrinseca, meramente fenomenica o concettuale potesse ridurre nell’arte la differenza tra buono e cattivo fino a renderla irrilevante”.
Duchamp, contro l’avanguardia, inventò l’avanguardismo. Per cui “lo scioccante, il sorprendente, l’ingannevole e il contraddittorio furono abbracciati come fini in sé. Con l’avanguardismo è arrivato il fraintendimento forzato, “un fraintendimento aggressivo, inflazionato, pretenzioso”; le opere ready made (la ruota di bicicletta, lo scolabottiglie, l’orinatoio…) diventano opere solo grazie al contesto di arte in cui vengono presentate, un contesto culturale e sociale ma non estetico o artistico. E dunque rappresentando un arte “grezza”, non formalizzata, non suscitano nessuna emozione estetica, se non in modo superficiale.
L’arte procede sempre dalla tradizione
Greenberg inoltre mette in discussione uno dei concetti base dell’arte contemporanea intesa come macchina di comprensione dell’attimo presente, strumento in perenne evoluzione sulla linea unidirezionale del progresso. Come se ogni opera spingesse un poco più oltre il confine umano prescindendo dal resto. Ma così non è, perché l’arte “superiore” – dice Greenberg – deriva quasi sempre dalla tradizione. Procede quando una serie di aspettative di novità si evolve in un’altra, includendola, e per ciò si deve ricordare che “questa evoluzione, nonostante sia cumulativa, non significa necessariamente progresso, non più di quanto lo significhi la parola stessa evoluzione”.
E anche la dimostrazione che qualsiasi oggetto può essere arte. Secondo il diktat duchampiano ciò diventa una dimostrazione ripetitiva e stucchevole agli occhi del critico americano. Cosa invece che non accade per la vera arte perché essa va esperita ogni volta con i sensi, ed è capace di dare sensazioni nuove. La vera arte è lo sforzo continuo di arrestare il declino degli standard estetici minacciati dalla democratizzazione della cultura nel tempo dell’industrializzazione, resistenza che non appartiene all’arte pop, minimalista e concettuale le quali, al contrario, l’hanno assecondata e accolta.
E questa sorta di “katechon” della buona arte contro la decadenza ineludibile che minaccia il mondo occidentale, secondo le visioni di Spengler, di un Occidente incapace di distinguere tra bene e male, tra bello e brutto, viene messo in essere, soprattutto dai pittori, essendo “la pittura l’arte d’avanguardia per eccellenza”, e dunque al pittore, anche oggi, va affidata la salvezza.
Tra le poche cose tradotte e ancora in catalogo, l’ottimo volume a cura di Giuseppe di Salvatore – Luigi Fassi.
Clement Greenberg, “L’avventura del modernismo. Antologia critica”, Johan & Levi, 2011