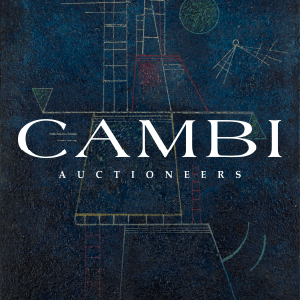Silvia Bigi (Ravenna, 1985) esordisce nel mondo dell’arte attraverso la fotografia dopo essersi laureata al DAMS di Bologna. Mediante l’utilizzo di diversi linguaggi – fotografia, installazione, scultura, suono, video – il suo lavoro esplora la relazione fra memorie individuali e collettive.
Le sue opere, oggi parte di collezioni pubbliche e private, sono state premiate e selezionate per esposizioni nazionali e internazionali, tra cui la mostra Engaged, active, aware: women’s perspective now; è stata vincitrice del Lucie Award/Best Exhibition 2018, Museo di Arte Contemporanea (Zagabria). I suoi lavori sono stati esposti presso: Musei Civici agli Eremitani (Padova), Chiostri di San Domenico (Fotografia Europea/ Reggio Emilia), Galerie Hinterland (Vienna), MLZ Art Dep (Trieste). Selezionata da Diane Dufour per Der Greif, è artista in residenza presso Bòlit (CAT) e La Chambre Blanche (Quèbec).
Il binomio reale/realtà, introdotto dallo psicoanalista Lacan, è uno dei punti di riferimento nella sua pratica, in cui il reale rappresenta uno spazio sottostante, costantemente represso, della nostra esistenza. Nei suoi lavori, l’artista invita il fruitore alla decostruzione dello sguardo, che incarna un modello culturale egemone. Le tematiche che analizza maggiormente sono, infatti, la struttura patrilineare, la condizione della donna, le tradizioni in senso più ampio, ma anche le sue origini familiari e identitarie.
In occasione della mostra REFOLDED. Percorsi meta-artistici, aperta fino allo scorso 18 gennaio presso la Fondazione Pastificio Cerere, a Roma, Bigi ha esposto alcuni dei risultati del progetto From dust you came (and to dust you shall return), che porta avanti dal 2018.
Grazie alla piattaforma indipendente Percorsi Fotosensibili che gestisce, Bigi è anche insegnante: il percorso di formazione da lei proposto ha lo scopo di far scoprire a ogni studente il proprio potenziale fotografico.

Come è nato il progetto From dust you came (and to dust you shall return) e in cosa consiste?
Nel 2018 ero ossessionata da una domanda: che relazione esiste fra memoria, colore e percezione? Ero mossa dalla consapevolezza che come esseri umani non vediamo mai realmente le cose, le persone o i luoghi, ma solo la luce che essi riflettono. Quella luce si traduce in colore, il colore in percezione. Le nostre emozioni – così come i nostri ricordi – sono indissolubilmente connesse a questo processo di codificazione. Al centro della mia indagine si è subito presentato dunque un paradosso: il colore è sì materia, eppure ogni essere vivente lo percepisce in modo unico: qual è la soglia fra oggettività e soggettività? Quale il punto di incontro fra percezione e realtà? Ho cominciato così a campionare i colori delle immagini partendo dalla prima fotografia della mia vita, creando monocromi che andavano a sostituirsi ai ricordi di famiglia. Durante il processo mi sono ritrovata con un cutter fra le mani, intenta a polverizzare le superfici di quelle stesse immagini da cui ero partita, domandandomi ancora una volta se il colore fosse percezione o materia, nel tentativo di afferrarne le qualità intrinseche, ma anche per preservarne la materialità più pura e universale.
From dust nasce dal tentativo di ricavare nuovi pigmenti colorati grattando le superfici delle fotografie del mio archivio di famiglia. Il pigmento che ottengo dal raschiamento non è puro, né minerale: è il risultato di una lunga serie di processi trasformativi, di stampa, di digitalizzazione, di copia: l’immagine oggi si reincarna in differenti stati, portando inevitabilmente a interrogarsi sul tema della materialità fotografica nell’epoca della sua dissoluzione oggettuale. Nel suo manifesto The first man was an artist, Barnet Newman afferma che le prime rappresentazioni umane furono primariamente un grido artistico. I primi pigmenti estratti dall’uomo erano in effetti terre, usate nelle pitture rupestri, come dimostrano le grotte di Lascaux. From dust you came (and to dust you shall return) rappresenta in un certo senso il tentativo di chiudere un cerchio, di distruggere per ricostruire, riconnettendo la mia pratica al grido originario di cui parla Newman: cominciammo in effetti dal pigmento naturale a rappresentare il nostro mondo. Il mio nuovo pigmento porta con sé quella natura atavica e contemporaneamente tutti i detriti della nostra era, che ne rappresentano una qualità essenziale. La polverizzazione del mio archivio fotografico famigliare trasforma inoltre la mia memoria privata in memoria collettiva: il nuovo pigmento, riposto in piccole ampolle di vetro, può essere utilizzato per produrre nuove forme di rappresentazione, in un eterno ciclo.
Il lavoro è composto da una moltitudine di fotografie cancellate: involucri, residui dell’intero processo. Poi ci sono i “blow-up”, ovvero gli ingrandimenti di porzioni di fotografie da cui ottengo grandi quantità di polvere colorata e che preservo quasi fossero degli anti-disegni. Infine, le polveri, contenute nelle piccole ampolle in vetro di Murano, realizzate su ispirazione della biblioteca dei pigmenti di Harvard – la più grande collezione di pigmenti naturali al mondo.
Ora sto cominciando a utilizzare le polveri per produrre acquerelli, acrilici e dipinti a olio: lego la polvere fotografica come fosse un normale pigmento, anche se non si scioglie completamente, ricordando così la sua vera natura. Che cosa rimane dei miei ricordi? È la domanda che motiva questa nuove azioni. Sto anche pensando ad una fase finale, in cui invitare il pubblico ad usare i nuovi pigmenti, dipingendo come vuole su una tela bianca. Trovo entusiasmante l’idea di una fase partecipativa: credo fortemente nell’arte come azione collettiva.

Come mai hai scelto di esporre questo progetto all’interno della mostra? Ti senti affine, per modalità, scelte artistiche o ispirazioni, a qualcuno degli altri artisti presenti?
Il lavoro è stato selezionato per la mostra tramite un bando nazionale: si tratta del Premio Generazione Contemporanea, dove una giuria composta da Achille Bonito Oliva, Peter Benson Miller, Roberto Cotroneo, Pia Lauro, Gianfranco Maraniello, Giovanna Melandri, Domenico Piraina, Luca Pirolo e un rappresentante del Collettivo Curatoriale della decima edizione del Luiss Master of Art, ha decretato tre opere finaliste da unire al corpus di lavori già presenti nell’esposizione. Quando mi è stato notificato che la mia opera era stata scelta tra più di trecento proposte ne sono stata felice e soprattutto onorata.
Il tema lo sento profondamente vicino: ho apprezzato molto la selezione delle opere, che mostra tante affinità e allo stesso tempo esprime una moltitudine di linguaggi e possibilità per riflettere sui processi stessi del fare arte, in dialogo con gli spazi della Fondazione Pastificio Cerere.

I tuoi progetti seriali seguono specifici iter creativi, diversi tra loro per tecniche e mezzi; penso a Il codice (L’albero del Latte) , come anche a Cicatrici. Come e quando scegli la modalità di elaborazione dei tuoi lavori ?
Il mio processo creativo è estremamente libero, può essere attivato da qualsiasi cosa: un’idea, un ritrovamento, un gesto. Nonostante la formalizzazione dei lavori risulti alla fine spesso differente, ci sono punti di contatto imprescindibili: il tema della memoria, l’immagine come incarnazione di precise istanze identitarie e culturali, l’opera come soglia per accedere ad altri mondi. La fotografia è stata fondamentale nel mio percorso formativo, e per questo è spesso il mezzo da cui le mie indagini hanno origine: tuttavia può essere anche il punto di approdo, come accade ad esempio ne Il Codice, in cui parto dall’esigenza di dare vita ad una falsa memoria retrospettiva, o come mi piace definirla un’“anti-memoria”, per poi attestarne l’esistenza attraverso una documentazione fotografica. Il Codice (L’albero del latte) è un’opera tessile, lavoro finale di un importante progetto di mostra sviluppato nel 2017 e prodotto dalla Fondazione Dino Zoli.
Tutte le opere nell’esposizione ruotavano attorno a una domanda: quanto noi donne siamo ancora costrette all’interno di forme ataviche di assoggettamento, e quanto siamo realmente a un punto di svolta nella nostra lotta per l’auto-affermazione? Per Il codice ho immaginato, inscenato e documentato una possibile trasmissione segreta: un insieme di leggi ricamate a mano, bianco su bianco, custodite e tramandate di generazione in generazione. Si trattava del tentativo di penetrare nel tessuto del tempo, al fine di innestare una possibilità in risposta a consuetudini millenarie e ideologie che troppo a lungo si sono presentate come fatti naturali ed empirici.
L’idea nasce dalla lettura del Kanun di Leke Dukagjini, l’antico canone di leggi dei Balcani, ove sono descritti rapporti di parentela, doveri coniugali, coercizioni sociali e vincoli di sangue che relegavano la donna ad un ruolo di evidente marginalità e subordinazione. Nell’urgenza di rispondere criticamente al Canone, ho creato un nuovo Canone: il nuovo codice è composto da tredici leggi, scritte da donna a donna nel proprio dialetto, al fine di preservare inviolato un sapere pre-razionale e occulto attraverso le azioni del ricamo, della trasmissione e del dono. La sua lettura, i suoni aspri, sanguigni e indecifrabili, si trasformavano in mostra in una ripetizione sovversiva, una sorta di mantra teso a far interiorizzare in chi ascoltava la possibilità di una deviazione storica.

Cicatrici ha invece tutt’altra genesi: parte da una giornata precisa, il 10 agosto 1985, indelebile nella storia della mia famiglia, per via dell’incidente aereo che vede tra i passeggeri mio padre. All’epoca avevo solamente due mesi di vita, e per questo non ho alcun ricordo di ciò che accadde. È sempre stato un incredibile paradosso per me: ero lì, tra le braccia di mia nonna, quando lui apparve in condizioni terribili davanti a noi, superstite. Scendeva da un sentiero di montagna, gridando aiuto. Ironia della sorte, di quel giorno non ho alcun ricordo: a pochi mesi di vita, infatti, la corteccia cerebrale non è abbastanza sviluppata per trattenere i ricordi. L’intero progetto è un vero e proprio viaggio nella memoria e nell’imperscrutabilità dei suoi processi: ma è anche un viaggio reale, volto a ricostruire il lungo percorso compiuto da mio padre, quel giorno, per salvarsi. Il progetto si compone di documenti, testimonianze, fotografie e installazioni: tutte ruotano attorno ad un vuoto, il mio ricordo mancante, l’immagine di mio padre che riappare davanti ai miei occhi. Nonostante si tratti di un lavoro estremamente intimo e personale, è anche un lavoro che racconta delle enormi trasformazioni della fotografia negli ultimi trent’anni: quel giorno infatti mio padre si trovava in volo per scattare fotografie aeree.
Oggi, che le immagini ci sovrastano e non necessitano spesso più di produzione essendo tuttalpiù “disponibili”, i resti dell’aereo ritrovati nel bosco (sì, li ho trovati: erano ancora lì, nonostante fossero trascorsi molti anni) non riguardano solamente la storia di mio padre. Essi sono vere e proprie reliquie di un culto per la fotografia scomparso. Cicatrici è il lavoro più personale che abbia mai realizzato, ed è stato difficilissimo per me condividerlo. Alla fine, ho trovato la forza, è diventato mostra e libro d’artista. I miei lavori non nascono quasi mai con un’idea costruita e definitiva. In questo caso avevo un indizio: le cicatrici sulla pelle di mio padre, che erano sempre state davanti ai miei occhi e – forse – la volontà di utilizzare l’arte come pretesto per scandagliare una storia familiare nella quale altrimenti non avrei mai osato addentrarmi: non avrei mai potuto spingermi così tanto oltre. E invece sono giunta a coinvolgere tutta la mia famiglia, chiedendo loro di raccontarmi quella giornata dall’inizio alla fine. Ho analizzato ogni documento, giornale, referto medico, per poi tornare alla fotografia come strumento di comprensione del reale. Dopo ti faccio vedere un pezzo dell’aereo, ne ho fatto una scultura.
Le mie idee progettuali nascono da ritrovamenti, gesti, intuizioni: non ho un modo unico e mi lascio molto trasportare dall’ascolto: prima arriva un’intuizione, una scintilla, che è veramente difficile da descrivere a parole. Può essere un incontro casuale, un ritrovamento, un pensiero, un sogno, qualsiasi cosa ma di sicuro viene dal profondo. E a quel punto subentra un processo analitico di messa in forma, diverso di volta in volta. Io credo infatti che ogni idea abbia un suo corpo. Non mi sono mai accontentata di una singola forma: credo che se lo facessi, lo farei semplicemente per il mercato, perché così il tuo lavoro è più riconoscibile ed è più facile inserirlo in categorie prestabilite.

È molto interessante quello che dici. Penso che pochi artisti riescano a spaziare così tanto, pur mantenendo lo stesso medium, che in questo caso è quello della fotografia. Pur costruendo sempre progetti seriali, tu spazi molto progetto dopo progetto. Non c’è mai nemmeno una traccia del progetto prima. L’unica cosa comune in alcuni è la tua famiglia, la memoria.
Non ti so dire se ci siano o meno tracce del lavoro precedente in quello successivo: sicuramente il filo rosso che li accomuna tutti sono io, il mio modo di vedere ciò che incontro, ciò che si presenta davanti a me lungo il mio cammino. Fare arte per me è un’esperienza totalizzante e mi tiene sveglia molte notti. A volte sono totalmente sopraffatta, e allora mi ripeto una frase di Cristina Campo che amo molto: “Se lo scriba non è veloce abbastanza da incidere esattamente le parole, significa che così com’egli le incide Dio le vuole incise e così incise opereranno”.

Tornando a From dust you came (and to dust you shall return), trovo che ci sia una dualità all’interno del progetto: c’è l’atto della conservazione, secondo cui tu gratti visi, volti, figure e ne conservi sia la polvere che le immagini svuotate, ma dall’altra parte c’è anche questo atto, non violento ma insomma…, in cui gratti via, un po’ come una cancellazione. Non sono due concetti che lottano tra di loro ma bisticciano un po’…
Sì, sono d’accordo, sono due processi opposti che generano una tensione reciproca: uno rappresenta un’azione violenta (la cancellazione) mentre nell’altro (la conservazione) c’è una volontà di prendersi cura di ciò che ne rimane. Del resto, è la fotografia stessa ad essere un paradosso: nasce meno di due secoli fa, eppure a lei affidiamo tutta la nostra memoria. La fotografia è l’unico strumento per ricordare? L’umanità esiste da milioni di anni e per molto tempo ha preservato la sua Storia in modi differenti.
Aver dato questa enorme responsabilità a uno strumento relativamente giovane, che un domani potrebbe scomparire, oppure – come sta già facendo oggi – subire significative mutazioni che le permettono con estrema facilità di mentire, la rendono uno strumento profondamente contraddittorio. Se le mie fotografie di famiglia non ci fossero più, cosa ne sarebbe della mia esistenza? Come ricorderei? Dunque, sì, è vero, la mia è una critica e allo stesso tempo è anche un atto d’amore. Il fatto che diventi polvere, che acquisisca una nuova forma, rappresenta uno slittamento del punto di vista: da una visione antropocentrica a una in cui torniamo ad essere qualcosa che si colloca “tra l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande”.
La psicologia e la psicoanalisi sono molto presenti nel tuo lavoro. Ti sei avvicinata a questa disciplina per tuo interesse personale?
Sì, è un aspetto molto presente. Ho studiato psicologia, antropologia e sociologia al liceo. Ultimamente, mi sono molto appassionata di Jung: una mia studentessa la scorsa estate mi ha regalato la sua copia del Liber Novus: me l’ha lasciato in portineria, con un biglietto che diceva che ne avrei fatto un buon uso, che l’avrei trasformato in opera. Sai, il lavoro di insegnante e di artista sono profondamente legati nella mia vita: si può dire siano due facce della stessa medaglia. Mi sono appassionata a Jung perché per me rappresenta una perfetta combinazione di pensiero razionale e pensiero occulto, pre-razionale: pensiero completamente rimosso dalla cultura occidentale. Mi affascina molto in particolare tutto il lavoro che ha intrapreso sull’inconscio collettivo e sui sogni, che poi ciò a cui mi sono ispirata per il progetto iniziato la scorsa primavera, Urtümliches Bild.

Come hai passato il primo periodo di quarantena, e quello corrente? La chiusura ha favorito o bloccato la creazione di nuovi progetti? Penso all’ultimo che hai avviato, appena accennato, Urtümliches Bild.
I primi mesi di confinamento sono stati molto difficili. Approfittavo per fare ricerca, studiavo Marx, Gramsci, Jung: cose che ti dici: “adesso o mai più!”. Eppure, non stavo progettando niente di nuovo. Semplicemente non ero pronta, stavano accadendo cose che non riuscivo ancora a comprendere fino in fondo: quando sono stata contattata per realizzare un progetto inedito per il festival Cortona On The Move su invito dei curatori Daniele De Luigi e Ilaria Campioli, non riuscivo a immaginare nulla che avesse a che vedere con il mondo esterno. Così, ho deciso di rivolgere la mia attenzione ai sogni notturni. Mi ero accorta di come la mia attività onirica fosse particolarmente intensa durante la quarantena. Dei sogni ricordavo ogni dettaglio: apparivano molto vividi, e così ho cominciato a trascriverli. Rileggendoli, mi sono accorta di come portassero con sé già i segni della pandemia: la paura dell’incontro, le mascherine, i divieti.
Il mio inconscio stava già lavorando per metabolizzare la situazione, per assimilare ciò che forse la mia mente razionale non era ancora in grado di accettare. Ho deciso che avrei lavorato su questo tema. Sono partita raccogliendo trentanove sogni provenienti da diverse regioni del Pianeta, per poi affidarli ad un algoritmo di apprendimento automatico text-to-image, ovvero un programma di intelligenza artificiale che tenta di tradurre input testuali in immagini. L’algoritmo è studiato per tradurre il testo nel modo più realistico possibile, ma con un contenuto profondamente illogico come quello dei sogni, finiva per “fallire” il compito per il quale era stato progettato, producendo immagini astratte, completamente prive di regole e riferimenti al reale. La cosa interessante è che queste nuove immagini sono frutto della combinazione di fotografie preesistenti, messe in relazione dal programma al di là del mio controllo: i sogni sono così letteralmente scivolati da un inconscio umano ad un inconscio tecnologico, come direbbe Vaccari. Non sono interessata alla tecnologia in sé, la uso – un po’ come faccio con qualsiasi mezzo – come una “penna”, uno strumento qualsiasi.
L’astrazione prodotta dalle macchine mette in scena un nuovo modello visivo, una nuova iconografia, anche se può ricordare alcune esperienze del XX secolo, le avanguardie storiche come l’astrattismo. Un ritorno all’astratto, ad ogni modo, io credo sia urgente oggi più che mai, poiché l’immagine fotografica è ancora molto legata al concetto di referente. Con l’astrattismo ci troviamo di fronte ad una trasfigurazione della realtà e di questo abbiamo bisogno, di aprire nuovi orizzonti di senso e non rimanere costretti dentro a schemi visivi (e mentali) troppo rigidi. La fotografia non è uno strumento esclusivo in mano agli artisti: la fotografia è di chiunque. Per questo e ancor più, credo sia urgente un’educazione all’immagine, al vedere, e insieme un’educazione ecologica alla nuova produzione di immagini, perché oggi ne siamo letteralmente sommersi. E questo è un altro tema a me caro.
Dunque, distruzione delle immagini per comprenderle (From dust you came) e ricostruzione di immagini nuove, dentro le quali confluiscono gli infiniti click che produciamo ogni giorno (Urtümliches Bild), poiché i dataset che addestrano l’algoritmo sono niente più che miriadi di immagini prese dalla rete. Mi piace quindi immaginare che tutto questo inquinamento visivo prodotto, alla fine, dia vita a qualcosa di bello: da un rumore visivo assordante a nuovi immaginari, dove gli scatti fotografici non sono altro che immagini-alfabeto, necessarie alle nuove tecnologie per lo sviluppo di una nuova iconosfera. Questo è il nuovo viaggio appena intrapreso.