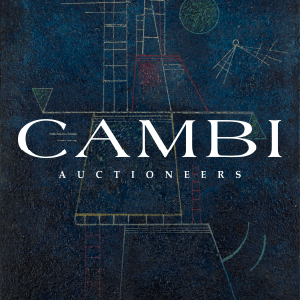Vendere o non vendere? La declinazione shakespeariana illumina bene l’umore dei grandi musei americani. Sempre più alle prese con apocalittici bilanci provocati dalla pandemia.
A differenza dei musei pubblici italiani, che conservano beni inalienabili, le grandi istituzioni statunitensi hanno da sempre esercitato la facoltà di cedere delle opere. Ma solo per acquistarne altre. Con lo scopo cioè di potenziare e valorizzare la loro collezione. Non certo per tappare le falle di esercizi economici disastrosi. Da qualche mese nel mondo dell’arte internazionale va invece di moda un termine inusuale: “deacessioning”. Che suona sinistro. Come vuotare le casse. Ma nello stesso -faticoso- termine si nasconde un aspetto malinconico. Quasi arrendevole.
Con questa parola si intende la cessione da parte di un museo di un’opera (o più) appartenente alla propria collezione. L’operazione è tanto controversa che anche negli Stati Uniti, patria del liberalismo sfrenato, si interrogano sulla legittimità e i confini entro cui può operare. Perché da soluzione per lo sviluppo, d’improvviso si è trasformata nell’argine cui affidare l’impedimento del contrario. In circostanze normali vi si può ricorrere solo se mossi dall’intenzione di finanziare nuove acquisizioni. Oggi è un salvagente. E in questi mesi persino la questione etica è sfumata dietro l’inquietante crollo dei ricavi che ogni museo si è trovato a fronteggiare durante e dopo il lockdown.
Le perplessità dell’Association of Art Museum Directors
Così l’Association of Art Museum Directors (AADM) ha dovuto rivedere le restrizioni imposte negli ultimi anni, aprendo una finestra – da aprile 2020 ad aprile 2022 – in cui è possibile cedere i propri asset artistici per un ventaglio più ampio di ragioni. Ragioni che, ovviamente, non esulano comunque dalla salvaguardia e dalla valorizzazione della collezione. Et voilà, nell’ottobre 2020, il Baltimore Museum (che già nel 2018 aveva venduto alcune opere per acquistarne altre) decide di cedere tre dei suoi pezzi più importanti -tra cui “L’ultima Cena” di Andy Warhol (1986)- con Sotheby’s, ipotizzando un guadagno $65 milioni. Questa volta però il ricavato doveva servire non solo ad ampliare la collezione, ma soprattutto a garantire un equo salario ai propri dipendenti. «Questa è un’iniziativa basata sulla visione, non sulla disperazione», dichiara il direttore Christopher Bedford. Non è sufficiente. Tutto si ferma a causa di polemiche innescate dalla stampa e grazie a una lettera concisa, nella quale quindici ex presidenti dell’AADM consigliano fermamente di bloccare l’iniziativa. Quattro ore dopo i mandati a vendere vengono ritirati.

Perdite colossali e strada obbligata
Ma il dado è tratto. Che si può fare per salvare l’esistenza dei grandi musei e delle migliaia di persone che vi lavorano? Esistono alternative alla dismissione di opere? Leggendo il The New York Times, sembra di no. Secondo il celebre quotidiano newyorkese il Met Museum, che nell’ultimo anno ha perso $150 milioni, avrebbe dato indicazione ai propri curatori di individuare delle opere adatte alla vendita. Tra queste, possibili doppioni, opere mal conservate o raramente esposte. «Nessuno ha ancora idea di come andrà la pandemia. Sarebbe irresponsabile se non ci pensassimo mentre ancora stiamo in questa nebbia», commenta il direttore Max Hollein. Una decisione, quella del Met -sempre che venga portata fino in fondo- che aprirebbe di sicuro una diga in piena. Assecondando altri precedenti esempi d’una strada certamente percorribile. Come quello del Museum of Fine Arts di Boston – che nel 2011 ha ceduto quadri di Monet, Gauguin, Sisley, Pissarro e Renoir per acquistare, tra l’altro, “Uomo al bagno” (1884) di Caillebotte. O il Brooklyn Museum che nel 2019 ha ceduto “Pope” (1958) di Francis Bacon per sanare un disastrato saldo operativo che ne avrebbe bloccato le attività. Oggi, in sostanza, il deaccessioning potrebbe assumere caratteri più sinistri. Thomas P. Campbell, direttore del Fine Arts Museums di San Francisco, lo descrive come “un percorso scivoloso. Il deaccessioning sarà come un tiro di cocaina per un tossicodipendente. Una scelta rapida, destinata poi a diventare dipendenza. Temo che le conseguenze possano essere altamente distruttive per il mondo dell’arte“. Sembra avere preso una certa assuefazione il Brooklyn Museum, che nell’ottobre 2020 ha ceduto per un totale di $31 milioni opere del super designer Carlo Mollino (record all’asta di $6,1 milioni per un suo tavolo da pranzo del 1965), Monet, Matisse, Degas, Dubuffet, Lucas Cranach il Vecchio. Naturalmente con l’aiuto di Sotheby’s e Christie’s.

Le nuove acquisizioni e il cambio di passo
Ma forse anche nell’anticamera del disastro nascono nuove idee. Sempre Christie’s, nell’ottobre 2020, ha supportato l’Everson Museum of Art di Syracuse di New York, nella vendita di uno dei suoi pezzi più preziosi: “Red Composition” di Jackson Pollock. Con il ricavato (circa $13 milioni) il museo ha però acquistato sette nuove opere realizzate da artiste donne, di colore e di artisti appartenenti a “minoranze” . Che sia questa la vera opportunità nascosta nel deaccessioning? Nell’anno del Covid-19, del Black Lives Matter e della parità di genere, i musei hanno l’occasione di revisionare e ampliare le proprie collezioni. Assecondando i tempi e facendo fede al loro compito primario: documentare la storia e rappresentare la società. Così scopriamo che lo stesso Baltimore Museum, nel 2018 dopo aver ceduto le proprie opere, ha investito parte del ricavato ($2,57 milioni) per acquistare 65 lavori realizzati da 49 artiste donne, 40 di queste mai esposte prima nel museo. Allo stesso modo il San Francisco Museum of Modern Art, che nel 2019 ha guadagnato $50 milioni dalla vendita di un Rothko, nel 2020 ha annesso alla sua collezione 91 opere di Black Artists, di cui 55 acquistate. E così tanti altri musei americani, ma anche europei, tra cui lo Stedelijk Museum di Amsterdam.
Le strategie in Europa e i Italia
In Europa il deaccessioning non ha ancora preso piede. Anche perché in molti Paesi, Italia compresa, i beni pubblici, come le opere d’arte conservate nei musei, sono considerati inalienabili. Così siamo -fortunatamente o sfortunatamente- costretti a cercare delle alternative per rimanere a galla. In particolare il tentativo è quello di dare nuova vita ai musei provando a svincolarli dai grandi flussi turistici alimentati dagli stranieri. Lo conferma Massimo Osanna, da settembre direttore generale dei Musei Statali Italiani: «I musei devono diventare sempre più attraenti per chi vive nel territorio circostante. Devono essere luoghi aperti, spazi in cui si va per ammirare un capolavoro, ma anche per incontrare altre persone o partecipare a un evento».
La speranza è che una simile trasformazione -da tempo suggerita- si verifichi in fretta, ovviamente non appena sarà possibile. Perché lo Stato è reticente a cedere i propri capolavori. Ma il mercato è in agguato, più pronto che mai a riceverli a braccia aperte. Soprattutto di questi tempi, nei quali la richiesta supera di gran lunga l’offerta.
Paolo Manazza e Davide Landoni
copyright Corriere della Sera – L’Economia