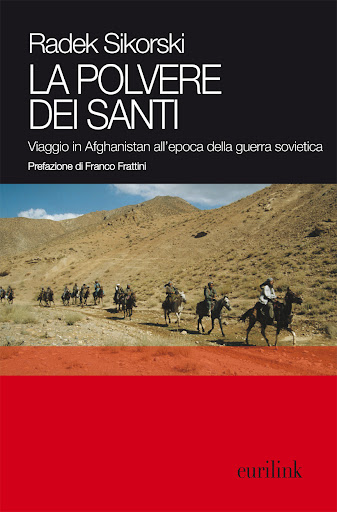Un reportage nell’Afghanistan della resistenza ai sovietici può essere un utile documento per capire gli errori compiuti dai Paesi occidentali e le responsabilità che hanno mancato di assumere. Con La polvere dei santi (Eurilink, pp. 380, Euro 20) Radek Sikorski, uomo politico polacco ma già corrispondente di guerra, ci consegna un importante documento per capire le ragioni di tanti errori compiuti in Afghanistan dai Paesi occidentali.
Roma. Con il violento e drammatico ritorno al potere dei fanatisti islamici, seguito all’indegno abbandono del campo da parte dei contingenti militari dell’alleanza anti-talebana, l’Afganistan è tornato brevemente d’attualità sulla stampa occidentale, quando un’ondata emotiva meramente di facciata ha quasi fatto credere che all’Occidente importasse davvero qualcosa dei diritti e delle libertà di questo popolo oppresso da decenni di guerra. L’instabilità seguita allo spodestamento del Re Zahir Shah nel 1973, portò nel 1978 a un colpo di Stato di matrice comunista appoggiato dall’Unione Sovietica; episodi di resistenza armata su scala sempre più ampia indussero Mosca all’intervento militare per normalizzare il Paese e garantirsi dal pericolo del terrorismo che avrebbe potuto premere alle sue frontiere. In realtà fu una scelta senza ritorno, i cui altissimo costi accelerarono la caduta del regime comunista, che la perestrojka di Gorbaciov non era riuscita a salvare. Il massiccio supporto militare agli insorti afghani aveva principalmente questo scopo: annientare l’Unione Sovietica combattendola per via indiretta, approfittando della resistenza locale. Che, seppur già allora ispirata al fanatismo islamico, era appunto vista con favore dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Gran Bretagna e altri Stati in area NATO, e se ne esaltava il carattere patriottico, sorvolando con particolare “benevolenza” sul commercio internazionale di eroina con cui veniva finanziata parte dell’attività militare. Al resto provvedevano i generosi aiuti occidentali, in primo luogo i missili Stinger generosamente forniti da Washington a partire dal 1986 e che si rivelarono l’arma vincente della resistenza.
I mujaheddin, così erano chiamati i combattenti afghani, godevano delle simpatie occidentali, e molti giornalisti cercavano di accreditarsi presso di loro per documentare la loro attività al fronte. Radek Sikorski, all’epoca corrispondente di guerra per alcune testate britanniche, compì nel 1987 un lungo viaggio nelle zone di guerra afghane, al fianco di vari gruppi della resistenza, condividendo con loro rischi e pericoli e adattandosi alle loro condizioni di vita, sopportando tutti i disagi del caso. Da cittadino polacco in esilio a Londra, simpatizzava ovviamente con i mujaheddin, che combattevano quello stesso regime che ancora opprimeva la sua Polonia, ma quello che emerge dalle sue pagine, non è il semplice racconto combattimenti più o meno violenti; Sikorski andò in Afghanistan anche con lo scopo di cercare di capire le ragioni della resistenza e di conoscere un po’ più da vicino la cultura di un Paese che in Occidente era (ed è rimasta) in larga parte ignota.
Dal libro emerge anche l’esperienza umana vissuta dall’autore: l’orrore provato per i civili vittime dei bombardamenti, gli incontri con giovanissimi combattenti, il doloroso stupore davanti alle distruzioni di antichi e splendidi palazzi che erano un segno tangibile degli ormai perduti splendori afghani. Con obiettività, Sikorski menziona anche quelle violenze commesse dai mujaheddin su chi veniva identificato come traditore. Ma condivide comunque la sostanza della resistenza; oggettivamente, documenti alla mano, è difficile non vedere l’invasione sovietica come un’aggressione militare ingiustificata. La resistenza aveva una sua legittimità, ma per quelle coincidenze storiche, aveva un doppio volto: era già accaduto con i Khemr Rossi in Cambogia, dapprima salutati come i liberatori dalla minaccia statunitense e poi rivelatisi come i carnefici del loro stesso popolo. Per i mujaheddin, o almeno per buona parte di loro, è stato lo stesso, in un contesto politico ancora più complesso; oltre ad aver oppresso i loro connazionali, gli ex combattenti per la libertà si sono molto spesso “riciclati” verso la jihad internazionale, compiendo attentati in molti Paesi occidentali, contro quei popoli che avevano sostenuto la loro causa ma avevano il “torto” di professare religioni diverse dall’Islam.
Se qualche dubbio fu avanzato in quegli anni, fu presto dissipato in considerazione della causa anti-sovietica, e il reportage di Sikorski ha anche, a distanza di anni, valore documentario sull’atteggiamento a volte anche ingenuo, che i cittadini occidentali avevano verso i mujaheddin (molti dei quali, giova ricordalo, erano pakistani). Qualche ombra, comunque, rimaneva. Ad esempio, la resistenza aveva la sua base principale in Pakistan, a Peshawar, dove confluivano gli aiuti esterni; e qua e là, Sikorski lascia capire come non ci fosse un completo controllo sui loro destini, prova ne era il fatto che almeno il 30% delle armi mandate in Pakistan, veniva rivenduto clandestinamente dai soldati di Islamabad. Non sempre a soggetti affidabili, come si sarebbe visto diversi anni dopo. E il caos dell’Afghanistan di oggi, così come la recrudescenza del terrorismo islamico, hanno la loro origine anche nella faciloneria con cui, con il solo obiettivo di affossare l’URSS, furono sostenute entità paramilitari senza indagare troppo a fondo sulla loro vera natura.

Considerazioni storico-politiche a parte, La polvere dei santi è anche, in più di un passaggio, un affascinante racconto della geografia e della natura dell’Afghanistan, con le sue montagne rocciose e i suoi deserti assolati, non privi di quel fascino selvaggio tipico dei luoghi incontaminati. Paesaggi solenni che sembrano rimanere indifferenti alle follie della violenza umana.
Purtroppo, finita l’esigenza della “causa comune” contro l’invasore sovietico, nei primi anni Novanta il fronte della resistenza si spezzò, diviso principalmente su quello che doveva essere il giusto governo islamico da dare a un Afghanistan tornato all’apparenza libero. Ma in Occidente, una volta caduta l’Unione Sovietica, poco importava del destino degli afghani, e con l’abituale cinismo della politica si lasciò che la guerra civile facesse il suo corso, permettendo così il consolidarsi dell’ala islamica più estremista che avrebbe preso il potere nel 1996. Cominciando, anche, la sua crociata contro gli “infedeli”, culminata con l’attentato dell’11 settembre 2001. In pochi avevano intuito il rischio di aver sostenuto con così ampia fiducia, forze paramilitari di cui in fondo non si sapeva molto; fra questi pochi ci fu Mary Kenny, giornalista del Sunday Telegraph che, pur sbagliando nell’appoggiare la causa sovietica, era nel giusto quando accusava i mujaheddin di opprimere donne e bambini, paventando il pericolo del terrorismo islamico; il giudizio, a onor del vero, non era applicabile a tutte le fazioni allora in campo, ma era esatta per diverse di esse. Stranamente, lo stesso Sikorski non colse la giustezza di questa opinione, e nel volume stigmatizza le parole di Kenny. I fatti avrebbero però dimostrato chi aveva visto giusto e chi no. Per cercare di evitare la guerra civile e la deriva islamista, i governi occidentali che avevano sostenuto i mujaheddin avrebbero potuto, ad esempio, vigilare sulla normalizzazione dell’Afghanistan e guidare u processo di democratizzazione o comunque di attenuazione delle istanze più estremiste. Ciò non è accaduto, e per questa ragione nel 2004 cominciò la prima missione in ambito ONU per combattere il regime talebano.
Nella prefazione che Franco Frattini, allora Ministero degli Affari Esteri della repubblica Italiana, scrisse nel 2011 all’edizione italiana del volume, citava con giusta soddisfazione il contributo che i Paesi occidentali stavano dando alla ricostruzione dell’Afghanistan; in particolare, l’Italia era impegnata nella provincia di Herat in una “azione di cooperazione civile e culturale a tutto campo, che”, affermava il Ministro, “continuerà anche dopo la già scadenzata conclusione della nostra presenza militare”. Purtroppo anche l’Italia ha abbandonato l’Afghanistan, interrompendo l’opera di ricostruzione e lasciando quando di buone realizzato in questi anni, alla mercé dei fanatici talebani. Oltre ad aver deluse le speranze di un popolo, sono stati anche vergognosamente vanificati i sacrificio dei 53 militari Caduti e degli oltre 700 rimasti feriti (molti dei quali hanno riportato gravi mutilazioni), durante le missioni ISAF e Resolute Support, dal 2004 al 2021. Un ritiro, quello delle forze ONU, che è stato un vero sfregio al popolo afghano e alla sua cultura, che a parole tutti i governi dichiarano di voler tutelare.
Riscoprire dieci anni dopo il bel reportage di Sikorski è utile per ripercorrere una pagina della recente e travagliata storia afghana, quella pagina in cui sono nati gli errori che a loro volta hanno portato alla vergogna dell’estate 2021. Ed è anche un modo per fare capire le responsabilità di tanti Paesi occidentali.