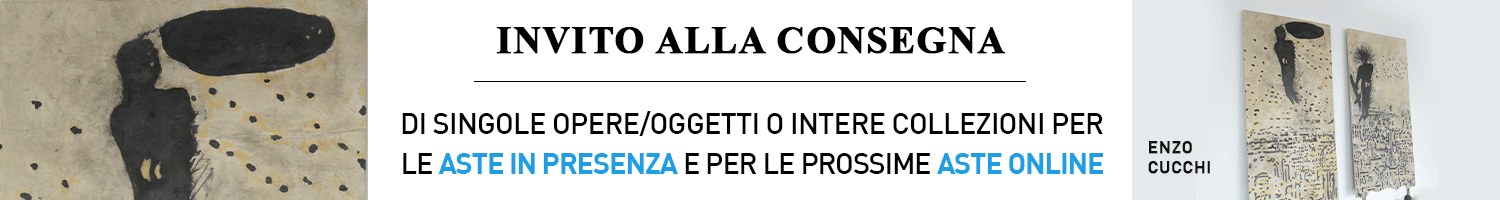Tre storie ispirate a tre fotografie di Joel Meyerowitz. L’artista è protagonista della mostra Joel Meyerowitz. Leica Hall of Fame 2016, organizzata da Leica Galerie Milano dal 25 gennaio al 2 aprile 2022.
Il mondo prima di Joel Meyerowitz (1938) era in bianco e nero. Il colore, almeno in ambito fotografico, era considerato poco utile. Un vezzo da fotoamatore, un espediente superficiale per dare tono a una composizione insipida. É stato l’artista americano a introdurlo nei suoi scatti. Lo ha nobilitato a elemento cardine dei suoi racconti urbani e umani, ritratti ricchi di vita e sfumature. Fu proprio grazie al suo stile – unico, riconoscibile e molto apprezzato – che i colleghi, ma anche l’editoria, iniziarono ad adottare il colore per le loro stampe.
Una portata rivoluzionaria non da poco, tanto che Maurizio Beucci, responsabile della mostra Joel Meyerowitz. Leica Hall of Fame 2016, lo definisce un esploratore. «Spesso si parla di pionieri in fotografia, ma ciò che va riconosciuto a Meyerowitz è invece un ruolo più simile a quello dell’esploratore. Se da un lato il pioniere si insedia dopo la scoperta, dall’altro Meyerowitz ha invece cambiato continuamente direzione nell’arco della sua straordinaria carriera».
Cambiamenti ed evoluzione che la mostra racconta attraverso 50 fotografie. Alcune a colori, altre in bianco e nero. Tutte rappresentanti di uno degli artisti cardine della street photography, qui mostrato nei punti salienti della sua attività. Dalle immagini catturate tra le strade di New York, ambiente perfetto per osservare le vicende della varia umanità che popola la grande città, a quelle raccolte durante un viaggio di un anno attraverso l’Europa a cavallo tra il 1966 e il 1967. Da quelle scattate a Parigi, tra cui spicca quella che ritrae la scena dell’uomo che sviene nella quasi indifferenza totale delle persone che gli stanno attorno, ai paesaggi spagnoli catturate attraverso il filtro del vetro dell’automobile in corsa; da Napoli a Malaga, dall’Irlanda alla Bulgaria, alla Germania, fino alla serie di Londra e del Regno Unito.
Quel che più di tutto emerge dalle opere di Meyerowitz – più del colore, più dell’istante catturato, più della pienezza di sensi che evoca, più della tecnica realizzativa – è il potere narrativo del suo sguardo. In ogni fotografia sembrano contenute varie storie, molteplici racconti sopiti, ma presenti, pronti ad emergere da questo o dall’altro dettaglio. Può anche darsi che alla fine la miccia non si accenda, ma è innegabile che la tentazione ci abbia sfiorato, che una qualche vicenda sia arrivata a noi come in un sogno, come in un ricordo. E a volte tanto basta.
Io tre storie, in altrettante opere di Meyerowitz, le ho trovate. E ve le propongo.
Joel Meyerowitz, New York City, 1975
 Il 25 del mese di gennaio dell’anno di grazia 1975, che era un sabato, iniziò la mia relazione d’amore con Ophelia Bailey, che ebbe termine il venerdì 20 giugno dello stesso anno. Le avevo appena offerto un caffè sulla Fifth Avenue quando New York ci alitò addosso il suo respiro fumoso. Pochi minuti più tardi, mentre a braccetto giravamo nello store di Gucci, mi figuravo gli scaffali intenti ad osservarci, invidiandomi la compagnia. Non potevamo sposarci con il cappotto dello stesso colore, mi implorò, e se io non avessi voluto aspettare, be’, allora mi sarebbe toccato comprargliene uno nuovo.
Il 25 del mese di gennaio dell’anno di grazia 1975, che era un sabato, iniziò la mia relazione d’amore con Ophelia Bailey, che ebbe termine il venerdì 20 giugno dello stesso anno. Le avevo appena offerto un caffè sulla Fifth Avenue quando New York ci alitò addosso il suo respiro fumoso. Pochi minuti più tardi, mentre a braccetto giravamo nello store di Gucci, mi figuravo gli scaffali intenti ad osservarci, invidiandomi la compagnia. Non potevamo sposarci con il cappotto dello stesso colore, mi implorò, e se io non avessi voluto aspettare, be’, allora mi sarebbe toccato comprargliene uno nuovo.
Il cappotto glielo comprai, ma alla fine non mi sposò. Si era fatto tardi, disse; e poi fu sempre troppo tardi, mi accorsi. La chiamavo Degas, perché aveva i piedi di una ragazzina e si muoveva come una danzatrice. Non proprio, in realtà. Ma mi piaceva pensarlo. Mi piaceva anche pensare che lei provasse per me la stessa dedizione che il vero Degas provava per le sue ballerine. Ma si sa che gli amori nati in inverno raramente vedono l’autunno successivo. Ophelia, addirittura, ci tenne particolarmente a rendersi disponibile a nuovi spasimanti entro l’inizio dell’estate.
Joel Meyerowitz, Los Angeles Airport, California, 1976

Guidare gli autobus non mi piace. Però mi piace il giallo e mi piace fare quel che mi dicono che non posso fare. Sono bionda, ma non per questo dovete prendere il mio atteggiamento come una frivolezza. Lo faccio perché sono una seria e profonda amante dello scandalo. Amo sorprendere, meglio se con un pizzico di provocazione. Non ho piacere più grande del gettare nella confusione, di abbandonare nel dubbio i miei passeggeri. Quando salgono quei tre gradini si aspettano di essere spostati da una parte all’altra della città, senza intoppi. Io invece desidero offrire loro un viaggio surreale.
Al volante non trovano solo una donna, che già può insospettire, ma una gran bella ragazza in minigonna e stivali. L’acconciatura è sempre ok e per girare il volante non le serve che una mano. Il sole della California le inonda le cosce e ne illumina le unghie smaltate. Le fermate le annuncia lei stessa, ogni volta in una lingua diversa, e quando finisce le lingue che conosce ne inventa di nuove. É severissima sui biglietti, che devono sempre essere esibiti. In compenso ne accetta volentieri di contraffatti. L’importante è che non assomiglino per niente agli originali. Si impone, una volta al mese, di tamponare una volante della polizia. Per il resto del tempo la sua guida è perfetta. Oggi tiene accanto a sé una scatola nera, più larga che lunga, che sembra vibrare sempre più mano a mano che l’autobus si avvicina all’aeroporto. Lei sostiene che non farà scendere nessuno finché uno dei passeggeri non avrà il coraggio di aprirla. E io vi assicuro che è una ragazza che riesce sempre a realizzare i suoi intenti.
Joel Meyerowitz, New York City, 1963

Non appena entrato si è subito seduto sulla poltrona davanti alla televisione. Poi si è voluto togliere le scarpe e mi ha chiesto di portagli un paio di pantofole. Per fortuna mi ricordo ancora dove le teneva papà, così sono riuscita ad accontentarlo. Dopo aver smanettato per qualche minuto con il telecomando, ha finalmente trovato il canale giusto, quello dello sport.
Io continuavo a giocare con le bambole sul tappeto del salotto. Lui mi guardava con attenzione. Non era male, di solito sono sempre in casa da sola. Poi, all’improvviso, mi si è avvicinato, muovendosi con inaspettata agilità nel suo abito elegante. Sfiorandomi la mano ha afferrato la bambola che stringevo.
«Non hai mai pensato di tagliarle un po’ i capelli?» mi disse.
Silenzio.
«Io sono un parrucchiere, sai?»
Nel frattempo aveva già iniziato ad accorciare la chioma della Barbie con un paio di forbici che teneva in tasca.
«E da quando i parrucchieri entrano in casa delle persone dalla finestra?» avevo chiesto osservando i peli sintetici e dorati unirsi alle trame del tappeto.
A quel punto l’uomo si è alzato e ha fatto un giro della casa, mentre io lo seguivo iniziando a percepire il pericolo. Ho provato a fermarlo, con tutte le mie forze, mentre si riallacciava le scarpe e afferrava il cappotto.
«Scusami, volevo solo provare cosa si prova» mi disse prima di uscire da dove era entrato e reimmettersi nel traffico umano di New York.
Piansi e urlai, a lungo, chiamando un uomo di cui ignoravo il nome.
Quando mia madre, ormai fatta sera, tornò a casa, le raccontai tutto. Non mi credette. In compenso mi tirò un bello schiaffo per aver rovinato la mia bambola nuova.