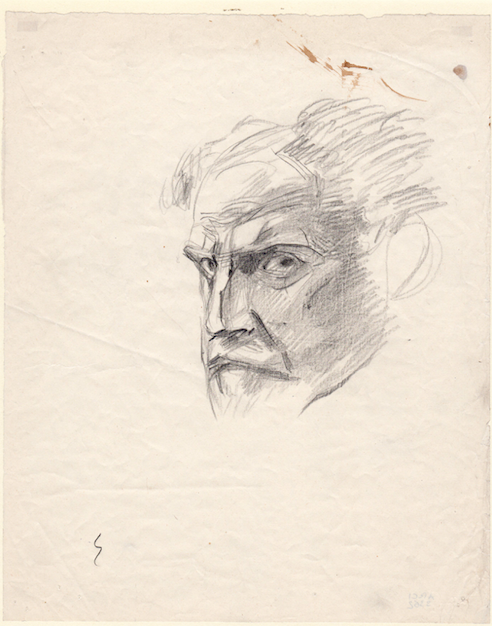Momenti di genio nella postcontemporanea regia di Ai Weiwei per la Turandot messa in scena al Teatro dell’Opera di Roma
– Allora, questa Turandot di Ai Weiwei?
– Mixed feelings, devo confessarlo. Dici bene, comunque: “di” Ai Weiwei. Con la sua prima (e a suo dire anche ultima) regia di un’opera lirica, ha senz’altro firmato quello che può considerarsi un suo vero e proprio lavoro, una gigantesca installazione in situ, cioè realizzata in un autentico teatro d’opera. Un po’ come aveva fatto nel 2017 con il suo film in concorso a Venezia, “Human Flow”. E come quello, anche questa sua “regia” è un veemente manifesto politico.
– Alle spese di Puccini?
– Limitatamente, visti e considerati i disastri combinati da tanti altri registi professionisti, incensati ovunque come “geniali rilettori” di prodotti dell’ingegno evidentemente non ritenuti in grado di stare in piedi da sé in quanto testimonianze di un passato lontano e sepolto. Di Turandot, Ai Weiwei ha conservato l’ambientazione in un altrove fiabesco ed esotico, postcontemporaneamente comprensivo di segni riconducibili al passato archeologico dell’attuale mondo globalizzato, al suo travagliato presente e a un suo ipotetico futuro post-umano, addirittura post-tecnologico. La sua Pechino è una specie di sito arcaico che ospita ruderi molto eleganti e suggestivamente poco illuminati, simili a un Foro Romano in una serata di luna piena. I popolani succubi delle crudeltà e dei capricci della bellissima e glaciale Principessa, le sue guardie e i ministri imperiali, bambini, mendicanti e diseredati vi si aggirano come nottambuli abbigliati in fogge stravaganti (abbondano la plastica, materiali sintetici, tulle, ciniglia) e fantasiosamente creativi: copricapi e altri accessori, come le spade e le alabarde dei soldati, palloncini di carta illuminati dall’interno, maschere, casacche e calzari, a prima vista ricordano l’iconografia tradizionale cinese, ma a guardar meglio, con gli occhi che progressivamente si abituano alla costante oscurità in cui è immersa la scena dall’inizio alla fine dell’opera, ostentano riferimenti diretti ai lessici contemporanei della cartellonistica computerizzata e delle emoji. Sulle teste di Ping, Pang e Pong svettano berretti che rimandano alle stampe cinesi prima della rivoluzione culturale maoista, ma in realtà sono modellati a forma di bomba atomica, di telecamera a circuito chiuso o di manina col pollice alzato. L’algida Turandot è identica alla Lady Gaga dei suoi video più esuberanti. In linea con le cineserie, il principe Calaf è ammantato, ma solo nel primo atto, di un gigantesco ranocchio di pezza (simbolo cinese, pare, della guarigione dalla malattia), che lo apparenta a un ninja dei cartoni animati per ragazzini: l’altra sera alla Prima, all’intervallo, nel foyer del Teatro dell’Opera era tutto un reciproco domandarsi cosa diavolo dovesse significare. La risposta più divertente me l’ha data Sir Tony Pappano, circondato da un capannello di amici e ammiratori curiosi della sua opinione: “È una specialità gastronomica cinese”…

– Non si è sbottonato su altro? Giusto la settimana scorsa Pappano ha diretto e inciso la stessa opera (coincidenza intrigantissima) a Santa Cecilia con Jonas Kaufmann e l’Orchestra dell’Accademia…
– Perciò da gentiluomo ha scelto di non esprimersi, credo, soprattutto a spettacolo non ancora concluso.
– Ma insomma, questo benedetto “messaggio politico” in cosa consiste?
– Ci stavo arrivando. L’intero spazio scenico viene continuamente investito da proiezioni a tutto campo che per tre ore riversano sulla fiaba di Gozzi, sul libretto di Adami e Simoni e sulla musica di Puccini una valanga di concitati videoreportages telegiornalistici che mostrano paesaggi della Cina contemporanea, città caotiche a volo d’uccello, cariche di poliziotti contro i manifestanti di Hong Kong, flotte di canotti zeppi di profughi e migranti, corsie d’ospedale e ambulanze durante le fasi più critiche dell’emergenza Covid a Wuhan, alternati ad animazioni nello stile vetusto della computer-grafica di fine secolo: armamentari nucleari che esplodono in mille frammenti, antichi guerrieri omerici in combattimento contro maoisti in mimetica e bandana… Praticamente un compendio enciclopedico di tutti i mali del Pianeta. Ora, l’abbinamento dell’arroganza del regime cinese (sai bene quanto sia complicata la relazione tra il dissidentissimo Ai Weiwei e il Governo del suo paese) con lo strapotere egoista e capriccioso della Principessa di gelo che dispone a suo piacere della vita e della morte dei suoi sudditi può senz’altro reggere con dignità di senso, ma si stenta parecchio a decifrare il nesso tra le proiezioni che brulicano senza sosta sui fondali, sui corpi e sui volti dei cantanti e del coro, e gli eventi illustrati nel libretto e nella partitura. Affiora la sensazione di una sovrapposizione esagerata di un “sé” del regista a scapito delle intenzioni dell’autore dell’opera in oggetto. Peccato, però, perché con una minore invadenza di contributi filmati, quella certa oratorialità magmatica che tutto avvolge e tracima nella fiumana sonora di una partitura rutilante di romanticismi modernisti e allucinati, Ai Weiwei l’avrebbe azzeccata in pieno. Nonostante che i movimenti di attori e coristi (e danzatori, e mimi) non brillino per genialità di intuizione. Al contrario, tocca semmai registrare il consueto repertorio dei minimi termini delle regie corrette e senza guizzi nei teatri d’opera delle province del mondo. Come dar torto a chi non è riuscito a concentrarsi sui filati di Liù o sulla tensione dei tre enigmi di Turandot perché distratto dalla profusione di lampeggianti, sparatorie, sommosse, voli pindarici e botte da orbi? Eppure in due momenti l’ho provata, l’estasi poetica della contemporaneità, ed è per questi due momenti che sempre conserverò in cuore, di questa regia, un ricordo luminoso di magia teatrale. Uno: quando Ping, Pang e Pong, esasperati di dover amministrare gli umori e le crudeltà di Turandot, sognano di poter tornare nella loro tranquilla casetta di campagna presso il lago blu “tutto cinto di bambù”, sul fondale ho visto scorrere le immagini delle città del mondo deserte durante il lockdown del 2020, il Canal Grande, l’Empire State Building, l’obelisco e le Chiese Gemelle di Piazza del Popolo, la Tour Eiffel con la scritta “Stay home”, e mi sono emozionato nel ricordare come a noi, esattamente come alle tre Maschere dell’opera, fosse impedito di andare dove si voleva per colpa dell’occulto potere di un virus misterioso. Due: quando nell’intro di “Nessun dorma” un coro lontano intona “Questa notte nessun dorma in Pechino”, mentre sono tutti impegnati a scovare chiunque possa rivelare il nome dello straniero Calaf e placare le ire dell’isterica Lady di ghiaccio, ho visto sul fondoscena le immagini notturne filmate coi droni delle strade e delle piazze pechinesi gremite di studenti e manifestanti in favore di Hong Kong che brandivano fiammelle e cartoncini colorati. Là mi son detto: Chapeau, Ai Weiwei.

– E che cosa mi dici della direttrice d’orchestra ucraina? Ti so contrario alle donne sui podii delle orchestre sinfoniche.
– Sono anzi tra i maggiori detrattori dell’idea stessa che una donna possa dirigere musica dell’800 e del primo 900, non certo per misoginia o patriarcale maschilismo, ma per motivazioni che ritengo (ovvio, dirai, sono le mie…) quantomeno degne di riflessione. L’altra sera, sotto la guida di Oksana Lyniv, ho rintracciato nella modesta, il più delle volte modestissima orchestra del Teatro dell’Opera di Roma sonorità ottenute con sapiente e lucida cura per gli impasti timbrici, e più in generale tutto l’ensemble sembrava avere una personalità di voce che mai prima d’ora, nemmeno con Muti, Gatti o Mariotti (per dirne tre fra coloro che ne hanno ottenuto prestazioni convincenti) gli avevo riscontrato. Il mio discorso vale per i momenti più dolci, lirici, intimistici della Turandot, dove con maggiore evidenza si avverte la finissima scrittura orchestrale di un Puccini incuriosito da quanto veniva verificandosi nel ‘900 europeo da quella ventina d’anni e poco più che lui stesso ebbe la ventura di viverci. È stato in questi momenti che, lo ammetto senza alcuna difficoltà, la Lyniv mi ha rivelato aspetti che potrei addirittura definire “inediti” di una partitura che frequento e ascolto da oltre quarant’anni: un algore siderale, una grana pulviscolare vicina a un’idea di musica “concreta”, che tingevano l’angoscia dei pechinesi e la devozione suicida di Liù di un’attonita, vitrea ineluttabilità. Tutt’altra faccenda sono stati invece quei momenti (e nella Turandot ve ne sono parecchi) con caratteristiche di titanica e monumentale drammaticità, dove la bacchetta della Lyniv si è rivelata inadeguata e insufficiente. Perciò dico che tutta la musica a partire, diciamo, da Beethoven e fino allo Stravinsky “russo”, al Bartok del Concerto per Orchestra, o all’Hindemith più autopropellente e barbarico, contiene quei caratteri di titanismo e cavalleresca virilità impossibili da cogliere e restituire col gesto corporale di una donna. Non per ragioni di “debolezza” o “inferiorità fisica”; ma per quella differenza che da sempre, in natura, e alla faccia della fluidità e delle novissime fantasticherie sul gender, corre fra una donna e un uomo. Un direttore d’orchestra non “tocca” la musica (come fanno gli strumentisti, che suonano con le proprie mani il loro strumento: non per niente esistono decine di magnifiche pianiste, violiniste, violoncelliste eccetera, di statura artistica assolutamente pari ai loro colleghi uomini) ma la “comunica” col proprio corpo a chi deve suonarla, a prescindere dalla severità e dall’autorevolezza dei propri toni e dei propri modi. L’aura e il carisma emanato da un corpo femminile, anche nel caso di donne con caratteristiche mascoline, sono estranei al “corpo” della musica di Beethoven, Brahms, Bruckner, Wagner, Mahler, Čaikovskij. Per non dire di Verdi e Puccini. Basta osservare che cosa si muove nell’aria a veder camminare su una passerella un modello uomo e una modella donna. Sarebbe come far danzare l’assolo del ballerino maschio nel passo a due di un qualunque balletto classico alla protagonista femminile. O far cantare “Di quella pira” a Leonora invece che a Manrico… Purtroppo raramente mi ritrovo a discutere di queste cose con chi sappia davvero di cosa sto parlando, e possieda anche soltanto la metà della mia competenza e della mia assiduità in fatto di musica e ascolti…
https://www.facebook.com/people/Anton-Giulio-Onofri/1405664800