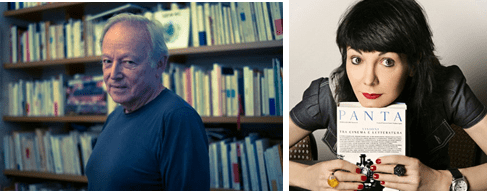Deludono De Maria, Falcone e il “Caravaggio” di Placido, bene invece Roberto Andò con “La Stranezza”
– Èccoti, finalmente. Ce l’hai fatta sospirare, stavolta, la “tua” Festa del Cinema di Roma.
– Chiedo scusa. Ma un festival nella città in cui vivi può rivelarsi ingestibile. A Cannes, Venezia, Berlino o Torino, ti ci trasferisci per quel paio di settimane in cui ti limiti a riservare a tutto il resto qualche mail e un paio di videochiamate, se necessario. Roma è il teatro della mia vita quotidiana, e rubare al tempo che di solito dedichi agli amici, agli appuntamenti di lavoro o dal dentista, alla palestra o allo psicanalista, è un’impresa praticamente insostenibile.
– Con ciò vuoi dire che sei riuscito a vedere poco o niente?
– Non direi. Un bottino complessivo di 20 titoli non può certo competere con la bulimia cinefila dei festivalieri abituali, ma può onorevolmente giustificare un accredito stampa.
– Mai così tanti film in calendario come quest’anno, a Roma. Come ti sei regolato per selezionare queste 20 “perle”?
– Confesso, e me ne scuso, di aver ignorato il concorso. Ma ho aderito all’invito della direttrice artistica Paola Malanga, di scegliere nel mare magno dell’offerta in programma le proposte che per pancia, cuore e intuito mi attiravano di più. Così ne ho approfittato per recuperare un po’ di film passati a Cannes, ben otto, e concedermi qualche anteprima di lusso.
– No stress, insomma. Nello stile romanesco di quella che è ormai per tutti “La Sagra del Cinema”.
– Epperò questa cosa qui non te la lascio dire, sai? Io la difendo comunque, questa Festa che seguo dalla prima edizione: avrà avuto vicende alterne, compresi tre anni stellari ed esaltanti sotto l’egida di Marco Müller che quasi la portò a rivaleggiare con i festival maggiori per qualità del programma e presenza della stampa internazionale (non scordiamocelo mai: è qui che ebbe luogo la prima mondiale di uno dei capolavori più inseguiti e irrintracciabili della Storia del Cinema, “Hard to be a God”, di Aleksej German, defunto qualche mese prima di quello storico evento. Perfino Cannes non era riuscita ad aggiudicarselo). Poi si sa, vuoi per le disgraziate vicende politiche italiane, cui Roma funge da cassa di risonanza, il profilo si è nuovamente abbassato ai livelli del consueto salottino esclusivo fra Capalbio e Manhattan; ciò nonostante trovo che sia sempre preziosa, anzi irrinunciabile l’occasione di poter proporre un’antologia di film selezionati da uno staff di teste pensanti e rispettabili in luoghi di accoglienza pubblica come l’Auditorium Parco della Musica. Non nego il casotto, questo sì “alla romana”, degli stand gastronomici ammassati nel precario giardino antistante i tre topoloni di Renzo Piano, e dell’incongrua mescolanza del pubblico dei concerti dell’Accademia di Santa Cecilia col generone in giacca blu e scarpe marroni cui è riservato il red carpet ove ostentare stelline e starlette. Ma là dove, al buio, la scena se la prende tutta il cinema, ovvero sugli schermi delle sale Sinopoli, Petrassi o Borgna (qualche cinefilo in coda all’ingresso si sarà mai chiesto chi sono costoro?), sgorgano pensieri, le idee circolano, i gusti si affinano: c’è gente, insomma, che è uscita di casa per guardare un film insieme ad altra gente, invece di bivaccare davanti a Canale 5. Ho sempre considerato antipatico e sgradevolmente snob irridere la romana Festa del Cinema, anche quando a guidarla c’era un guitto ripulito capace solo di sfoggiare grandi nomi, che effettivamente venivano, ma ai quali a lui non veniva di meglio che chiedere “Quanto zucchero metti nel caffè?”
– Va bene, chiedo scusa. Non lo dirò mai più. E ora si può avere qualche ragguaglio su quello che hai visto?
– Vorrei esser breve, ma con venti titoli sarà dura. Cercherò, su ciascuno, di dire quel poco che ti servirà a farti un’idea di quanto io abbia gradito o meno, ok?
– Comincia pure. Io prendo appunti. Che ordine seguirai?
– Cronologico. Così come li ho visti. Il primo è stato “Il colibrì” di Francesca Archibugi.
– Balzato fin dall’uscita in sala ai vertici della classifica.
– Com’era prevedibile. Tipico film cucito e confezionato su misura per il pubblico ormai deviato nei gusti e nel veicolare le proprie emozioni dalle modalità delle fiction televisive. “Il colibrì” sembra una miniserie di lusso in onda su una televisione nazionale, dove tutti indossano pulloverini di cachemire sopra colletti coi bottoncini, e provano gli stessi sentimenti che provano gli spettatori che li guardano da casa. Ecco spiegato il consenso ottenuto piallando un libro Premio Strega un tantinello più denso e complesso (e ironico, e graffiante, e cinico, eccetera), ad uso di una Roma Prati che si compiace di tragedie, suicidi e morti premature, a patto che le veda solo al cinema. O in televisione. Gli avrei dato il sei politico se non fosse per la presenza di un Nanni Moretti volutamente fuori registro, che vola altissimo e illumina i minuti in cui brilla sullo schermo. Un tocco di genio indiscusso. Perciò aggiungo un punto.
– Grazie, Sua Generosità! Andiamo avanti…
– James Ivory. Grandissimo narratore e riduttore di grandi scrittori. Nessuno come lui ha saputo adattare per lo schermo Henry James e Edward Morgan Forster. Ho sempre ritenuto che il “Passaggio in India”, riuscito così così all’immenso ma ormai stanco David Lean, nelle mani di Ivory sarebbe uscito un capolavoro. Nel piccolo, affettuoso documentario “A cooler climate” si racconta col garbo dell’anziano californiano (tutti pensano che sia inglese, e invece…) che a 90 anni e passa svela serenamente i suoi grandi amori. Anzi, il suo grande amore, il produttore di tutti i suoi film Ismail Merchant, e dice “Se due uomini gay decidono di realizzare insieme tanti film come ne abbiamo fatti io e Ismail, possono arrivare a dominare il mondo”. Il “clima più fresco” è quello dell’Afghanistan degli anni ’60, dove trentenne si recò a girare del materiale per tanti anni rimasto chiuso dentro un baule, su quel paradiso poi cancellato dai comunisti prima e dai talebani dopo. Il tempo passa, insomma, e non è detto che noi si debba per forza peggiorare con lui…
– Bella questa. Da cioccolatino. Ahahaha… Dai, continua!
– Il bistrattatissimo “Coupez!” di Michel Hazanavicius, il regista più detestato dai cinefili duri e puri per aver attentato alla maestà di Jean-Luc Godard con il suo invero divertentissimo “Le rédoutable” (nemmeno mi ricordo come si chiamava in italiano…). Ha aperto l’ultima edizione del Festival di Cannes, è il remake di un geniale film horror giapponese, ma funziona da Dio, e porca miseria se funziona! Si tratta sostanzialmente di un gioco realizzato in piano sequenza, che ti si svela per gradi, e tu ci caschi in pieno mentre rifletti sulla tua reattività di spettatore, contento di venir preso in giro in maniera così intelligente. Provare per credere, che ti devo dire?
– È già in sala, col titolo “Cut! Zombi contro Zombi”, sicché potrò verificare di persona. Andiamo avanti.
– Poche parole su una commediola manierata e zuccherina, una moderna favoletta “for ladies” anche un po’ attempate e di poche pretese: “Mrs Harris goes to Paris”, tratto da un bestseller (io non ne sapevo nulla) di sessant’anni fa. Cinema che certuni guardano col sorriso stampato in faccia per tutta la proiezione, contenti di apprendere qualcosa che non sapevano sulla Maison Dior, e non soffrono se sullo schermo vedono agitarsi come burattini telecomandati gente della statura di Isabelle Huppert e Lambert Wilson… Not my cup of tea, ecco. Anche se, confesso, Lesley Manville mi è rimasta in memoria, anche a distanza di qualche giorno.
– Qualcosa di italiano?
– Eccolo: due titoli, entrambi modesti, esempi di occasioni perdute e di come la narrazione televisiva abbia ormai definitivamente estirpato anche nei “mestieranti” la capacità di raccontare con un cinema che sappia di qualcosa.
– Chi sarebbero questi “mestieranti”?
– Noi abbiamo sempre avuto i “Grandi Autori”, da Visconti a Fellini e De Sica, da Rossellini a Pasolini e Antonioni; ma c’era anche un esercito di magnifici “mestieranti” di gran classe in grado di sfornare titoli indimenticabili, come “Il sorpasso”, “Io la conoscevo bene”, “La cuccagna” (parlo di Risi, Pietrangeli, Salce; ma pure Nanni Loy, Lattuada, Zampa, Steno, Mattioli, Mastrocinque… e mi fermo scusandomi con quelli che ho scordato). Oggi abbiamo solo qualche autore, dal bravino all’abbastanza bravo (e mai comunque dall’esito garantito), mentre scomparsa è la schiatta di chi sapeva comunque portare a casa un risultato coerente e dignitoso. Alla Festa di Roma sono passati “Rapiniamo il Duce” di Renato De Maria e “Il Principe di Roma” di Edoardo Falcone, entrambi manifesti patenti dell’attuale insipienza che aleggia nelle produzioni al di qua dei confini nazionali. Il problema non sono gli attori, che sono bravi e sembrano crederci più dei registi, né la confezione estetico-artistica, perché scene, costumi ed effetti speciali (almeno là dove paga Netflix, come il film di De Maria dove c’è una credibile ricostruzione della Milano prima del 1945) meriterebbero un plauso convinto. Quello che manca, e che affossa irrimediabilmente l’idea stessa che possa esistere un “cinema popolare” della stessa qualità dei “mestieranti” di una volta, è l’assenza di qualsiasi “mano” riconoscibile e sapiente, in grado di orchestrare e incantare con un ritmo, con un’atmosfera, con un magnetismo carismatico e affabulatore chi non sia ancora assuefatto, come il sottoscritto, alla piattezza che dagli schermi invade a cascata le nostre case… Se la scalcagnata commedia sull’attentato al tesoro con cui Mussolini sarebbe scappato a Salò arranca come un epigono del già insopportabile “Freaks Out”, l’Ottocento romanesco à la Marchese del Grillo del film con Giallini non riesce ad assumere lo spessore neppure della polvere non dico di Monicelli, ma neanche di Luigi Magni, qui evidente modello ricalcato con svogliatezza quasi ostentata… Bocciati entrambi.
– Dunque gli italiani così male, malissimo?
– Poi per fortuna arriva da Cannes, dove era fuori concorso, “L’Envol – Le vele scarlatte” di Pietro Marcello, che di italiano ha davvero ben poco (è tratto da un romanzo russo, ed è però ambientato in una ruralissima provincia francese), ma la mano che racconta è indubbiamente la sua. Stavolta, lo ammetto, non è riuscito, il grande regista di “Martin Eden”, a convincermi del tutto sulla bontà del suo progetto, né posso negare che a tratti affiorasse – ma durante un festival le visioni sono viziate dal sonno scarso e dall’accumulo delle ore davanti allo schermo – un annoiato disinteresse. Però, a metà film, all’arrivo di Juliette Jouan, c’è poco da fare: la sua bellezza e il suo charme d’altri tempi accendono il racconto di una luce talmente radiosa che è impossibile restarne indifferenti. (Onore al merito, manco a dirlo, al sempre ottimo Louis Garrel, capace di rubare la scena a chiunque: anche lui collabora sensibilmente ad animare “L’Envol” di suggestioni erotiche pastorali piuttosto rare nel cinema d’oggi).

– E “L’ombra di Caravaggio” lo hai visto? A giorni esce in sala, non ne ho letto malaccio…
– Ci stavo arrivando. E se la stampa ha applaudito, mi inchino a tanto mistero, e taccio.
– Macché taci! Dimmi, per favore, il tuo parere seduta stante. Sai che do retta soltanto a te!
– Dunque: intanto ti dico che Michele Placido è solitamente un buon regista. Potrei sciorinarti almeno quattro o cinque titoli da lui diretti che mi hanno, se non sempre pienamente convinto, almeno mandato a casa con la pancia piena. Sa maneggiare con mano forse un po’ grassa ma di indubbia efficacia temi sociali e di attualità, con doppio riguardo sia per la tenuta del messaggio politico che per la qualità spettacolare dell’intrattenimento. E ti dirò, con sprazzi lirici qua e là più che azzeccati. Speravo, dunque, che alle prese con il dramma storico, con il film in costume, con la tormentata personalità di un artista della levatura di Caravaggio, ne sapesse tirar fuori un film attraversato da una lava di passione e di follia, un grande spettacolo “per tutti”, ci mancherebbe altro (come “per tutti” è l’arte di Merisi, tra gli artisti più amati e conosciuti a livello planetario), un drammone solido, tragico, a tinte forti, squarciate dalla luce del genio e dell’arte…
– Embè?
– Embè… Una crosta. Questo Caravaggio è una crosta, un dipinto su tela che meglio sarebbe bruciare piuttosto che appenderlo in un buio corridoio scarsamente illuminato e frequentato. Il disagio di Placido alla regia è evidente. Il “passato” gli fugge continuamente di mano, né sa che toni e che cifra adottare per restituirlo. Si brancola tra lo sceneggiato straniero mal doppiato della tv dei ragazzi e la serie B di un cinema esangue e respingente come se ne vedeva sulle tv private locali negli anni ’80, con coloracci sbiaditi, una fotografia confusa, priva di contrasti, velata di un lerciume che sa di lubrico, di sordido… Tutto è finto, goffo, posticcio (non ho memoria cinematografica di un’orgia più grottesca e ridicola di quella allestita a metà film), i personaggi parlano come in un fumetto: addirittura imbarazzanti le prestazioni di due fuoriclasse come Isabelle Huppert e Louis Garrel, mentre Scamarcio, nei panni del protagonista, conserva per l’intero film la medesima espressione immusonita e imbronciata dell’autoritratto dell’artista adombrato nel capoccione mozzato di Golia appena ucciso da David con una mazzafionda. Il contributo all’arte di Caravaggio si limita alla consueta e risaputa aneddotica sul suo carattere rissoso e irascibile, sulla sua ambiguità sessuale, e sui modelli dei suoi soggetti sacri, scelti fra popolani, mendicanti, prostitute. Un minimo di interesse lo desta l’inatteso finale, che accoglie una tesi diversa sulla sua morte (sostenuta anche da Tomaso Montanari), non più sulla spiaggia della Feniglia schiantato dalla febbre per un’infezione, ma…
– No, dai, niente spoiler. Lasciamo che lo scopra da sé chi avrà voglia di andarlo a vedere.
– Giusto. E vedrai che farà pure un sacco di soldi, con l’unanime consenso della critica sui quotidiani. …Sono molto contento, invece, dell’ottimo esordio al botteghino di un altro italiano (udite! udite!) che ha dissipato il cielo nero e stantio dell’ombra di Caravaggio con un raggio caldo e luminoso di luce siciliana: parlo di Roberto Andò e del suo eccellente “La Stranezza”.
– Quello dove Toni Servillo fa Pirandello? È al primo posto degli incassi del weekend.
– Esattamente. Non lo definirei propriamente una sorpresa, perché Andò è magari autore discontinuo, ma conserva sempre un livello di eleganza e professionalità non comuni né scontati. Stavolta ha fatto decisamente centro. E il pubblico, per fortuna!, se ne sta accorgendo. Una storia (finalmente) italiana, raccontata all’italiana con quel misto di grottesca ironia e disincantato cinismo senza mai abbandonare il seminato di un’impostazione che non prevede quelle consuete uscite di senso o i deragliamenti di tono e registro che infestano tanto cinema di casa nostra, specialmente nel genere della commedia. Tra un Servillo/Pirandello compassato scrutatore d’anime e caratteri, e la coppia di impresari funebri nonché teatranti dilettanti interpretati da Ficarra e Picone, imbrigliati con moderata severità senza tuttavia limitarne la franca e contagiosa vis comunicativa, non si sa davvero chi preferire. L’orchestrazione è precisa e calibrata come un orologio a pendolo, la coralità degli ambienti rifugge il macchiettismo alla Tornatore e regala cammei vividi, intriganti, curiosi, e sia che tutta questa storia fosse vera o meno, la sorpresa del finale (che non svelo) arriva dritta al cuore, soprattutto perché con la sua convincente descrizione lirica e un poco smagata di una Sicilia d’inizio secolo (scorso) e la perfetta taratura dei ritmi e dei nodi del racconto, Andò ci dimostra, pirandellianamente, che ognuno, dunque anche il Cinema, ha la sua verità.
– Questo risolleva un bilancio piuttosto scarsino, a quanto pare.
– Tranquillo, che adesso arrivano altri pezzi forti. Ti va una pausa? Ho la gola secca e ho voglia di un Pimm’s.
– Aderisco!
(1. Continua)