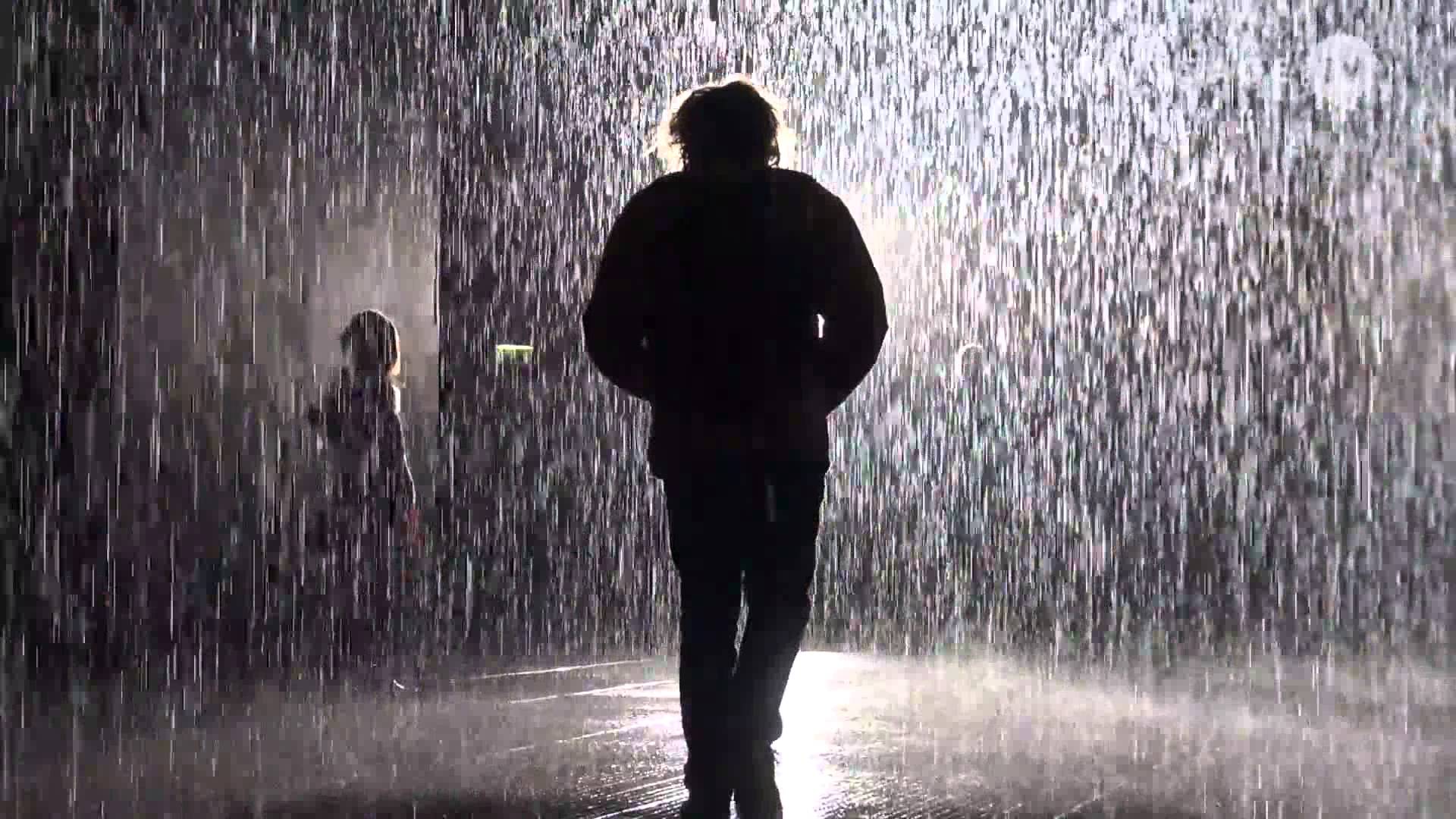Alla Biennale di Sharjah la Hatoum presenta opere pur recentissime di una banalità sempre più disarmante
“Dai diamanti non nasce niente, Dal letame nascono i fior”. Sono passati quasi sessant’anni da quando Fabrizio De André cantava Via del Campo, eppure quelle parole riescono ancora a ispirare grandi artisti. Anzi, no: “grandi” artisti creano oggi opere che ancora paiono ispirate da quelle parole. E che orgogliosamente denunciano davvero tutto, ma proprio tutto, il conseguente “deja vu”. Tradotto: noia. Siamo a Sharjah, alla quindicesima edizione della Biennale del piccolo emirato. E fra i “big” invitati dai curatori, guidati – come dicevamo ieri – dal concept dello scomparso Okwui Enwezor, c’è la libanese Mona Hatoum.
Un’artista dal ricchissimo pedigree, non è questa la sede per rispolverarlo: ma che lancia sempre più preoccupanti segnali di imbolsimento. D’accordo: nella sua pratica artistica la Hatoum – come ricorda la didascalia alla Biennale – “spoglia i temi del conflitto, dell’esilio, delle barriere e del controllo statale dal regno puramente concettuale, presentandoli invece nelle loro manifestazioni come esperienze vissute”. E d’accordo – sottolineavamo – che in questo si sposa perfettamente con il taglio “sociologico” della rassegna.

Ma è ancora accettabile che questo impegno si traduca in concetti di una banalità sempre più disarmante? In dispositivi ormai diventati la quintessenza della più stucchevole retorica? Non riusciamo a dire altro, davanti all’installazione Fossil Folly, opera recentissima – 2023 – della settantunenne artista. 15 barili di petrolio in disuso, mezzo accartocciati, dalle cui lamiere emergono come fantasmi sagome di cactus e palme. “Dai diamanti non nasce niente, Dal letame nascono i fior”…