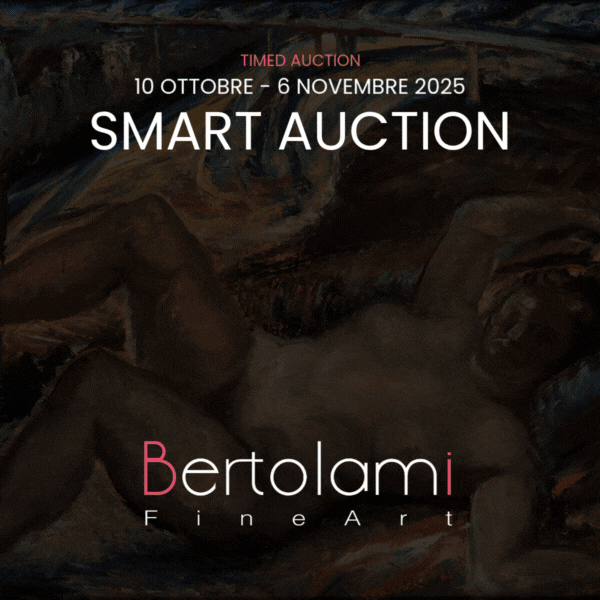Se paragonassimo una città a un organismo, e in particolare una città così stratificata nel tempo come Roma a una coscienza, a una psiche – cosa del resto già intuita da Sigmund Freud – si potrebbe affermare che molti dei fatti di sangue e di violenza testimoniati lungo la storia di quella città siano paragonabili a traumi, il più delle volte ancora perfettamente presenti nella memoria sociale, prima ancora che fisica, della città.
È da questa idea parte la mostra “Le ferite di Roma”, aperta sino al 25 marzo negli spazi della Galleria Mattia de Luca e curata da Spazio Taverna, progetto di Marco Bassan e Ludovico Pratesi, che vuole rileggere, forse esorcizzare, dieci grandi traumi di Roma mai risolti attraverso l’opera di dieci artisti contemporanei. Le ferite scelte hanno tutte a che fare, inutile dirlo, con l’esercizio e le forme del potere che la città di Roma ha espresso lungo tutta la sua storia – potere politico, religioso, di genere – e sono tutti episodi storici, siano essi più antichi o più recenti, in cui violenza e ingiustizia sono stati i motori principali: facile trovarne a iosa nella storia di una città che fu sempre al centro di qualche impero, secolare o spirituale, e che fu fondata proprio su un fratricidio. Di fatti, i dieci episodi sono stati selezionati da un’iniziale rosa di diciotto.
Le regole sono state così definite: individuati dieci artisti viventi, tutti di Roma per nascita o per adozione, è stato assegnato a ciascuno un diverso trauma, e un foglio di carta Amatruda. Nonostante sia stata lasciata la massima libertà al modo in cui ogni singolo artista avrebbe affrontato il tema assegnato, il risultato finale ha visto emergere inattese analogie e risonanze tra i lavori, a dispetto delle pur evidenti differenze nelle singole pratiche artistiche.
Dei delitti di Roma
Il primo crimine scelto per la rassegna è l’accoltellamento di Giulio Cesare, alle Idi di Marzo del 44 a.c., da parte di una congiura di senatori, che segna idealmente la fine della Repubblica romana e la nascita dell’Impero: l’artista Elisabetta Benassi ha deciso di interpretarlo con un pugnale conficcato nel foglio lasciato bianco. L’evidenza così iconica dell’arma da taglio, rimanda in modo naturale all’opera di un’altra artista, Silvia Giambrone, che ha utilizzato le sagome di diversi coltelli, utensili domestici, un’ascia da boia, quasi a ricordarci come la loro funzione possa, tra le mani dell’uomo, trasformarsi bestialmente da innocuo utensile ad arma letale in contesti di violenza domestica: significativo che l’episodio riletto da Giambrone, in linea con un interesse tematico persistente nella sua ricerca, sia proprio la storia di violenza domestica vissuta da Beatrice Cenci alla fine del sedicesimo secolo, condannata a morte per aver ucciso il padre aguzzino e violentatore.

Significativo anche, e in negativo, che tale storia ci appaia ancora dopo più di quattrocento anni così tristemente fresca e attuale. Il colore utilizzato da Giambrone, come a evocare del sangue rappreso, richiama involontariamente quello dell’opera vicina, dedicata da Gabriele Silli all’assassinio di Cola di Rienzo, artefice di un esperimento comunitario romano finito con il suo linciaggio da parte del popolo. L’artista, infatti, traccia con del sangue la pianta di San Marcello a via Lata, chiesa in cui il corpo di Cola venne appeso ed esposto per due giorni.
Due ferite più inerenti il potere religioso, invece, sono trattate da Luigi Ontani e da Enzo Cucchi. Il primo affronta, con il suo solito piglio colorato, ermetico e giocoso, il drammatico processo di Galileo Galilei, ingiustamente processato dall’Inquisizione e costretto all’abiura per aver provato scientificamente la centralità del sole nel sistema solare in disaccordo con le sacre scritture. Enzo Cucchi, invece, decide di evocare una potente ondata di fuliggine e carbone, impreziosita da un inserto di ceramica nera, per alludere al rogo di Giordano Bruno, bruciato vivo a Campo de’ Fiori per aver disquisito nelle sue opere dell’infinità dell’universo, della molteplicità dei mondi e del moto della Terra, ma in contraddizione con i dogmi della Chiesa.

Fuoco chiama fuoco, si sa, ed eccoci quindi ad un altro notorio rogo che fu l’incendio di Roma innescato da Nerone nel 64 d.c., e richiamato nelle caliginose immagini di Marco Tirelli di incendi più prossimi al nostro tempo, certo meno epici, ma che sembrano eternare di quello la memoria al suono del verso «Arde sempre non si estingue».
Ben quattro ferite riguardano il XX secolo, nella sua ricchezza per Roma di traumi ancora non risolti, in certi casi di crimini senza ancora il nome di un colpevole, di vittime di violenza ancora in attesa di una giustizia che ne possa riscattare la dignità. Due di questi episodi hanno a che fare con il Fascismo, e in particolare con la Marcia su Roma, nel riferimento all’aquila imperiale dell’opera realizzata da Pietro Ruffo, e con il delitto Matteotti, nella delicatissima immagine cimiteriale addensata da Giulio Bensasson come fosse un triste spettro ammonitore.
Altri due orrendi delitti, gli ultimi, chiudono la carrellata un passo prima della nostra era, in cui altre ferite continuano a essere inflitte a questa città, ma forse ancora troppo fresche per poterne parlare con equilibrio. Si tratta di due crimini allo stesso tempo notori per fama, ma oscuri, ancora, per dinamica e colpe esatte. Uno è il rapimento di Aldo Moro: Rä di Martino lo ha risolto attraverso il disegno di un bambino – forse paradossalmente l’unico occhio obiettivo, perché ingenuo, perché incosciente, su un fatto così grave – raffigurante la Renault 4, ritrovata in via Caetani il 9 maggio 1978 con il corpo del politico democristiano, che si era reso protagonista del famoso compromesso storico tra DC e PCI.

L’altro crimine, che fu anche contraddistinto dalla presenza di un’auto, è l’assassinio di Pier Paolo Pasolini nel 1975 all’Idroscalo di Ostia, che Lulù Nuti ha voluto rievocare con un foglio scavato, raschiato lentamente nella sua stessa materia, graffio dopo graffio, abrasione dopo abrasione, proprio come il delitto Pasolini è stato e continua a essere consumato anno dopo anno, ipotesi dopo ipotesi, senza mai giungere all’identificazione pacifica di un responsabile.
In definitiva, ogni trauma ha un suo luogo, e un suo tempo, che Roma conosce bene e non dimentica, tanto da potersi quasi disegnare una mappa ipotetica dei tessuti cicatriziali della città. Ma d’altra parte se, come affermato dall’architetto Daniel Libeskind, un trauma non può essere curato, e rimarrà sempre lì, presente, forse conviene provare almeno a comprenderlo attraverso gli artisti.