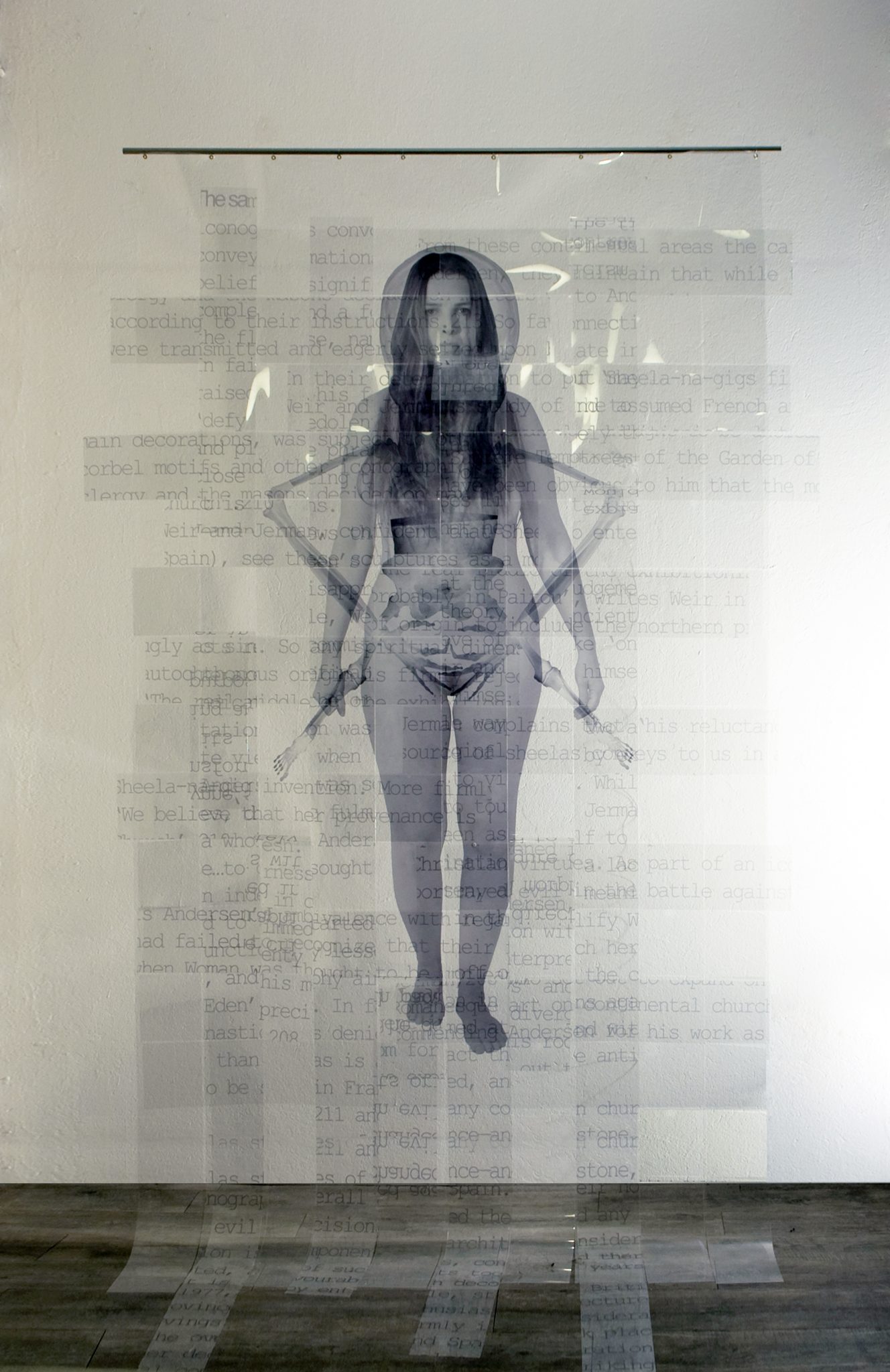La Sala Dogana di Palazzo Ducale, in quel di Genova, ospita dieci giovani artisti e le loro riflessioni sulle fragilità sociali del presente. Tempo in cui ogni diritto acquisito non è più una certezza.
Pubblica ammenda: era un po’ (un po’ tanto in verità) che chi scrive mancava dalla Sala Dogana. Non per manifesto snobismo verso le idee giovani, ma – più probabilmente – per due motivi: o sono state le idee giovani (anzi, le “giovani idee in transito”, come da sottotitolo della Dogana) a scarseggiare, o c’erano, ma non sono state adeguatamente supportate all’interno della comunicazione di Palazzo Ducale. Di conseguenza, non dava affatto per scontato di trovare lì dentro un progetto espositivo come “Lo davamo per scontato” (a cura di Marco Arrigoni e Giacomo Pigliapoco, fino al 18 giugno prossimo), in cui c’è solo ciò che serve: nomi e pezzi pensati, a formare la cronaca di questo periodo storico, in cui la precarietà sul piano globale intacca capillarmente una dimensione soggettiva. Un’epoca in cui a uscirne spiazzate sono soprattutto per le classi più giovani, abituate a dare per scontato diritti socio-personali per cui chi le ha precedute o ha già lottato, o non ha mai avuto interesse a farlo.

Dieci artisti, per i motivi di cui sopra tutti sotto i 35 anni, di cui metà nativi del Belpaese. E non è per patriottismo (nemmeno quello si può dare per scontato in questo periodo storico, ché è un attimo a beccarti del sovranista), ma tre dei lavori più convincenti parlano proprio italiano. Diciamo che Selma Selman, ad esempio, fa bene il suo: You have not idea (Election daa2020) è un video incisivo, lei con soprabito fluo in un crescendo di strilli potente, viscerale, l’espressionismo drammatico di un Edvard Munch in versione video-performativa. Chloe Wise, dal canto suo, propone un ritratto fatto da chi ha mano e testa, un semplice inchiostro su carta in cui convoglia tutta la complessità emotiva di una generazione. Selman e Wise a parte, i nostri connazionali mostrano tuttavia un appeal progettualmente più diretto, figli di una patria in cui il “farsi capire” tramite un linguaggio non verbale è più naturale che da altre parti. “Italians do it better” – Madonna scusa se ti rubiamo la massima – anche in questo contesto, concettualmente allineati su un’idea partenership tecnico-formale che impatta senza troppi arzigogoli mentali. Come la combinazione tra metallo e calzini bianchi in spugna di Davide Stucchi: la sua Ironed moon è davvero un gioiellino. Graficamente indovinata, sul piano pratico è un’ibridazione pensata alla maniera del ready made, per avventurarsi oltre i soliti schemi. Perché singolarmente i calzini sono calzini, la lastra in metallo è una lastra in metallo: i primi te li metti ai piedi (e questi sono anche “vissuti”), la seconda è un oggetto tanto utile sul piano pratico, quanto inutile su quello comunicativo. Touché: certe unioni funzionano – e arricchiscono – molto più delle scissioni.
Far leva sul concetto di unione vale per Stucchi come per Gaia De Megni, tra polarità opposte (un blocco di marmo bianco e uno nero), intersezione tra media su due piedi incompatibili (marmo, appunto, e videoproiezione), universi distanti (il mare proiettato sugli stessi blocchi). Un minimalismo che massimizza il messaggio di inclusione/apertura all’altro da sé, causa fondamentalmente perorata anche da Alice Ronchi con Voglia di tenerezza. Un tondino di ferro lineare forma una scritta non urlata, dove la manualità di ogni lettera segue l’andamento semicircolare dell’arcobaleno. Forma che in tempi recenti è stata assorbita dall’ormai mitico “andrà tutto bene” di pandemica memoria; estrapolata da Ronchi non per veicolare l’ennesimo messaggio di positività globale, bensì una richiesta d’aiuto personale e condivisibile, scritta sottovoce in un tempo sociale che persevera nel sotterrare certi bisogni umani. Per molti poter ricevere/scambiare della tenerezza a oggi è cosa non scontata.