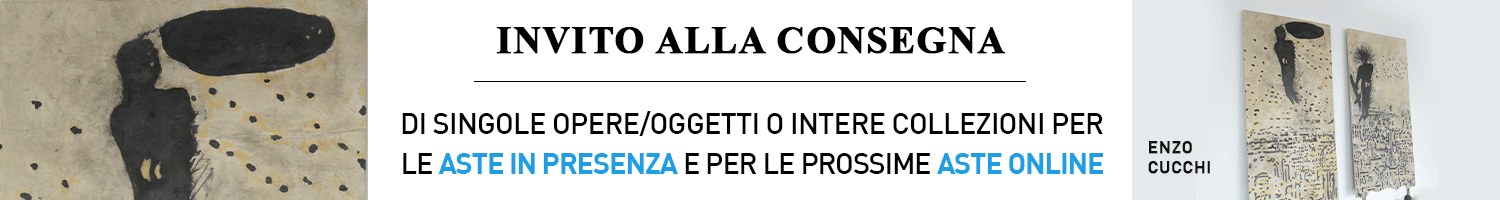Deludono i primi due giorni della Mostra al Lido. Ma i piatti forti devono ancora arrivare…
– È di nuovo Venezia.
– Già. Per fortuna lo stress delle prenotazioni online è stato ridotto a quattro sedute diluite ogni tre giorni. Ciò non ci libera dalle levatacce e dalle lunghe attese come ebeti davanti al display di cellulari o computer. Ma una volta entrati nella piattaforma in sette/otto minuti fai tutto e ti sei assicurato un bel gruzzolo di visioni. Perfino il meteo è favorevole: dopo il preludio piovoso della vigilia, ora splende un sole fresco (ma già minaccia nuove caldane da domenica in poi, anche se più miti della recente asfissia agostana).
– Tutto a gonfie vele, quindi. E i film?
– Ecco, sul fronte cinema l’andazzo è per ora piuttosto scadente. Ma siamo soltanto ai primi due giorni, e i piatti forti devono ancora arrivare.
– Quest’anno poi non ci sono gli americani…
– Sai che non la trovo una mancanza così grave? Ultimamente hanno portato al Lido parecchie cantonate inguardabili.
– Molte, però, hanno trionfato agli Oscar.
– E che significa? È già qualche anno che le statuette non sono più garanzia di qualità autentica. A noi invece interessa solo quella, anche quando non viene riconosciuta con palme, leoni e ometti dorati con le braccia conserte…
– Niente di buono, dunque, finora?
– Qui al Lido, no. Salvo un caso, che mi tengo per ultimo, per finire questa conversazione in bellezza.
– Cominciamo col film d’apertura: uno dei sei titoli italiani in concorso.
– Yes. “Comandante” di Edoardo De Angelis, tornato al cinema dopo tre commedie di Eduardo e una serie, tutte per la televisione. È la storia, vera, del Comandante di un sommergibile della nostra Regia Marina che a Seconda Guerra Mondiale appena iniziata conduce in porto una nobile impresa che non sto a raccontarti per lasciarti addosso quel minimo di curiosità.
– Un Comandante fascista, quindi.
– Se lo chiami fascista, lui, che è Pierfrancesco Favino in versione lagunare (mancava, forse, il veneziano al suo catalogo di dialetti italiani sfoggiato in decine di film usciti in questi ultimi 15 anni) si incazza di brutto. Preferisce “un uomo di mare”, e alla fine è un buon diavolo tutto d’un pezzo, che trova la giusta parola per ciascun membro del suo equipaggio adunato da ogni anfratto della Penisola. L’intento, con l’aiuto di Sandro Veronesi, autore a quattro mani insieme allo stesso De Angelis, della sceneggiatura pubblicata da Bompiani, era quello di mostrare dei militari italiani impegnati in un’azione bellica senza necessariamente dipingerli come esaltati proni e devoti a Benito Mussolini, ma gente semplice, lontana da casa e dalla famiglia, coinvolta in qualcosa di molto più grande di loro, come tutti i soldati da sempre impegnati in tutte le guerre che furono, sono e saranno (il film è preceduto da un esergo riferito al conflitto russo-ucraino in corso). Può darsi che tutto questo funzioni sulla carta stampata. In un film sono necessarie una coerenza narrativa e una regia che sappia dipanare con dosaggio accurato l’accumulo delle emozioni e della reattività dei personaggi senza forzature e manierismi che compromettano la naturalezza del risultato. De Angelis, purtroppo, si abbandona qui e là ad estetismi non necessari, e ad altrettanto incongrue “uscite di senso” (perché mai un manipolo di soldati nel 1940 dovrebbe intonare in coro, per darsi coraggio, una famosa canzonetta di trent’anni più tardi?), come se l’angusta e claustrofobica ambientazione all’interno del sottomarino giustificasse l’impianto teatrale dei dialoghi e delle scene d’insieme, scordandosi a tratti del “cinema”. Sorge addirittura il dubbio che l’intera impostazione di un racconto per parole e immagini giocato sulla smorzatura, sulla sottrazione e sul vedo-non-vedo, sia un effetto espressamente voluto da De Angelis. Effetto che tuttavia, abbinato ad una troppo frequente inadeguatezza tecnica di inquadrature e messa a fuoco (in netto contrasto con la leccatura di quei manierismi che ti dicevo, e che sembrano dei malriusciti copia e incolla dai primi film di Paolo Sorrentino), sfocia nel fallimentare.
– Ho sentito che qualcuno lo ha definito “un film meloniano”…
– Le consuete scemenze da Festival. Tutto nasce da una battuta di Favino, al quale (ma attento: faccio un mini-spoiler) il capitano della nave belga affondata dal sommergibile italiano e tratto in salvo insieme al suo intero equipaggio dice che al suo posto lui avrebbe fatto fuori tutti i prigionieri: “Come mai, invece” gli chiede “ci avete salvati?”. E Favino risponde “Perché siamo italiani”. Una battuta bella e felice, a mio modo di vedere. Ovvio che a molti tendenziosi possa suonare come “Italiani brava gente”, ma a pensarci su, un paio di secondi sono sufficienti a riflettere su come ogni altra popolazione europea abbia una caratteristica comune: la compattezza. A un tedesco (per non dire a un nazista di quegli anni lì), a un inglese o a un francese, mai sarebbe venuto in mente di disobbedire a un ordine dall’alto. Gli italiani, anche quelli del “Ventennio”, proprio perché – e non sono affatto luoghi comuni – fantasiosi, indisciplinati e impossibili da irregimentare, possono riservare delle sorprese. Non tutti, naturalmente. Ma un italiano indomito, ribelle, solitario e forastico, innamorato di una moglie giovane e bella che a casa lo aspetta insieme alla creatura che porta in grembo, un “uomo di mare”, sì.

– Dimmi adesso del nuovissimo film di Liliana Cavani, Leone d’oro alla Carriera di questa ottantesima Mostra del Cinema. Un titolo rovelliano: “L’ordine del tempo”.
– Guarda, poiché le voglio bene (ho avuto modo di farci una lunga chiacchierata e ti garantisco che è una donna coltissima e molto simpatica), ed è comunque una Grande Signora del nostro cinema che ha azzeccato in carriera un paio di colpi indiscutibili e indimenticabili, non mi sbrodolerò troppo nel liquidare questo film di imbarazzante pochezza. È liberissimamente ispirato, come hai detto tu, alle considerazioni sul tempo e sulla sua percezione contenute nel saggio di Carlo Rovelli (pubblicato da Adelphi) che porta lo stesso titolo, intorno alle quali la Cavani e i suoi sceneggiatori cuciono una pretestuosa trametta: la breve vacanza in una casa sulla spiaggia di Sabaudia sotto il Circeo (la stessa di “La voglia matta” di Luciano Salce, “Il compleanno” di Marco Filiberti, “La Luna” di Bertolucci…) di una mezza dozzina di radical chic capitolini, mediamente felici, mediamente infelici, mediamente isterici per via delle rispettive e incasinate relazioni sentimentali, qualcuno con figlie (e figli) appresso. Si finge che sia estate, ma il film è stato palesemente girato in inverno (la spiaggia è deserta…), e gli attori in bermuda e camicetta non riescono a mascherare il freddo cane che li congela… A un tratto trapela la notizia di un meteorite che, come 66 milioni di fa, potrebbe da un momento all’altro schiantarsi sulla Terra e ciao per sempre spiaggia, casa, patio, carbonara, tisane, bermuda, caschi e motorini, gite in pattino, viaggi in vetta all’Himalaya, meditazioni yoga, Leonard Cohen, sedute dallo psicanalista, battutine feroci tra coniugi per fare finta di ignorare le corna dell’altro… Pare un film di Ozpetek lavato in lavatrice con la candeggina decolorante. La regia c’è, o meglio, il tentativo di tenere insieme secondo il criterio della briglia sciolta diversi puledri di razza (i più convinti, e convincenti, tra gli attori sono Alessandro Gassman, Valentina Cervi, e pure Claudia Gerini), ma la sensazione è quella di una precaria e scombinata cavalcata senza sella. Chi ne esce maluccio, costretto a ostentare un broncio da bambinone in castigo praticamente per l’intero film, è Edoardo Leo. Ma anche lui mi è simpatico, perciò mi fermo qui. Ma è impossibile non registrare un tonfo in finale di carriera (augurando alla Cavani, che va per i 91, di campare altri cent’anni e di dirigere altrettanti film) che lascia l’amaro in bocca.
– Che disastro. Ma avevi promesso una ciliegina dolce finale…
– Aspetta, aspetta. Restiamo in Italia, così non andiamo fuori tema. Anche se il film è tutto made in USA: “Ferrari” di Michael Mann. È forse, finora, la visione più sgradita del Festival. Un film sulle cui spinte motivazionali è lecito avanzare forti, fortissime perplessità. Michael Mann è un regista che non rientra tra quelli che mi fanno battere il cuore, ma ha un suo rispettabilissimo stuolo di fans che lui è riuscito a intortare con quelli che per loro sono calcolata freddezza, lucido understatement, allucinata metafisica del disagio metropolitano; per me sono semplicemente mano morta, banalità e inerzia espressiva. Sai tu dirmi che ci azzecca un autore di Noir (che peraltro da “Heat”, che ha ormai quasi 30 anni, non riesce più a uscirsene con un film di qualità almeno decente) con la storia tutta italiana di Enzo Ferrari e delle sue leggendarie automobili da corsa? Forte era il timore che si ripetesse lo sfacelo perpetrato da Ridley Scott con quell’ “House of Gucci” che tuttavia, al confronto, pare “La caduta degli Dèi” di Luchino Visconti: si sa, quando gli americani vengono in Italia a raccontarci storie italiane alla loro maniera, con quei “Buongiorno signora” infilati in mezzo all’eloquio in inglese, l’imbarazzo gronda dalle pareti, ma stavolta si va ben oltre la rappresentazione scorretta dei luoghi e dei modi del Belpaese, che considererei peccatucci veniali se tutto il resto fosse stato trattato con mano ben diversa. La cosa più sconcertante è la qualità del racconto cinematografico, molto vicina a quella di uno scadente film televisivo. Per quanto le ricostruzioni di interni e di ambienti siano piuttosto puntuali, le inquadrature, i movimenti di macchina, la tecnica di ripresa adottata per le sequenze automobilistiche, per le prove su pista e per le gare sportive più impegnative, sono di una piattezza e di un’assenza di fantasia e spettacolarità che in un film del 2023 lasciano di stucco, e, quel che è peggio, annoiano da morire! Avrebbe forse giovato una riguardatina a film gloriosi come “La 24 ore di Le Mans” del 1971, o “Indianapolis Pista Infernale” del 1969, diretti da solidi professionisti non certo annoverati nell’Olimpo dei grandi nomi di Hollywood, eppure fantasmagorici ed efficacissimi nel restituire la tensione e l’ebbrezza della velocità delle corse automobilistiche. Qualcuno ha detto “Ma non è questo che interessava a Michael Mann”: il bello è che risulta difficoltoso indovinare che cosa davvero volesse raccontare l’autore di un film così dozzinale, addirittura volgare nella sua corriva superficialità. Fin dalle prime battute è evidente che a ricostruire sullo schermo il sogno di un idealista costruttore di vetture da corsa è qualcuno abituato a maneggiare ben altro, e si ha la spaesante sensazione di ritrovarsi in un film di gangster, dove tutti indossano, sulle loro inespressive facce di tolla, occhiali scuri. Mentre invece siamo nella Modena degli anni ’50, dove dovrebbe essere tutta una profusione di gnocco fritto, salama da sugo e Lambrusco! Le vicende intime della famiglia Ferrari (un figlio morto giovanissimo, un amore coniugale esaurito, un’amante con un figlio segreto mantenuti all’insaputa della moglie perennemente sull’orlo di una crisi di nervi) vengono illustrate con un algore degno di un soap anni ’80 ambientata a Manhattan, non nella graziosa Modena della Ghirlandina, dei palazzetti neoclassici, delle case di mattoni rossi (e dei carrelli di bollito con la mostarda). Insomma, sembrava impossibile fare peggio di “House of Gucci”. Michael Mann ci è riuscito.
– E Adam Driver? Non funziona nemmeno lui?
– Sai bene che per me Adam Driver è il più grande attore vivente under 45. Qui, truccato e imbolsito da omone maturo coi capelli imbiancati sembra un facoltoso mafioso italo-americano del Midwest. Pur con tutta la buona volontà (e i soldi! Il film è prodotto da lui…) impiegata in un progetto del genere, il verdetto è la piena bocciatura.

– Dio santo, che catastrofico inizio di kermesse… Adesso però chiudiamo, come avevi detto, “in bellezza”. O sbaglio?
– Non sbagli. Sarò breve, perché quando qualcosa funziona a meraviglia, cammina da sola e non c’è bisogno di ulteriori discorsi. È una specie di sorpresa, perché come forse saprai non sono mai andato in estasi per Pablo Larraìn, amatissimo invece dalle frange più “engagé” della cinefilia. Di lui ho praticamente adorato esclusivamente “Jackie”, visto peraltro qui a Venezia qualche anno fa. Tutti i suoi precedenti, salvo forse l’ottimo “Neruda”, mi hanno sempre lasciato indifferente. Ma questo suo mirabilissimo “El Conde” mi ha conquistato totalmente. Un pamphlettino, un raccontino gotico dove si immagina la vita di Albert Pinoche, un vampiro highlander nato a metà ‘700 nella Francia pre-rivoluzionaria, che succhiando qui e là attraversa i secoli e nel Ventesimo del Millennio scorso diventa dittatore in Cile (Pinoche-t…). Uno scherzo tra il macabro e il garbato, elegantissimo – la fotografia e tutto l’apparato estetico e visuale del film sono di una finezza da bibliofili – venato di un umor nero piuttosto feroce, però mascherato dalla qualità della scrittura (l’intera storia è raccontata da… No, non posso rivelartelo senza spoilerare quello che è il colpo di scena più geniale del film!), e illuminato da una sapienza immaginifica stupefacente. Per ora, da Venezia è tutto, con la speranza di darvi info e news sempre più allegre.
– Ma Luc Besson e Wes Anderson?
– Io non vado a vedere i film di questi due signori.
– Ah, capisco.