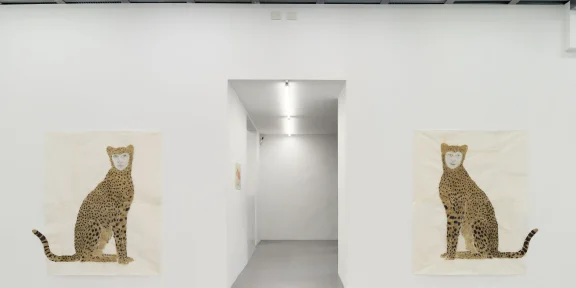Ristoranti, pizzerie, bar, pub. Le strade di Trastevere non permettono pause né ripensamenti per chi le percorre a piedi, facendo uno slalom tra le decine di imbonitori intenti ad acchiappare i turisti mordi e fuggi che affollano strade, vicoli e piazza del quartiere. Ma il 1 dicembre scorso, in questo marasma gastronomico di infimo livello, è nato Supernova, uno spazio multiculturale gestito da Gabriele Giugni che ha affidato al giovane Niccolò Giacomazzi la cura delle prime tre personali di emergenti: il duo Mozzarella Light con “Puramente Immaginabile”, Valerio D’Angelo con “Space House” e oggi “Misure di una distanza” di Daniele di Girolamo.
Due installazioni occupano i due piani dell’ambiente: ad accogliere i visitatori tre coppie di cardi che ondeggiano nell’aria cercando di toccarsi, attaccati a lunghi fili di ottone che nascondono fili elettrici, permettendo di ruotare su se stessi, mentre nel piccolo ambiente sotterraneo tre sculture di materiale plastico, riempite con sabbia, simulano il rumore delle onde marine sulla risacca. Entrambe le installazioni vengono interpretate da Giacomazzi come una metafora del “rapportarsi con l’altro e ascoltare i flussi interiori della propria memoria”. Ottima e coraggiosa la proposta di Supernova, che riserverà in futuro nuovi appuntamenti di qualità come questa mostra del giovane di Girolamo, promessa dell’arte emergente capitolina.

Lo stesso Valerio D’Angelo è protagonista della personale “Too far for light to travel” alla galleria Valentina Bonomo, giocata su tre installazioni legate al percorso della luce nello spazio, tra le quali What do we see when we stare into darkness (2024), proiezione di un frammento di pellicola su una parete del cortile della galleria. L’opera più convincente è Too far for light to travel (2024), composta da 8 colonne in perspex trasparente che contengono una pellicola in grado di rendere visibile i fasci di luce. “L’altezza totale delle colonne – quindici metri, si riferisce alla distanza di quindici miliardi di anni luce percorribile dai fotoni prima di esaurire la loro energia” puntualizza Flaminia Ciuferri. Un lavoro forte e preciso nella sua essenzialità, che occupa lo spazio in maniera minimale ma di notevole suggestione poetica.

Un’altra galleria aperta di recente che punta sugli emergenti è Divario, nel cuore del quartiere Prati, dove fino al 12 aprile è aperta “Natural Disaster”, prima personale di Francesca Cornacchini, che ha trasformato lo spazio della galleria in un luogo dove materiali del quotidiano assumono un aspetto quasi sacrale. Incorniciata da Incendio: allegoria del fuoco (2024), una pannellatura in ferro zincato, che reca le tracce di bruciature di fumogeni, l’opera Il Sole (2024), composta da una serie di tute sportive cucite quasi a comporre una trama di segni e loghi, introduce visivamente le altre opere della mostra, collocate alle due pareti laterali della galleria. Un paesaggio di rovine di una civiltà trascorsa, un “cammino nel caos” che l’artista ha costruito con rigore e consapevolezza, ci ricorda la fragilità della nostra società, costretta tra rituali consumistici fine a sé stessi e sempre più privi di senso, in un presente già trascorso e un futuro incerto. “Il presente è passato da indefinibili anni, Nuovi angeli abitano la Cattedrale del Disastro naturale” scrive l’artista, capace di creare un ambiente carico di una tensione invisibile ma palpabile.

Più complessa e a tratti indecifrabile ma non priva di interesse la personale di Alessandro Di Pietro “Ghostwriting Paul Thek: Time Capsules and Reliquaries”, curata da Peter Benson Miller e Cornelia Mattiacci alla Fondazione Nicola Del Roscio, uno degli spazi romani più aperti alla sperimentazione. In questa occasione l’artista presenta alcune nuove sculture, un dipinto e un video ispirati alla vita di Paul Thek, artista americano vissuto a Roma nella seconda metà del secolo scorso. Grazie al sostegno dell’Italian Council, Di Pietro ha reinterpretato la figura di Thek come una sorta di ghostwriter, proseguendo idealmente nel presente la sua ricerca. Tra le opere esposte in questa sovrapposizione concettuale e formale l’opera più efficace appare To Wong Attributed to Paul Thek (2017?) composta da due scudi in bronzo accoppiati, che custodiscono e nascondono una bobina cinematografica, destinata a spettatori del futuro e forse legata alla vicenda dell’attivista Joshua Wong, leader delle rivolte di Hong Kong nel 2014, arrestato e condannato tre anni dopo. Interessante anche Race of a hippie (2023) che reinterpreta alcuni momenti dell’esistenza di Thek, e le sculture Prehistoryboards (2020), tre lastre di alluminio con frammenti di frasi tratte da autori come Mike Kelley e Chris Kraus.

Poetica e disturbante “Nummer eenentwintig-palpable futility”, la personale dell’artista olandese Guido van der Werve, aperta fino al 22 marzo da Monitor: l’eccezionale qualità di narratore visuale di Guido è espressa con tre lavori video corredati al suo primo lungometraggio, Nummer achtieen-The Breath of Life. Un percorso incentrato sul rapporto tra la vita e la morte, che si sviluppa attraverso tre tappe: se akte negen, futility (2023) è una riflessione simbolica sul senso della vita, sia akte twee, what if (2023) che akte tien, spice of life death drive (2023) raccontano episodi quotidiani incentrati sulla negazione della vita attraverso il suicido, con risultati emotivamente impattanti sullo spettatore. In una città che vive un periodo di torpore delle istituzioni museali, la scena emergente appare invece percorsa da una promettente vitalità.