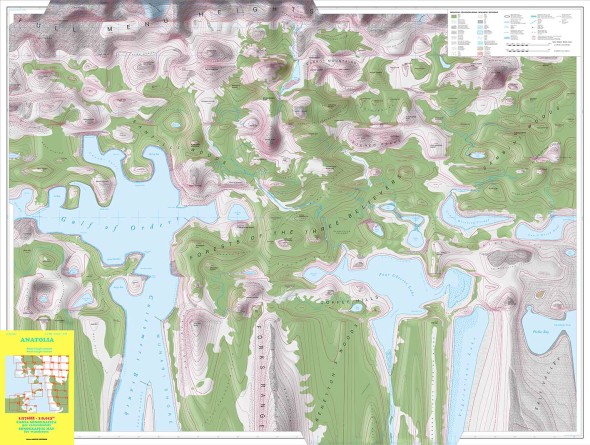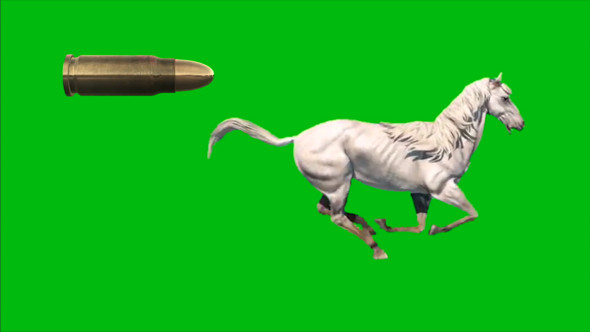“Ciao Marta. Richiedo tuo aiuto. Mi servono le famiglie adesso. Hai presente la scorsa puntata di Replay! com’erano le famiglie? Classiche. Mi servono al volo e poi le convinco io. Su Milano. Mamma papà uno o due figli.”, si legge in uno degli ultimi messaggi che ho ricevuto da Alessandro Sambini (Rovigo, 1982; vive a Milano) e da qui comincia la nostra chiacchierata, di cui questa intervista è solo un estratto.
Bisogna inerpicarsi su una ripida scaletta metallica, che ricorda quelle di alcune cabine di regia, per raggiungere il suo studio soppalcato, pieno di monitor, strumenti musicali, appunti difficilmente decifrabili.
In questo periodo sei stato molto impegnato con la nuova puntata di “Replay!”, che hai preparato in occasione di una collettiva organizzata durante la Biennale di Venezia. Di che cosa si tratta?
«Si tratta della seconda puntata dello show diretto da Igor Cova, che è stata presentata all’interno di “Flags”, mostra a cura di Elena Forin a cui sono stato invitato dalla galleria Michela Rizzo. È una trasmissione televisiva in cui famiglie normalissime si sfidano nel tentativo di rifare un video, spesso legato all’attualità, diventato famoso sui media. Ogni puntata ha un tema diverso, in questo caso “Atti iconoclasti del passato”. “Replay!” sfrutta la necessità dimostrata da diversi utenti di YouTube di reinterpretare video già esistenti. In un mondo filtrato e vissuto tramite immagini, gli spettatori sono frustrati dall’incapacità di agire, di far qualcosa per cambiare quello che stanno vedendo. Sono coscienti che quanto è accaduto è irreversibile, accettano questo patto e creano una nuova regola: se non posso modificarlo realmente, allora mi prendo il diritto di ricreare quell’immagine e di variarne gli addendi. È in questo ecosistema visuale che si collocano le famiglie di “Replay!”»

Chi è Igor Cova?
«È un regista sintetizzato chimicamente. Tentare di identificare Igor Cova mi ha forzato a cercare di capire la struttura in cui colloco “Replay!”: un mondo altro, dove esistono trasmissioni tv slegate dall’aspetto commerciale. I tre milioni di euro in palio sono come il milione che veniva dato al Signor Bonaventura, che non alimentava l’economia mondiale. Queste famiglie in una trasmissione reale sarebbero carne da macello, nel mondo di Igor Cova non lo sono. Ma Igor Cova non sono io, ovviamente».
Il tema di questa seconda puntata è “Atti iconoclasti del passato”. Come l’hai scelto? Si lega in qualche modo a “Varva. Quello che avrei voluto vedere”, uno dei tuoi ultimi progetti?
«In entrambi i casi si tratta di video che non avrei voluto esistessero. Attraverso la loro riproposizione ho la possibilità di cambiarne l’esito, come appunto in “Varva”, oppure di replicarli fedelmente, come nel caso di “Replay!”».


Che cosa ti spinge nell’una o nell’altra direzione? Mi parli meglio di “Varva”?
«Il regista è diverso: nel caso di “Replay!” è Igor Cova; nel caso di “Varva” è Alessandro Sambini. Il cambiamento che le famiglie di “Replay!” potrebbero realizzare, lo faccio io. “Replay!” è un progetto sull’affezione alle immagini; “Varva” è una mia aspirazione. Un video in cui viene messo in scena un evento che ricorda esteticamente un’esecuzione di un giornalista americano da parte dell’Isis. La forma è simile, la sostanza opposta. Ciò che vediamo in televisione o su un computer condiziona però la percezione di quanto ci accade».
Abbiamo già discusso di questo più volte: attribuisci più importanza all’aspetto performativo o alla documentazione dello stesso? Non penso soltanto a “Replay!”, ma anche a “One is dead” e a “The Great Saga of the Infamous Image”, per esempio.
«In questo caso si tratta di una trasmissione televisiva e l’aspetto documentativo non esiste, a meno che non si consideri ogni trasmissione televisiva – intesa come video di una certa durata che viene proiettato su di uno schermo – la documentazione di una performance. Ho rispetto per gli spettatori in sala e per questo il lavoro performativo cerca di soddisfare la loro esigenza di spettacolo.
Credo, quindi, che nessuna delle due componenti abbia maggiore importanza, semplicemente la documentazione è più longeva. Ma, ancora una volta, non penso che il video di “Replay!” possa definirsi documentazione di una performance, poiché le telecamere televisive sono istruite e viziate da una regia che indica quando guardare, cosa e per quanto tempo, creando una litania precisa e troppo lontana da ciò che è accaduto realmente».

Questo vale anche per “One is dead”, per “The Great Saga of the Infamous Image”?
«Durante la proiezione della prima puntata di “Replay!”, al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano nel 2012, il presentatore della serata era Uan, storica mascotte del programma televisivo “Bim Bum Bam”. La serata fu interrotta, perché Uan si sentì male, arrivarono i soccorritori con l’ambulanza, ma tutto fu inutile: morì quella sera. Ecco “One is dead” e in questo caso credo sia corretto parlare di documentazione. Cosa è rimasto di quella performance? Nulla di scritto, nulla di visibile, solo il passaparola e la narrazione che ognuno degli spettatori potrebbe fare di quanto accaduto in quella sala.
In “The Great Saga of The Infamous Image”, processo che mi ha visto sul banco degli imputati per l’appropriazione di un’immagine di cui ho rivendicato la paternità pur non essendone l’autore, il pubblico non c’era. C’erano le camere, istruite e addomesticate. Il risultato, di nuovo, è una trasmissione televisiva».

Il riferimento alla dimensione famigliare e quotidiana è trasversalmente presente in diversi tuoi lavori, anche più datati e con spunti autobiografici. In essi ci sono interferenze continue tra mediaticità e quotidianità. Per questo tue fonti principali sono la televisione e YouTube?
«Rifletto costantemente sulla produzione di immagini e sull’influenza che questa nuova creazione può avere in un contesto diverso dall’originale, soprattutto visto che oggi a tutti è data questa possibilità di invenzione di significato. Mi interessa qualunque prodotto audiovisivo creato da altri, sia esso una trasmissione televisiva o amatoriale. Per questo attingo da YouTube, come raccoglitore di video realizzati e diffusi senza mediazione, ma decodificabili attraverso i tòpoi che riconosco come spettatore».