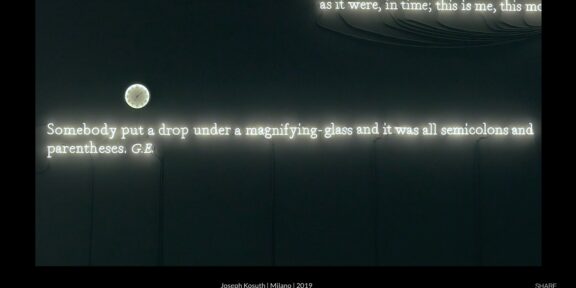Un universo in bilico tra realtà, mito e sogno. L’immaginario di Marta Spagnoli (Verona, 1994) prende forma (e vita) nella sede di Galleria Continua a San Gimignano. Una prima personale di assoluto livello che porta l’artista veneta alla ribalta nazionale, con prospettive che vanno ben oltre i confini italiani. Una pratica e poetica che si dipana sul solco delle espressioni più alte di Nancy Spero e Kiki Smith con una forte componente storica e antropologica satura di sedimenti evocativi che si stratificano nella sua ricerca. Whiteout il titolo dell’esposizione in mostra fino al 10 maggio 2020.
Il fondamento è la traccia liquida latente, lasciata scivolare sulla tela per prepararne e propagarne la stratificazione oculata, libera di vagare nella dimensione del magico. Sono costellazioni nel solco dei teatri e delle rivoluzioni permanenti del Novelli anni Sessanta, condotte sulla scia polare delle più pregne e alte espressioni simboliche impegnate della seconda metà del Novecento, calibrate e conciliate secondo il proprio immaginario contemporaneo che ha origini remote e non ha riverberi critici, politici. Quello di Marta Spagnoli è un atto che prende respiro depositando frammenti e lasciando emergere residui, reperti, testimonianze iconografiche. Sedimenti vivi e latenti che dimorano nel profondo della storia dell’uomo d’ogni tempo e cultura, scanditi al ritmo libero e ansimante delle acque della Laguna (Marta lavora da sei anni a Venezia) tra il lampeggiar di vuoti e slanci di stramonio che assecondano i ritmi dello spazio, volutamente schiacciato e sospeso. Sulla tela, in processo, un conseguente logico stratificarsi di organismi, forme organiche sempre più complesse che si accalcano e lavano via, che si agitano struggendo, aspirando un equilibrio, che è il fine bilanciato di ogni opera per diventare una composizione compiuta dove vagare tentando di orientarsi. Una narrazione che si nutre della forma, di quei piccoli barlumi biomorfi di segno (come una corolla di un fiore, un corallo tentacolare che si allunga e spira come una serpe di Kiki Smith o amori fluttuanti che chiamano l’immaginario di Londoño), di quei liquidi che a tagli e intagli conducono la storia (lasciati correre, come nella migliore tradizione astratta sciamanica o come le trame di Frankenthaler e Sam Francis, stesi al principio), di quei lunghi filamenti che si perdono nello spazio. Che si è fatto sospeso quanto arcaico e ancestrale, antico. Che ricorda e rievoca una dimensione strettamente polare, nel senso geografico ma non solo del termine, di luce diffusa in senso spaesante, quando le nuvole dense coprono fittamente i raggi, e neve nebbia risultano una cosa sola lasciando la “vittima” al vagheggiare stordito e disorientato, in balia di se stesso e del tempo senza spazio. Fenomeno scientifico che tecnicamente è chiamato Whiteout, nome che dà il titolo alla mostra fornendole una “dimensione altra” dove attingere e dirigere la propria visione e fruizione. Richiamando quella triplice alleanza nota nel lavoro di Marta tra sogno, realtà e mito nella quale tinge e colloca (se non si collocano di loro sponte) i suoi “mondi altri”, ne garantisce e introduce una collocazione spazio temporale, ma al contempo può celare quella connotazione peculiare fortissima dei lavori in mostra: l’ancorarsi nella Storia e nella terra -in senso prettamente di suolo materiale chimico, fisico, catalitico (e per sua genetica, stratificata)- che evocano ed echeggiano entrambi il passaggio dell’essere umano sulla Terra (questo sì in senso ampio), che è e rimane un principio cardine dell’opera mitopoietica di Marta. La testimonianza è nel segno, le arature aborigene (si sente la ricerca di Cagli), una dimensione persiana che vola verso l’estremo oriente passando per le efflorescenze ultime di Jitish Kallat. Tracce, strutture che prosperano raccogliendo la perpetua pratica portata avanti incessantemente fin dall’infanzia dall’artista -quella del disegno e più, quella del disegnare figure di animali- che va a comporre e scandire queste mappe di sintesi tra la natura e l’artificio ricoperte e ricamate di pelli maculate, seminali che germogliano più o meno a intermittenza sulle tele. Che implicitamente o meno richiamano i lavori di Nancy Spero, di Kiki Smith e in maniera più astratta di Sue Williams, terreno dove pascola anche la Mehretu. C’è anche qualche speranza di figurazione umana, senza volontà di citazione o copia posticcia, ma interiore e funzionale alla dimensione del mito. Amorini, satiri e cavalieri sulle forme antiche di Cucchi che stentano ad emergere e tentano una collocazione all’interno del tutto. Tutto che nel caso stretto della mostra, vede l’ultimo biennio di produzione di Marta svolgersi nel salone a lei dedicato, su vari registri (carta, tela, argilla e vari formati e tecniche). A 25 anni una maturità invidiabile. Per chi pensasse (stupidamente come il sottoscritto) di trovarsi uno o al massimo due chiavi di ricerca della sua produzione, si trova a constatare (e letteralmente a farsi sbattere in faccia) una serie di filoni avviati e già pronti, che rimbalzano tra le pareti, saturi di un vocabolario definito e consapevole. Una grammatica che vuole esplorare e interpretare il potenziale di strutture, relazioni, significati che bombardano e impregnano l’immaginario visivo esperienziale dell’artista, tradotto ed espanso a ognuno di noi: da sentori più astratti e segni graficamente più marcati e quasi meccanici (un tessuto che morfologicamente richiama la Accardi), alla onirica compenetrazione di viscere labirintiche ricoperte di brandelli di livree maculate dal trascorso antico, a pulsioni di tachisme, da scampoli di mondi dal sapore onirico simbolista ai paesaggi popolati di formazioni ocra e conformazioni minerali (che sentono il primo Frangi). Una varietà di costellazioni definite, metamorfiche e in potenza che si connettono a un unico universo. Con un chiaro avvenire.