
Roberto Floreani interviene nel dibattito aperto da ArtsLife dopo il corsivo pubblicato da ABO su Robinson di Repubblica
È sempre una buona notizia quando si accende un dibattito: opinioni diverse, nella loro indispensabilità, sono il sale dell’Arte e non solo. Così anche per il corsivo di ABO comparso su Robinson di Repubblica, dove vengono ribaditi punti di vista che si è già avuto modo, negli anni, di affrontare. Ma che oggi appaiono più come una richiesta d’attenzione che una tesi critica. Leggendo: “Senza un sistema composto da media, collezionisti, mercato, musei, musei pubblici le opere in sé non avrebbero valore”, ci si imbatte in un evidente inciampo linguistico tra valore e prezzo. Dove l’uso di valore appare del tutto travisato. Se non si attribuisce al denaro priorità assoluta asservendosi al materialismo, è del tutto evidente di come media, mercato, musei etc. etc. possano incidere anche in modo determinante, ma sul prezzo dell’opera, non certo sul valore, il più delle volte finendo anzi con lo snaturare semmai il valore di quelle successive, troppo spesso attente a non disorientare chi le ha foraggiate in precedenza.
Ma quanto al valore, il sistema citato non c’entra nulla, spesso riguardando aspetti dell’opera difficilmente traducibili in uno schema di valutazione che abbia a che fare con il suo aspetto commerciale. L’arte del solo Novecento conta le storie di centinaia di artisti in grado di suffragare questa tesi, che, numeri alla mano, esulano dal parere personale, rientrando in un conteggio statistico. Ma anche limitandosi alla mera valutazione del prezzo, è impreciso affermare che un’opera non abbia prezzo senza il supporto del sistema. Esiste infatti un’altra semplicissima regola economica, valida anche al mercato della frutta o del pesce, secondo cui il prezzo è comunque influenzato dalla domanda e dall’offerta che, anche senza le brigate da combattimento delle Case d’Asta, possono raggiungere livelli accettabili, in presenza di offerta numericamente ridotta. Naturalmente non saranno i prezzi registrati con il sistema completo all’opera, ma sufficienti per ritagliarsi uno spazio nel proprio tempo. Anzi, gli artisti (meglio defunti) con bassa produzione e prezzi allettanti diventano autentiche leccornìe per il suddetto sistema, in grado di rastrellare le opere in breve tempo, con spesa ridotta, rilanciando poi con i potenti mezzi a disposizione. Un’analisi quindi che richiede più competenze, per non correre il rischio della boutade ad effetto.
Nulla c’entra, quindi, il prezzo con il valore, diventato tuttavia il parametro di riferimento dell’arte dominante da almeno un trentennio. Quella che amo indicare come Post-Arte, in quanto sicuramente arte, ma che ubbidisce a fattori di riferimento mutuati dal potente (e liquido) settore della moda, è alimentata dalla logica interna al mondo delle griffes, dove l’affermazione e la diffusione dell’opera avviene dopo un bombardamento mediatico soffocante che appiattisce verso il basso la soglia critica, annichilita dal timore di esprimere un parere controcorrente. Il sistema di promozione applicato dalle multinazionali, in ogni settore. Senza contare l’autentica ossessione della novità a tutti i costi, con mostre prêt-à-porter che seguono la logica distorta della spettacolarizzazione a discapito del contenuto, seguendo quel che già nel 1967 Guy Debord aveva definito come Società dello spettacolo, seguita poi dalla vetrinizzazione sociale analizzata da Vanni Codeluppi nel 2007 e pubblicata nella collana scientifica Bollati Boringhieri.
In questi ultimo trentennio si è assistito al più elementare, sfrontato, perfetto conflitto d’interessi dei vari potentati del sistema, simultaneamente titolari di galleria, mercanti all’ingrosso, magari anche proprietari di casa d’aste e influencer, se non addirittura costruttori, museali, come il buon Charles Saatchi – titolare, non casualmente della grande multinazionale della comunicazione – ha insegnato negli anni Ottanta, inventando Damien Hirst e la tribù degli Young British Artists (YBAs). Nella Post-Arte esitono solo capolavori, proprio in quanto aggiudicati a prezzi stellari e quindi immediatamente musealizzabili, attualizzando l’ossimoro dell’”avanguardia di consenso”, ovvero della cosiddetta sperimentazione accettata senza riserve in tempo reale dalla collettività, anche la più sprovveduta. Storture dovute proprio al sistema citato da ABO, tuttavia dimenticando, limitadosi ad una descrizione ferma agli anni ’80, la componente oggi determinante della finanza, in grado di equiparare le post-opere alle blue chips presenti in Borsa, post-opere che restano nei sotterranei delle banche dopo le aggiudicazioni, in attesa dello step operativo successivo, il più delle volte senza il loro godimento diretto dell’acquirente.
Traformazione del sistema di cui ABO non è stato comunque il protagonista, ma il recentemente scomparso Germano Celant che inizia la “stagione finanziaria dell’arte” con il suo incarico alla rassegna Arte-Moda di Firenze del 1996; influenza non certo benefica per l’arte stessa se quel sistema sarà oggetto anche del saggio del celebre filosofo Gilles Lipovetsky L’era del vuoto, best-seller da un milione di copie in Francia che si commenta fin dalla titolazione, Sistema ripudiato duramente da menti capaci e strutturate quali Jean Baudrillard, autore – dopo essersi occupato della sparizione dell’arte – del celebre pamphlet Il complotto dell’arte, Paul Virilio che cita i nuovi protagonisti come: “occupanti dei musei degli orrori di una stampa spazzatura”, il filosofo Giovanni Reale con “Il fallimento dell’arte contemporanea”, Nicolàs Gòmez Dàvila: “questo secolo (il Novecento) sprofonda lentamente in un pantano di sperma e merda”, pur sorvolando sull’autentica crociata dello storico dell’arte Jean Clair, che cita il contemporaneo come il défilé dell’osceno, innescando un’autentica battaglia contro l’avvento dell’orrore.
Contrappesi qualitativi che annullano dall’interno il presunto consenso di massa dei manovratori. Sistema dell’arte che secondo ABO sarebbe quindi: “Un valore aggiunto, un plusavalore culturale che spesso travalica anche la stessa qualità dell’opera d’arte e la modifica in una sorta di superarte”; affermazione che resta valida solamente quando è il prezzo unico parametro di riferimento, applicato quindi “a opera morta”, valutata solo come oggetto di scambio. Quanto alla Superarte, sorella della Transavanguardia, non sono che le nipotine delle intuizioni futuriste del Passatismo, dell’Antigrazioso, Antineutrale, Mitomacchina, Mitovelocità: simpatiche ed efficaci.
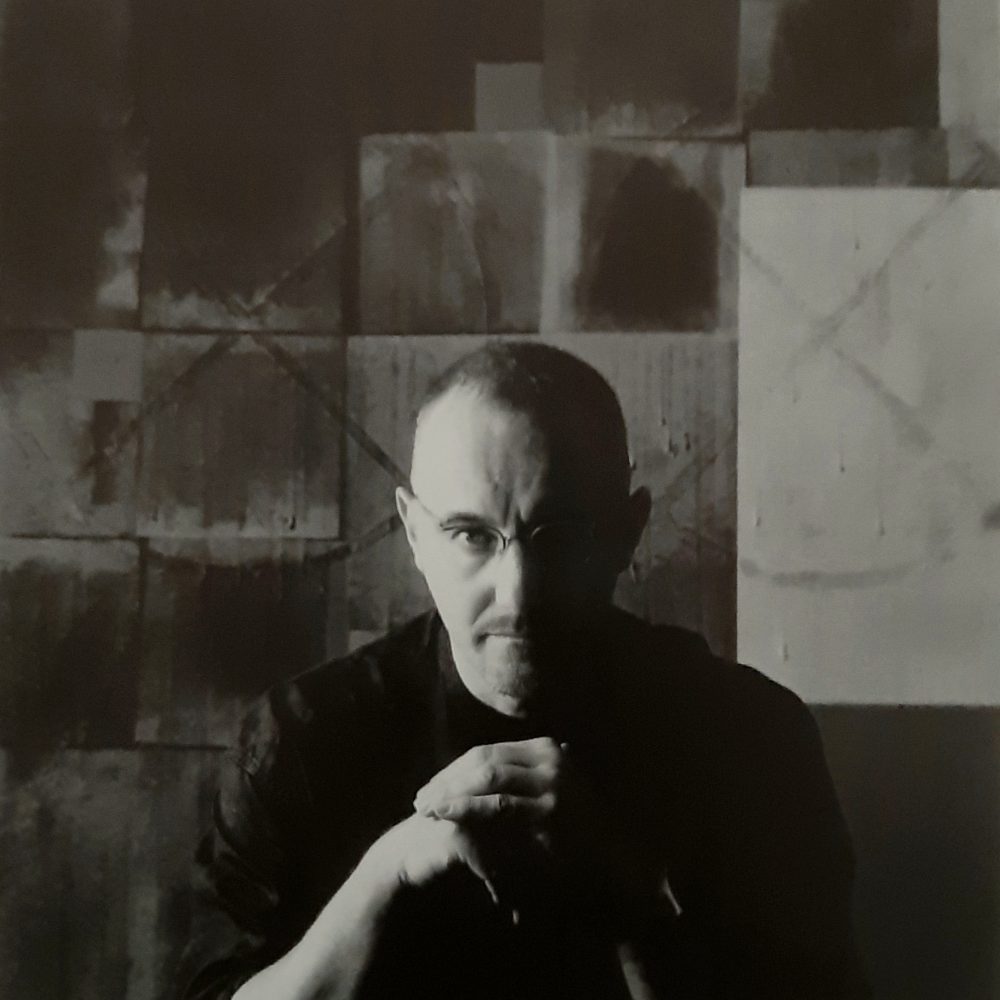
Il reiterato discredito sul processo creativo e quindi sulla stessa figura dell’artista nel tentativo di controllarlo, non è una novità. Ma non era una novità nemmeno del 1974 quando ABO riduce a pegno visivo l’opera dell’artista, che assumerebbe senso solo al momento in cui viene inserita in un progetto, teoria a sua volta mutuata dallo “spirito del Gruppo” sostenuto da Giulio Carlo Argan, fin dai primi anni ’60, compensato efficacemente dal pensiero di Mircea Eliade che parlerà della “disintegrazione del singolo nel cosiddetto collettivo” dove si raggiungeranno: “La meccanizzazione, la disentellettualizzazione e la razionalizzazione di ogni attività, su tutti i piani”. Già nel 1914, agitando il vento della Rivoluzione, il costruttivista Vladimir Tatlin auspica l’inserimento organico dell’artista nel sistema produttivo, seminale per lo sviluppo delle teorie di Nikolaj Tarabukin definite nella conferenza L’ultimo quadro. Dal cavalletto alla macchina, del 1921 dove per l’artista viene auspicato “un ruolo professionale, estraneo alla creazione. Nel futuro l’arte, abbandonato l’ambito dell’estetica, allargherà la sua sfera d’azione e penetrerà come parte integrante nella vita, aderendovi organicamente […] Nel futuro, quando l’interesse per l’arte pura si sarà indebolito sotto l’influenza dell’americanizzazione, invece che paladina dell’arte pura, gli uomini di talento diventeranno uomini pratici”. È la stessa logica collettivista della riorganizzazione della cultura post-rivoluzionaria degli anni ’20: là serva della politica: “l’artista sarà senza velleità estetiche, senza riguardo per l’aspetto spirituale, apprendendo il metodo dell’operaio”, oggi schiava del mercato. Una profezia, un orrore, che si sperava non si riattualizzasse, seppur in contesti diversi: il primo sanguinario, l’attuale sornione, apparentemente luccicante.
La disputa tra artista e critico conta precedenti esaltanti e anche divertenti, raggiungendo, negli anni, livelli anche parossistici, con le scorribande critiche dei futuristi in prima fila, del tutto autonomi fin dalla pubblicazione dei numerosi e specifici Manifesti programmatici. Senza il supporto teorico di Umberto Boccioni e dei suoi scritti, il Futurismo, cioè la prima Avanguardia storica del Novecento, quella seminale, non esisterebbe, come la conosciamo oggi. Ma anche Alberto Burri sconfesserà sistematicamente le interpretazioni critiche relative al suo lavoro; così come del tutto autonoma sarà l’Age d’Or di Dorazio, Perilli e Guerrini, libreria-galleria aperta a Roma nel 1950, anno in cui Ettore Colla fonda il Gruppo Origine, che darà vita, dal ’52 al ’58 alla rivista Arti visive, centrale nel dibattito artistico e critico di quegli anni. Così come significativa sarà la vicenda dell’Art Club, Associazione Internazionale Indipendente (1945-1964); la figura di Gillo Dorfles nella fondazione del MAC e la successiva “catalogazione” teorica del Kitsch; la stagione esaltante escogitata da Piero Manzoni: critica (Azimuth) ed espositiva (Azimut), caratterizzata da un’attività frenetica, tra il 1959 e il 1960.
Lo stesso Lucio Fontana approderà in Italia dall’Argentina con il suo Manifesto Blanco (1946) sotto il braccio, ridefinendo un’arte nuova, slegata dai canoni classici di pittura e scultura, in questo seguendo da vicino il Polimaterismo di Prampolini, pubblicato nel 1944 sulle suggestioni del Manifesto della Scultura Futurista di Boccioni, datato 1912, cui lo stresso Fontana tributerà la primogenitura delle sue intuizioni. Centrale poi la stagione del Bauhaus, condotto da artisti-docenti come Klee, Kandinskij, Itten, l’irrinunciabile Josef Albers, che formerà generazioni di artisti in America del calibro di Newman e Rauschenberg; Arshile Gorky che sarà la coscienza critica degli Irascibili, gli espressionisti astratti che domineranno la scena per decenni. E Francis Bacon esporrà per la prima volta nello spazio espositivo autogestito di Graham Sutherland. La storia dell’arte dei nostri tempi racconta come i passaggi epocali del Novecento siano stati guidati dalle opere e dai contributi teorici degli artisti, attualizzando un filo conduttore diretto tra il concepimento e la realizzazione dell’opera e il suo posizionamento critico-storiografico, in cui l’opera e l’artista sono autonomamente il centro della scena e non certo marginalizzati.
La critica tout court ha naturalmente svolto un ruolo, ma oggettivamente complementare e quindi non concorrente. Ma anche trattando dell’attività dei grandi galleristi, le due mostre potenzialmente seminali, per l’attuale orientamento – anche mercantile – contemporaneo sono probabilmente Arte abitabile, del giugno 1966, realizzata a Torino dal visionario Gian Enzo Sperone e Fuoco Immagine Acqua Terra, del giugno del 1967, concepita a Roma da Fabio Sargentini, entrambe precedenti alla stagione critica “militante” inaugurata da Celant e Bonito Oliva. Critica non certo considerata benevolmente nemmeno dai grandi pensatori del Novecento, se Hans Georg Gadamer – con Baudrillard, Virilio, Debord, Reale, Clair, Lipovetsky, Perniola e molti altri – ultracentenaria coscienza filosofica del Novecento, già allievo di Martin Heidegger, in un’intervista di Klaus Davi del 1987, si esprimerà con molta durezza: “Temo che la critica non mai stata in grado di comprendere veramente l’arte”, amplificando il pensiero di uno dei suoi allievi, Gottfried Boehm, convinto che: “I critici non sappiano fare altro che imporre un loro codice interpretativo, rigido e deterministico, distorcendo, se non proprio deturpando, i significati delle opere che pretendono di criticare”.
L’opera vive una vita propria che le deriva direttamente dal suo essere creazione, e separa il tempo del prima da quello del poi, come del resto sanno tutti, naturalmente.









