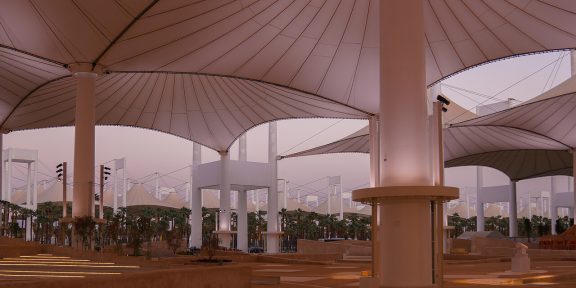A scorrere le biografie dei cento artisti presentati dalla Biennale di Diriyah non può non saltare all’occhio l’impeccabile curriculum di ciascuno di loro, a cominciare da studi blasonati, fino agli incarichi come docenti universitari o come direttori di laboratori sperimentali di punta di tutto il mondo. Così mi viene in mente quel libretto di Mario Perniola del 2015, Arte Espansa, che mette a confronto la Biennale di Venezia “fringe” del 2013 curata da Massimiliano Gioni e la “reazione” della Biennale seguente del 2015, curata da Okwui Enwezor che invece riportava il timone dell’arte in direzione di artisti con curricula studiorum ineccepibili, recuperando un’idea di arte colta, come ricerca e studio, impegno e teorizzazione.
Ecco, la Biennale di Diriyah curata dalla direttrice artistica Ute Meta Bauer, si pone in continuità con questa impostazione, del resto la curatrice tedesca ha ricevuto l’imprinting proprio da Enwezor, essendo nel board dei curatori della documenta 11 del 2002. È molto acuta in effetti, in una zona rialzata della prima sala, la sezione dedicata alla Re/search: l’arte vista come cercare e ricercare, come curiosità per il mondo e come ricerca di carattere scientifico, architettonico, archeologico, storico, sociale, ecologico e così via, che sono poi le linee programmaticamente aperte dalla curatela che si interessa di queste pratiche artistiche pluridisciplinari, con attenzione a 360 gradi agli aspetti che granularmente e impalpabilmente abitano il mondo: un’attenzione particolare infatti viene data anche agli odori con la presenza delle ricerche di Sissel Tolaas, ricercatrice nel campo degli odori, che viene incaricata di creare artificialmente l’odore del petricore, l’odore della pioggia sulla terra asciutta e di Anaïs Tondeur che invece rintraccia l’odore del petricore in 72 campioni di terra nelle strade di Parigi. Il petricore è l’odore da cui “emana” il titolo della Biennale: After rain.

Un titolo dal forte significato vitale e rigenerativo, ecologico e comunque anche coinvolgente i sensi dello spettatore. Infatti un altro elemento tipico di questa Biennale è proprio la volontà di fare partecipare lo spettatore secondo varie modalità, tra workshop, letture, performance, offerta di bevande africane del gruppo Njokobok oppure di cibo tipico di varie cucine del mondo di Britto Arts Trust o la performance-pasto collettivo orchestrato da Lucy e Jorge Orta.

Mi ha favorevolmente impressionato l’abilissimo display della mostra, che segue una precisa regia quasi drammaturgica con l’alternanza di zone chiare e invece atmosfere notturne di grande impatto emotivo. Nella prima sala, Stories and Histories, le luci sono posizionate sulle opere in modo teatrale, mentre il resto rimane scuro e i riferimenti sono al mondo del teatro, al circo, al cinema, alla musica: il bagladese Dhali Al Mamoon mette in scena lo spettacolino delle sue rumorose marionette semoventi che riprendono la raffigurazione carnevalesca dei soldati indiani al soldo della Compagnia delle Indie dell’Est. Mentre su una pedana giacciono gli strumenti musicali attivati da performance durante la mostra, frutto della ricerca di Tarek Atoui sulla musica araba e islamica in Marocco e Arabia Saudita. Una luce fredda e chiara costruisce lo scenario scientifico del secondo salone dedicato ad Ambienti ed ecologie con lavori di carattere fotografico interessanti come il progetto delle case di fango di vari paesi del Medio Oriente ed Africa dell’Ovest di James Morris e installazioni di grande impatto come la “Palafitta” di Marjetica Potrč, un’ambiente di matrice indigena per la sopravvivenza. Infine il meccanismo semovente con mangrovie che salgono e scendono nell’acqua e i video dell’artista filippina Martha Atienza si riferiscono all’impatto del cambiamento climatico con il problema urgente della sparizione di intere isole sommerse dalle acque compresa l’isola di Banthaian dove lei stessa vive. La terza sala dedicata a Modern Legacies and Geopolitics riguarda artisti storici del Medio Oriente e dell’Oriente che sono state figure importanti per gli artisti a venire: tra questi interessanti le performance dell’artista iraniano Hassan Sharif che costituiscono una risposta al movimento Fluxus conosciuto in Gran Bretagna.

Di grande suggestione è il quarto salone immerso nell’oscurità con le luci che colpiscono in maniera scenografica le opere, intitolato Water and Habitats con le grandi fontane in forma di contenitori d’acqua antichi e moderni dell’artista del Kuwait Alia Farid, che mostra anche i video Chibayish che denunciano l’inquinamento dell’acqua alla confluenza tra Tigri ed Eufrate attraverso la rappresentazione di due bambini che si prendono cura di un bufalo d’acqua. L’enorme quinto salone nominato Knowledge in Material and Spiritual Intelligence dedicato ai materiali naturali e il rapporto empatico e spirituale con il mondo è di grande impatto scenografico, anche questo immerso in una luce oscura. Due installazioni riprendono forme, materiali e pratiche artigianali in modo spettacolare: quelle del cambogiano Sopheap Pich e del balinese Muhanned Cader. Interessante il video di Priyageeta Dia di Singapore che denuncia le multinazionali delle piantagioni e il lavoro dei migranti nella penisola malese. Mentre il lavoro più commovente ed essenziale è Come, let me heal your wounds di Dana Awartani, un tessuto in vari riquadri “minimalisti” che viene colorato con medicine e che viene ricamato nei fori-ferite, riprendendo la pazienza e la gratuità dell’idea di cura. L’ultima sala, Time and Space, con l’Initiation Room di Tania Mouraud offre una finale idea di concentrazione, contemplazione, cura del sé.
La nutrita presenza di artisti del Medio Oriente, con particolare riguardo all’Arabia Saudita, è il risultato di attente ricerche e viaggi della direttrice artistica e del team curatoriale, che hanno incontrato artisti, ma anche artigiani, scienziati, agricoltori cercando di ricostruire un tessuto sociale e culturale da restituire in modo appropriato nella Biennale, dimostrando rispetto e attenzione per il territorio in cui la Biennale ha luogo.