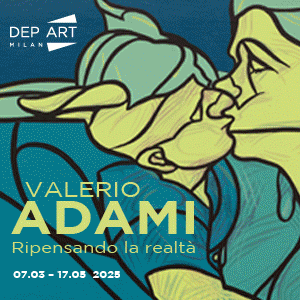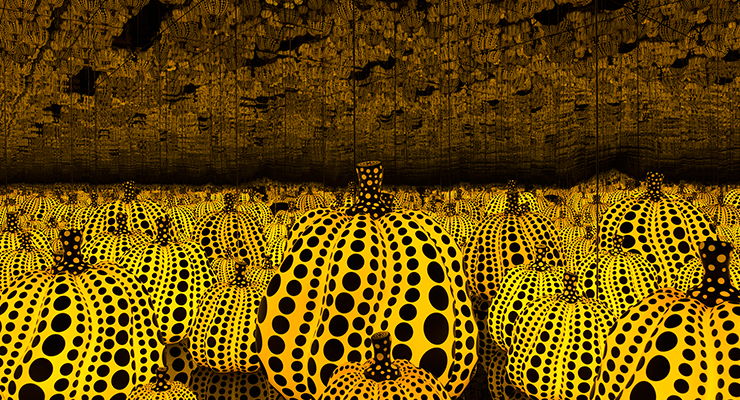A volte, non bastano 3 anni per tornare alla vita. Ma per ricominciare, sì.
E se in questi giorni, sabato 31 gennaio, apre a Mirandola la mostra «Per amore dell’arte – Il restauro di 3 capolavori», oltre a quello che si può vedere c’è tutto quello che abbiamo visto in quelle notti di cielo nero e di terra cattiva e tutto quello che è rimasto scolpito dai giorni della paura nell’Emilia devastata dalle scosse, a ricordarci che la vita quando rinasce può essere anche più bella.

Le opere esposte nell’Aula Santa Maria Maddalena sono il Crocefisso della Collegiata di Santa Maria Maggiore e i dipinti raffiguranti la Conversione di Saulo di Sante Peranda e la Madonna di Loreto col Bambino in gloria di Annibale Castelli.
Sono il simbolo di questi tre anni. E ci raccontano cose diverse.
Il Crocifisso era finito nel crollo della navata centrale che l’aveva spezzato in un mucchio di frammenti, alcuni dei quali erano stati addirittura ritrovati solo un anno dopo il terremoto.
Fino a questo momento era ritenuto un’opera in gesso del Settecento, ma proprio in seguito al restauro si è rivelato un manufatto in legno molto più antico, databile alla fine del XV secolo.
Noi c’eravamo stati, per lavoro, in quei paesi distrutti dalle bombe che salivano dalla terra, fra le macerie ammucchiate sulle strade davanti alle quinte dei palazzi rimaste in piedi come dei disegni, a coprire solo il vuoto dietro di loro, con il fumo che veniva dalle rovine, tutta quella polvere, quell’odore di morte, e quei silenzi angoscianti lacerati dalle urla delle sirene.
C’eravamo tornati sei mesi dopo, per vedere come ripartiva l’Emilia del lavoro e della vita, ed eravamo capitati proprio a Mirandola. La Chiesa di San Francesco era ancora una grande balena vuota, con qualche candelabro a forma di croce che si scorgeva dal fianco caduto, allungando lo sguardo oltre le sue rovine. Il sagrato del Duomo era coperto di macerie: pioveva dentro, quel giorno, una pioggia continua, distruttiva.
Il terremoto del 20 e 29 maggio 2012 aveva lasciato 27 morti, centinaia di feriti, danni per 12 miliardi di euro, sedicimila sfollati, un mondo imprenditoriale di 175mila lavoratori in ginocchio, seimila aziende agricole colpite oltre a 600 allevamenti, 600mila forme di parmigiano cadute, 37 caseifici fermati.
Le scosse si erano allungate dai luoghi della memoria storica a paesini quasi sconosciuti ai più, da Medolla a Finale Emilia, da Ferrara a Modena, e poi Cavezzo, Mirandola, Novi, Carpi, mischiando tutto in quelle rovine, dal campanile alla fabbrica diffusa, lungo la via Emilia con gli argini del Po e i filari di pioppi.
Dopo sei mesi avevano sgombrato tutti i campi, l’ultimo a Mirandola, qualche ora prima che noi arrivassimo, con la tendopoli smontata dietro l’Ipercoop. Come ci diceva Maino Benatti, il sindaco, «l’ottanta per cento del biomedicale ha ripreso a funzionare, i capannoni li stanno finendo, anche se la gente non si è mai fermata, nemmeno nei giorni più terribili».
Solo nelle Chiese era tutto rimasto come nei giorni della grande paura e della tragedia, come se i luoghi di culto avessero finito per rappresentare la memoria incalcellabile. Il 20 e il 29 maggio, 515 chiese erano state colpite e rese inagibili. Praticamente tutte.

Una fetta dell’Emilia aveva perso la sua identità: una terra senza campanili. I fedeli non avevano più chiese dove ritrovarsi. Andavano alla Messa in tendoni disseminati nelle periferie dei paesi, come in via Posta, dove don Carlo Truzzi, il parroco del Duomo, celebrava il rito delle 10 e 30, quella domenica, davanti a 400 persone ammassate fra le sedie di plastica.
Prima del sisma, nella magnificenza della Chiesa venivano in 500, quindi non erano tanti di più. All’ospedale, invece, celebravano la Messa per quelli del tempio di San Francesco. Il Duomo e San Francesco erano state le chiese più colpite dal terremoto.
A San Francesco era crollato il campanile, la Chiesa aveva perso i tre quarti della copertura e dentro era tutta vuota. Erano rimaste solo la facciata, una parte della navata sinistra e l’abside. Sei mesi dopo c’era ancora la polvere, quella luce sporca che come un sudario ricopriva le rovine.

Ecco, avendo negli occhi tutto questo, andremo a vedere le opere restaurate a Mirandola, e assieme la Bassa dei pioppeti e dei campi sperduti fra le nebbie o affondati nel sole dell’estate, quella meravigliosa terra, con la sua gente così dura e romantica, che ha sempre messo insieme le sue radici e il futuro, dove se passi di lì, lungo la via Emilia, ti sembra di sentire ancora adesso l’odore del carburante bruciato che si disperde tra i campi di erba medica e di barbabietole, come se ci fossero i contadini di un tempo con il cappellaccio di paglia e la canottiera a guardare correre le Mille Miglia appoggiati a un forcone, sullo sfondo di casolari dai muri scoloriti per le piogge o il solleone. Dolce Emilia.