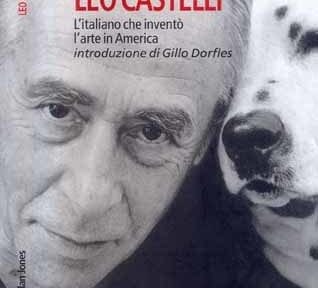Poco conosciuta in Italia, sia sul versante critico che su quello del mercato, l’opera della Mitchell può a ragione essere considerata un ponte tra la pittura americana e quella europea della seconda metà del Novecento. Insieme a Lee Krasner (moglie di Jackson Pollock), Grace Hartigan, Helen Frankenthaler (sposata in seconde nozze con Robert Motherwell) ed Elaine de Kooning (moglie di Willem de Kooning) fu tra le pochissime donne protagoniste della grande stagione newyorchese dell’espressionismo astratto. Nel 1949 aveva sposato a Parigi Barney Rosset, editore già proprietario della Grove Press celebre per aver pubblicato lo scandaloso “Tropico del Cancro” di Henry Miller. Dopo aver divorziato a New York nel ’52 la Mitchell, conosce il pittore canadese Jean-Paul Riopelle e decide di trasferirsi a Parigi con lui nel 1955. Da qui la lunga stagione europea di contaminazione tra una gestualità astratto-informale e la rivisitazione che Joan compie delle esperienze coloristiche di Vincent Van Gogh e Claude Monet, due artisti da lei amatissimi. Nonostante la sua opera sia fondamentale per la crescita della pittura europea le opere della Mitchell sono pressoché sconosciute al grande pubblico e quasi del tutto assenti dal mercato italiano. Non così ovviamente per Parigi che nel maggio del 2007, da Christie’s, ha archiviato il suo attuale record mondiale. “Sans titre”, un magistrale olio su tela di quasi due metri per due, dipinto nel 1971, era stimato 1,2-1,5 milioni di euro. Ma nella battuta finale di aggiudicazione si è fermato, compresi i diritti, a 5.184.000 euro. Nel novembre del 2007, a New York ancora da Christie’s, un altro olio questa volta del 1960 è stato venduto per 5.081.000 $. Il 2008 è stata invece la volta di Sotheby’s, che ha venduto “La Grande Vallée XI”, del 1984 -stimata 1-1,5 milioni di pound- a 2.596.500 sterline. Mentre nel maggio del 2008, “La ligne de la rupture” del 1970/71, nella sala parigina di Sotheby’s stimato 2,2,-3,2 milioni di euro ha sfiorato il record fermandosi a 3.840.250 euro. Complessivamente negli ultimi quindici anni sono passati in asta 455 opere della Mitchell, delle quali 252 dipinti. Con una crescita esponenziale del suo valore medio. Secondo “ArtPrice” 100 euro investiti nel 1998 su un’opera di quest’artista valgono in media, nel dicembre 2008, ben 780 euro. Nel 2007 sono state vendute suoi quadri per un controvalore di 20,1 milioni di euro, pari al +74% rispetto al 2006. Questa mostra di Reggio Emilia è un avvenimento storico e di tendenza. L’ultima volta che nel nostro Paese furono esposte opere di questa straordinaria interprete del colore risale al 1960 quando Franco Russoli presentò una sua personale nella mitica Galleria dell’Ariete a Milano. E nel 1961 perchè risultò vincitrice del “Premio Lissone”. Da allora per quasi cinquant’anni galleristi, mercanti, collezionisti, critici e l’intero mondo dell’arte italiano si scordò di lei. Un vero peccato.

Joan Mitchell, “Sans titre”, 1971, olio su tela, 198 x 200 cm Christie’s, Parigi, maggio 2007. Stima: 1,2 -1,5 milioni di euro. AGGIUDICATO A: 5.184.000 EURO (record mondiale per l’autrice)
alcune sale della mostra
in Italia dopo 50 anni
22 marzo – 19 luglio 2009
Palazzo Magnani Rocca, Reggio Emilia
Dal 22 marzo al 19 luglio 2009, Palazzo Magnani di Reggio Emilia ospita la grande antologica, la prima mai organizzata in Italia, dedicata a Joan Mitchell (Chicago, 1926 – Parigi, 1992), una delle pittrici americane più importanti del XX secolo.
L’esposizione, curata da Sandro Parmiggiani, promossa dalla Provincia di Reggio Emilia, con il contributo di Fondazione Manodori, CCPL, Tecton, Grasselli, BFMR&Partners Dottori commercialisti, Studio Legale Sutich-Barbieri-Sutich di Reggio Emilia, e con il contributo speciale della Terra Foundation di Chicago, della Joan Mitchell Foundation e della Cheim & Read Gallery di New York, presenta 46 opere – alcune di grandi dimensioni, quali Les bleuets, 1973, di 280 x 580 cm e A small garden, 1980, di 285 x 720 cm, entrambi del Centre Pompidou di Parigi; Edrita Fried, 297 x 762 cm, della Joan Mitchell Foundation di New York – provenienti da alcuni dei maggiori musei americani (Whitney Museum of American Art di New York, Smithsonian Museum di Washington, National Gallery of Art di Washington), dalla Joan Mitchell Foundation di New York e dalla Cheim & Read Gallery di New York, e da musei (Centre Pompidou, Musée de Beaux-Arts di Nantes, FRAC Haute Normandie, Fondation Maeght di St. Paul de Vence) e collezioni private francesi, in grado di coprire l’intero percorso dell’artista, dal 1950 agli ultimi dipinti realizzati nei giorni immediatamente precedenti la sua scomparsa

Les bleuets, 1973 olio su tela, 280,7 x 579,8 cm trittico (3 pannelli)
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Parigi
Centre de création industrielle In deposito a Nantes, Musée des Beaux-Arts
L’iniziativa reggiana è la seconda tappa di un percorso espositivo che, iniziato alla Kunsthalle di Emden (Germania), proseguirà dal 23 agosto al 31 ottobre 2009, al Musée des Impressionismes Giverny (Francia).

Hemlock, 1956, Olio su tela, 231,1 x 203,2 cm
Whitney Museum of American Art, New York
L’opera di Joan Mitchell può essere considerata un ponte tra la pittura americana e quella europea. Dapprima protagonista dell’Espressionismo Astratto americano – negli anni Cinquanta, quando viveva in quella New York – faceva parte del gruppo di mitici pittori, tra cui Pollock e De Kooning, con il quale sarebbe restata fino alla fine in rapporti di fraterna amicizia – che avrebbe scalzato Parigi dal ruolo di centro dell’arte mondiale e segnato l’affermazione della metropoli americana come luogo propulsore dell’innovazione artistica – e successivamente, a partire dal suo trasferimento a Parigi alla fine degli anni Cinquanta, creatrice di una pittura che rivisita le esperienze di Van Gogh e di Monet, e che riesce a trasmettere, attraverso una gestualità astratto-informale e colori squillanti, le emozioni provate di fronte alla natura (campi, giardini, alberi, fiori) e i sentimenti suscitati in lei da alcune vicende della sua vita.
Piano mécanique, 1958 olio su tela, 198 x 325,1 cm
National Gallery of Art, Washington, donazione di Addie e Sidney Yates
La pittura di Joan Mitchell, esito di un gesto che tradisce l’ansia e il desiderio di vivere e di dipingere, è sempre di altissima qualità, per l’equilibrio formale, gli accordi tonali, e lo svolgimento di un ritmo che si può seguire in ogni sua opera.
A Joan Mitchell sono state dedicate, dopo la morte, alcune importanti retrospettive, come quelle al Musée des Beaux-Arts di Nantes e al Jeu de Paume di Parigi nel 1994, e al Whitney Museum of American Art di New York nel 2002.
In Italia, l’opera di Joan Mitchell non viene presentata da cinquant’anni: la sua stagione espositiva in Italia fu assai breve, e tutta circoscritta tra la fine degli anni Cinquanta (1958, Biennale di Venezia, dove espose due opere nella sezione “Giovani artisti italiani e stranieri” curata da Franco Russoli, e al Festival dei Due Mondi di Spoleto; 1959, mostra al Circolo degli Artisti di Torino) e i primi anni Sessanta (1960, mostra personale alla Galleria dell’Ariete di Milano, presentata in catalogo da Franco Russoli; 1961, vincitrice del Premio Lissone).
Il catalogo bilingue (italiano/francese), edito da Skira, presenta testi del curatore, di Nils Ohlsen (direttore della Kunsthalle di Emden), di Sophie Levy (direttrice del Musée des Impressionismes Giverny), di Yves Michaud, di Rachel Stella, di Brigitte Hedel-Samson, e di Gisèle Barreau (amica personale dell’artista, che rievoca il suo ininterrotto amore per la poesia e per la musica).
Tilleul, 1978 olio su tela, 260 x 180 cm
Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Parigi
Centre de création industrielle in deposito a Nantes, Musée des Beaux-Arts
Alcuni testi di approfondimento, estratti dal catalogo della mostra edito da Skira
Alla ricerca di un sentimento perduto
Sandro Parmiggiani, Curatore della mostra
Non amava, Joan Mitchell, le mostre antologiche, almeno stando a una sua perentoria affermazione: “non voglio vedere la mia vita srotolata davanti a me come un album di fotografie”. Non sembri, questa volontà di negarsi alla presentazione del proprio percorso – riflesso, anch’essa, di un carattere inestricabilmente fatto di asprezze e di tenerezze, di cui chi la frequentò ha reso testimonianza –, mera espressione di una civetteria o di una volontà di sviamento, in cui talvolta chi si trova sotto le luci di una ribalta è costretto a rifugiarsi, magari per sottrarsi a una qualche troppo insistente curiosità. Al contrario, diventa specchio, la dichiarazione della Mitchell, di alcune verità, se si pensa al senso profondo, e alla reciproca, inscindibile influenza e unità, che vita, natura e pittura hanno avuto per lei. Lei è vissuta per la pittura, la sua esistenza si è incarnata nei suoi dipinti; tutto ciò che in essa vi è stato di più intenso e vitale vi è stato racchiuso: la memoria di certi paesaggi e di certi scorci della natura; il travaglio e l’angoscia sorda dei giorni del lutto e del dolore; l’approdo alla serenità, spesso rivelatasi breve e illusoria; l’amore per la pittura che mai è scemato di intensità, tanto da spingerla, verso la fine dei suoi giorni, ormai sofferente, a praticare ancora il rito faticoso di salire e di scendere da una scala, nello studio, per stendere una pennellata su una grande tela e poi arretrare a constatarne e giudicarne gli esiti. D’altra parte, la stessa fotografia può finire per diventare solo una pallida eco degli autentici “momenti di essere” dell’esistere, incapace di rendere quel rapporto che allora si stabilì tra le cose del mondo e le persone, quando tutto pulsava e pareva esprimere sentimenti coincidenti, o quell’acuto sentire del corpo, del cuore e della mente nei giorni della sofferenza e della solitudine. Joan teme probabilmente che ciò che lei ha vissuto, nel corso della sua esistenza di donna e di pittrice, con tanta intensità di coinvolgimento emotivo e di coscienza, possa essere non colto e non visto, svilito, offuscato e incompreso da un semplice “passare accanto” alle opere, senza misurarsi con i grumi di verità e di sentimenti che in ciascuna di esse lei vi ha depositato. Consapevole di questa sfida, mi atterrò a una scelta personale, alla quale sono ormai fedele da lunga data, che Francesco Arcangeli, il critico e storico dell’arte italiano che con tanta passione si batté per l’informale, riteneva fosse l’insegnamento fondamentale lasciatogli dal suo maestro Roberto Longhi: “il rapporto concreto con le opere, […] un effetto di convivenza, quasi per un mirabile fenomeno di osmosi, con il respiro dell’arte stessa”. Nel caso di Joan, potremmo, parafrasando, dire che nei suoi dipinti si dà proprio un fenomeno di osmosi, un manifestarsi, un respirare, un fluire ininterrotto dei “sentimenti interiori” che le cose rivelarono all’artista, e che noi stessi possiamo cogliere quando la nostra sensibilità sa andare loro incontro. Se non passiamo accanto a un’opera della Mitchell con indifferenza, sentiamo che essa, al di là del viluppo, più o meno intricato, delle pennellate e dei segni, dell’incanto sfavillante dei colori – che alternano sensuali campi tonali smorzati a stesure cromatiche aggressive, impetuose tempeste che tutto scuotono –, del baluginare intermittente delle luci che si accendono o si spengono, risveglia qualcosa che s’era in noi assopito. È un sentimento, uno stato d’animo, un’accensione della memoria, magari determinati da un’emozione lontana che improvvisamente ci rivelò il senso, spesso negletto e dimenticato, dell’autenticità del vivere, nostro e del mondo intorno a noi – il tono di un cielo solcato da nuvole migranti, la bellezza insinuante di un fiore, la forza vitale di una pianta, il brivido che improvvisamente diede linfa al nostro corpo all’irrompere di un cambiamento atmosferico, la rapinosa scoperta di un segreto celato in un testo poetico, in un brano musicale o in un’opera d’arte. Di questo si era probabilmente nutrita la pittura dell’artista: una pittura, ne sono certo, che poteva darsi e crescere solo dentro questa capacità dei sensi di andare fino al termine ultimo delle loro possibilità, senza mai curarsi di restituirci, del veduto, ciò che l’occhio immediatamente percepisce e che viene universalmente considerato il volto del reale, ma qualcosa di meno superficiale, di più oscuro e vitale, pur fuggevole, destinato a una vita breve come un sospiro: la natura fu per Joan non solo fonte di immagini visive, ma di echi, di vibrazioni sonore, così che i suoi colori sempre sono la cassa di risonanza di un sentimento. Come diceva Proust ne Le Temps retrouvé: “La réalité à exprimer résidait […] non dans l’apparence du sujet, mais dans le degré de pénétration de cette impression à une profondeur où cette apparence importait peu”. I lacerti di paesaggio e di natura, l’inquietudine e l’angoscia, il dolore o la felicità di certi giorni, che Joan Mitchell ci restituisce attraverso la sua pittura hanno conservato quella originaria emozione forte, quella subitanea rivelazione della verità, in cui ciò che se ne sta davanti a noi emana una fragranza che ti dà l’illusione di potere entrare a fare parte di quel mondo, di essere accolto in quel mistero, stabilendo un rapporto alla pari e riconoscendo che la capacità di sentire, di soffrire, non è solo nostra, ma anche delle cose. La memoria sorgiva, fluviale, che la Mitchell riesce a plasmare in poesia ha selezionato, essendo di natura affettiva – come si dice in francese, si apprende par coeur –, ciò che indelebilmente è restato della sua esperienza e della sua osservazione: la memoria seleziona, elimina e poi magari recupera, mai diventa un cassetto che accoglie le cose alla rinfusa, e che in ogni momento si può riaprire per farne uscire, magari alla bisogna, qualcuna.Se, tuttavia, possiamo sostenere che la vita della Mitchell fu il dipingere, e che dentro le sue opere ella traspose la memoria rielaborata, i sentimenti ritrovati del suo sguardo sul paesaggio e sulle cose del mondo, e le sue vicende personali, non possiamo dimenticare che la pittura ha una sua peculiare memoria, soprattutto in artisti, come lei, che fin dall’infanzia frequentarono i musei e s’appassionarono a certi autori, e che poi vissero una stagione fervida di incontri e di rapporti duraturi – una memoria che, nel farsi dell’opera, fondendosi in una sorta di crogiuolo con i ricordi e le esperienze del vissuto, che talvolta possono anche andare alla deriva fino a farsi sogno o allucinazione, impone che, a un certo punto, una pennellata chiami una pennellata, un segno chiami un segno, un colore chiami un colore, in un processo in cui si mescolano intelligenza personale del pittore e intelligenza storica della pittura, riaffioramenti della memoria individuale e di quella, incancellabile, della pittura. Ha, la pittura, una sua lingua, dei codici espressivi, una sua leggenda che va, come avviene per i miti, continuamente arricchendosi e trasformandosi, proprio mentre viene rivisitata e declinata in maniera diversa – Joan ha tenuto viva la lingua della pittura proprio perché l’ha trasformata. Come lucidamente aveva compreso Georges Braque, ogni regola deve sempre essere corretta e temperata dall’emozione; la pittura di Joan Mitchell ci appare così l’esito di molte tensioni: il desiderio e la nostalgia di una cosa o di un tempo perduti, che nel suo alfabeto pittorico immediatamente si trasfigurano in una sorta di vortice che ferma un’immagine in movimento, di ritorno all’indietro “pittorico” nel processo di creazione e di evoluzione del mondo; la ricerca, nel farsi dell’opera, di quelle epifanie legate a una intuizione improvvisa, che arrivano a suggerire gli accostamenti di segni-colore, i loro brividi interni, le vibrazioni luminose e materiche delle pennellate, che possono procedere distese, senza sfiorarsi, abbracciarsi appassionatamente o collidere senza scampo.
alcune sale della mostra
I polittici o le cesure del tempo
Sophie Lévy, Direttrice del Musée des Impressionismes Giverny
1967: The Goodbye Door (La porta dell’addio)
Qualunque sia l’angolazione da cui si scelga d’affrontare l’opera di Joan Mitchell – biografica, psicologica, formale – l’anno 1967 appare come il momento d’una transizione importante, una porta aperta e richiusa, una cesura dentro il tempo della sua storia e della sua carriera. Quell’anno, sua madre, Marion Strobel, muore di un cancro. Grazie alla sua parte dell’eredità del patrimonio materno, è nello stesso 1967 che Joan Mitchell acquista la proprietà di Vétheuil. Infine, è a questa data che risale il suo rapporto con il gallerista Jean Fournier. Tutti questi avvenimenti, che segnano un allontanamento dalla sua terra natale, e un radicamento in Francia, dureranno fino alla sua morte nel 1992. 1967, « the goodbye door », per riprendere il titolo di un’opera del 1980. Sempre nel 1967, tre anni dopo Girolata Triptych, il suo primo polittico, Joan Mitchell riprende la forma del trittico, il cui titolo suona anche come un addio: Chicago. Questa comparsa, che diventerà una delle forme più ricorrenti della pittura astratta in Joan Mitchell, viene spesso trattata rapidamente, come en passant, dai critici e dai commentatori della sua opera, e da Joan Mitchell stessa. I vasti territori del Midwest da cui proviene, le caratteristiche del suo nuovo atelier, nello stesso tempo assai grande, e limitato in altezza da travi trasversali, sembrano essere sufficienti a spiegare, giustificare, inquadrare la sorprendente comparsa di queste tele, due, tre, quattro pannelli immensi, giustapposti senza separazione, ma nei quali nulla viene fatto per mascherare la sottile rottura.
Si può per prima cosa farne una lettura storica e geografica: nel momento stesso in cui Joan Mitchell va ad abitare in Francia, la forma del polittico la ricollega alla storia americana della pittura del dopoguerra (Barnett Newman, Mark Rothko, Jasper Johns, Ellsworth Kelly, Brice Marden, Agnes Martin, tra gli altri, hanno tutti fatto un uso ripetuto del polittico…). Il suo utilizzo più accentuato negli anni 1971-1973 è, da questo punto di vista, da collegare allamostra che la Mitchell prepara al Whitney Museum of American Art, la prima retrospettiva che le dedica un museo americano. E sono i suoi polittici che la storica dell’arte americana Rosalind Krauss sceglie di commentare in un articolo che appare in questa occasione in “Artforum”: Painting Becomes Cyclorama (La pittura diventa ciclorama). In esso ella fa direttamente riferimento al testo di Irving Sandler che, nel 1957, fonda storicamente il collegamento di Joan Mitchell all’espressionnismo astratto: Mitchell Paints a Picture (Mitchell dipinge un quadro). Rosalind Krauss analizza uno dei primi dittici di Joan Mitchell, Plage (Spiaggia), per dimostrare l’esitazione fondamentale dell’opera della pittrice tra la tentazione impressionista del paesaggio e le forme emblematiche degli espressionisti astratti. Per lei, la parte destra di questo dittico, formata da un gorgo di pennellate che rievocano le onde, ricorda il potere magico della pittura di evocare la natura senza mai uguagliarla. Le stesure uniformi, piatte, del colore che compongono la parte sinistra, al contrario, anche se Krauss vi legge le macchie colorate degli asciugamani da spiaggia visti dall’alto, somigliano ai segni astratti fluttuanti al centro dei quadri di Guston o di Gottlieb. Questa indecisione tra due ordini della rappresentazione, intensificata ancora dalla dimensione monumentale dei pannelli, ne fa secondo lei una sorta di “ciclorama”. Sebbene l’autrice non le citi mai, l’ombra delle Grandes décorations di Claude Monet installate nell’Orangerie aleggia costantemente sull’articolo.
Seguendo Rosalind Krauss, tentiamo un esame formale ravvicinato di alcuni polittici riuniti in questa mostra, esame che può fornire alcune informazioni sulla costruzione spaziale delle opere di Joan Mitchell, e pure sul modo assai particolare con cui esse orchestrano il tempo: tempo di produzione delle opere, tale da poterne conoscere qualcosa, tempo della loro percezione, tale che si dà attraverso i suoi svolgimenti e i suoi equilibri, i colori e le forme, le forme e i fondi, le continuità e le cesure. Infine, come e quanto questa percezione gioca con i titoli dati alle tele.
 |
Catalogo edito da Skira
“Joan Mitchell. La pittura dei due Mondi”
a cura di Sandro Parmiggiani
testo bilingue (italiano/francese)
presenta testi del curatore, di Nils Ohlsen (direttore della Kunsthalle di Emden), di Sophie Levy (direttrice del Muse’e des Impressionismes Giverny), di Yves Michaud, di Rachel Stella, di Brigitte Hedel-Samson, e di Gise’le Barreau (amica personale dell’artista, che rievoca il suo ininterrotto amore per la poesia e per la musica)
|
INFORMAZIONI UTILI:
JOAN MITCHELL. La pittura dei Due Mondi
22 marzo – 19 luglio 2009
Reggio Emilia
Palazzo Magnani
corso Garibaldi, 29
Orari: dal martedì alla domenica, 10.00-13.00, 15.30-19.00. Chiuso il lunedì
Biglietti: intero, Euro 7; ridotto, Euro 5; studenti, Euro 2
Informazioni e prenotazioni: tel. 0522.454437; fax 0522.444436
info@palazzomagnani.it
www.palazzomagnani.it