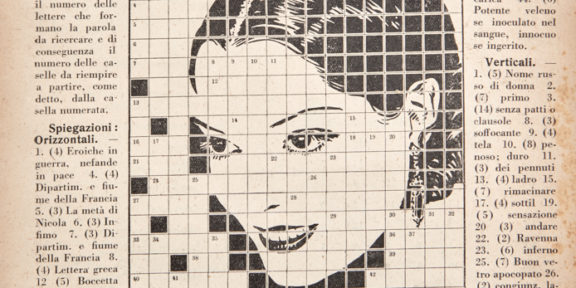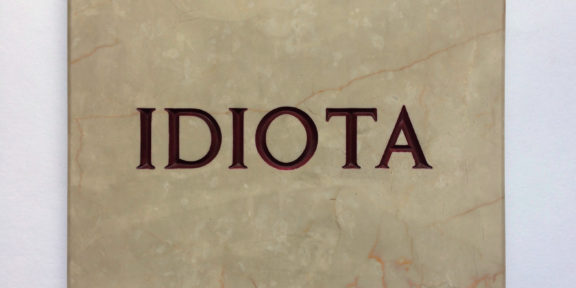Amarcord 39, Aspettando Godot – Un nuovo appuntamento con la rubrica di Incontri, Ricordi, Euforie, Melanconie di Giancarlo Politi
Mi fa ridere (e mi sorprende) constatare che questa reclusione ha contribuito a far esplodere le nostre cattive abitudini. Parlo di tutti (anche di me) ma in particolare di un pezzo di mondo dell’arte che è impazzito nella clausura e dalla paura (ma alcuni avevano espresso forti segnali anche molto prima) sprigionando esibizionismi molto spesso esilaranti, quasi sempre di cattivo gusto. E sempre, sempre, sempre autoreferenziali. Senza che nessuno di questi protagonisti consideri l’inquinamento visivo creato da loro attorno a noi. Lasciamo stare e sorridiamo per i mille artisti che interpretano il Coronavirus, invadendo tutti i social dell’universo con le loro offerte a tutte le ore, peggio della Ferragni che almeno spesso è divertente.
Ma no, questi artisti ci tempestano con immagini terrificanti della loro creatività emergendo dalla grotta degli orrori, rendendo ancor più pesante la clausura. Volti feroci, denti aguzzi, scheletri, fantasmi, forme disumane, teschi come quello di Damien Hirst che diventa un soprammobile da gioielliere (forse per cui è nato). Insomma tutta roba da tenerti allegro e di buonumore. Ma sono sorprendenti alcuni famosi curatori (e veramente bravi sino a che hanno fatto i curatori o i critici; ma sto parlando di alcuni tra i più importanti al mondo e che hanno inciso in modo significativo nel sistema dell’arte) e questi curatori si sono messi a fare i buffoni. Tra loro c’è anche il serioso e onnipresente e onnipotente curatore svizzero, tanto per non restare indietro.
L’artista è forse un buffone?
Ma buffoni sul serio e credo in modo convinto e talvolta creativo, a significare che tutto va bene madama dorè purché si sia sulla scena e per forse giungere alla conclusione che l’arte è una buffonata seria. E che forse questo Covid 19 non è che la cartina di tornasole per farci capire che l’arte è arrivata ad essere quel che è per divertire poveri e ricchi, giovani e no. Insomma per farci ridere. E che alla fine l’artista (e il critico e il curatore) deve essere solo un buffone, cioè sapere far ridere. E questi grandi curatori, ambiti da tutti e che hanno fatto la fortuna di molti artisti e ridimensionato molti altri, da critici si sono trasformati in artisti e giocolieri. E quali artisti! Buffoni di scena, amici miei, da far impallidire Domenego Tajacalze (il grande buffone a Venezia) oppure Antonio da Molino, il famoso Burchiello o anche il sempre verde Rigoletto alla corte di Mantova. E ad ognuno il suo. Uno dei più autorevoli critici americani usa ogni giorno montaggi grotteschi di Trump, oppure falli giganteschi in luogo di grattacieli e quasi sempre riferiti a Trump. Mi fa pensare a Travaglio ai tempi di Berlusconi (su cui aveva spesso ragione, ma ne fece un tormentone durato dieci anni per cui divenne noioso); poi per fortuna è arrivato Salvini e poi Matteo Renzi, e poi evviva, la Sanità Lombarda con i suoi morti, su cui ne avrà per anni.
Artisti canuti e barbuti come Messia
Ma oggi, artisti canuti e no, di buon lignaggio e anche di onesta carriera, vengono chiamati su Instagram dalla propria galleria o dal proprio referente oppure si autopropongono senza alcun ritegno, per spiegare a dieci o venti followers, cosa è l’arte al tempo del Coronavirus e come ci può salvare il corpo e lo spirito, novelli Mosè nel Mar Rosso. Eppure nessuno, pure gli artisti bravi, intelligenti e onesti, si rendono conto di quanto siano patetici e quanto ridicolizzino loro stessi e l’arte di oggi. A meno che non presentino senza troppi commenti semplicemente la loro opera. Che uno guarda e tira via.

E poi ci sono bravi critici nostrani, amici che io stimo, che tengono lezioni di storia dell’arte per contribuire ad affogare loro stessi e noi nella noia. Non capiscono che nessuno può reggere Instagram più di trenta secondi, a parte forse Giorgia Meloni che con le sue urla riesce a tenerti sveglio. Ma si sa, l’autoreferenzialità è il vero contagio dei tempi nostri e dunque bisogna mostrare pazienza ed esprimere tutta la nostra generosità verso il prossimo, per evitare di far credere che il Coronavirus ci ha portati via.
E forse capisco anche l’amico artista Giuseppe V. che ogni giorno, dico ogni giorno, al massimo due, annuncia che alle 17 avrà un incontro in streaming con critici veri che non resistono alla tentazione di vedersi invecchiati e imbruttiti e senza voce sul display del proprio cellulare, davanti a venti persone.
Ma Giuseppe V. è specializzato a coinvolgere amici del bar, da lui battezzati critici d’arte o collezionisti che hanno acquistato solo una o due sue opere per il piacere di avere una sua caricatura appesa al muro. Perché Giuseppe V., beato lui, ha una bella schiera di amici fedeli e inossidabili che lo seguono, lo proteggono e lo trattano da genio. Credo che un artista non possa chiedere di più. Ma Giuseppe V. in questa sua esigenza presenzialista è insuperabile e commovente e lungimirante. Lui che vive di provocazioni e di paradossi (e la sua è una divertente non pittura caricaturale), diventa carente di ossigeno e deve essere posto in terapia intensiva se non ha di fronte un pubblico di almeno cinque persone a cui ripetere le solite battute da venti anni. Come Gino De Dominicis, artista geniale ma ripetitivo come nessun altro, da imbarazzarti.
Giuseppe V. comunque tra tutti questi serpeggianti virus artistici è il più simpatico, perché ogni tanto ti strappa un sorriso forzato. Lui, arrivato da un paesino della Sicilia, ma accolto con affetto dalla comunità di Milano, di cui è diventato un piccolo protagonista. Ammirato e apprezzato da scrittori insensibili all’arte (penso al suo grande mentore, Andrea Pinketts, geniale scrittore noir da bar fumosi e mallevadore di disegnatori e illustratori sfortunati), Giuseppe V. è l’esempio di come l’intelligenza e la simpatia ti possano porre al centro della scena e a volte portare anche lontano. Bravo Giuseppe e tanta fortuna ancora a lungo per te.
Milano, la capitale dei terroni
Ma l’aspetto che più mi fa riflettere in questi giorni, è il razzismo che si è scatenato nei confronti di Milano. E chi mi dice che il razzismo in Italia non esiste mi fa ridere. Tutta l’Italia è da sempre ossessionata da Milano e oggi questi razzisti scatenati, sull’onda del pur bravo Saviano, che con il Nord si è ingrassato, gongolano per i decessi (troppo pochi per loro) avvenuti a Milano, per fatalità ma soprattutto per errori politici e incapacità. Un gallerista di Napoli, Francesco Annarumma, invoca maledizioni divine e decapitazioni e commissariamenti a raffica e prigioni a vita in ricordo di Silvio Pellico, verso la città più generosa d’Italia, dove solo lui ha fallito come gallerista.
In oltre 50 anni che vivo a Milano, non ho mai visto una galleria d’arte chiudere i battenti per incapacità gestionale e difficoltà economiche: tutte, dico tutte le gallerie qui a Milano sono sempre sopravvissute e spesso hanno raggiunto traguardi eccelsi, grazie alla sensibilità e generosità di Milano e della Lombardia. Perché, amici miei, qualcuno ignora che Milano è la capitale dei terroni, i quali hanno fatto grande questa città.
Sapete quanti milanesi ho conosciuto io in tutti questi anni di attività professionale, a volte anche frenetica? Quattro o cinque, forse sei. Giorgio Colombo, fotografo insigne che ha documentato come nessuno l’arte degli anni ’60 e ’70, Gianni Emilio Simonetti, intellettuale poliedrico e artista indefinibile, Giò Marconi, figlio del grande milanese Giorgio e Miuccia Prada, milanese storica. E forse Achille Mauri, ma non sono sicuro sulle sue origini milanesi.
Tutte le altre migliaia di persone che ho frequentato e con cui ho collaborato, sono terroni come me, spesso arrivati a Milano con la valigia di cartone ma con tante idee nella testa e volontà di realizzarle. In una città a braccia aperte per accoglierti. Ho scoperto che a Milano vivono 100 mila pugliesi e forse altrettanti abruzzesi e certamente ancor più campani. È Milano dunque la vera capitale del Sud.
Il Presidente Fontana o il Sindaco Sala, solo facce di bronzo
La sola persona che ricordo che abbia lasciato Milano scornata, è stato proprio il bravo Francesco Annarumma, che pure era stato generosamente aiutato da colleghi e amici. Uno di questi, Federico Luger, non proprio milanese, lo aveva facilitato lasciandogli il suo spazio in una zona mitica per le gallerie d’arte. E ora da Napoli, dove invece sopravvive, urla come un forsennato contro Milano e tutta la sua dirigenza, cancellando dal suo Instagram, qualsiasi opinione che si contrappone alla sua, chiedendo la pena di morte per tutti i politici milanesi.
Certo che dopo questa tempesta i vari Fontana, Gallera o Sala e molti molti altri, pagheranno per gli errori. Almeno spero. Ma i razzisti che urlano contro Milano non capiscono che questi signori qui in città contano come il due di briscola. O poco più. Perché Milano in realtà è governata da una economia e imprenditoria abbastanza illuminata, anche se a volte un po’ infiltrata dalla mafia ma pur sempre intelligente e progressista, la stessa che ha creato il Salone del Mobile, l’evento commerciale e culturale più importante al mondo e che genera un fatturato di oltre 21 miliardi di euro. Quasi quanto il Pil della Campania.
E Milano ha inventato la Fashion Week che non ha lo stesso impatto economico del Salone ma che per dieci giorni fa sentire la città, con tutta la sua creatività e bizzarrie, il centro dell’universo della comunicazione e delle nuove tendenze. E pochi forse sanno che MIDO, la più importante fiera degli occhiali al mondo, per dieci giorni e nemmeno aperta al pubblico, riempie tutti gli alberghi di Milano, Lombardia e parte dell’Emilia.
E questa è la Milano che determina gli orientamenti culturali ed economici della città e non solo, non certo le tre o quattro facce di bronzo che più spesso appaiono in TV e che ogni quattro anni si cambiano: in Italia, in quanto a facce politiche presentabili non c’è molto da scegliere. Anche se presto sostituiremo queste facce inguardabili per proporne altre, forse peggiori. In Italia (nel mondo?) quando tocchi la politica metti le mani in un nido di serpenti. Ma Milano ha realizzato un quartiere fieristico invidiabile (non solo l’Ospedale in dieci giorni), la nuova City, il Bosco Verticale, la Skyline che è un modello di bellezza e di efficienza e ora, qui, di fronte a casa mia, nell’ex Dogana Farini, affidato all’architetto Rem Koolhaas, si sta realizzando il più grande e incredibile giardino botanico d’Europa. E verranno in aereo e in pullman da tutto il mondo a visitarlo.
Il razzismo, come il campanilismo, è sempre esistito
Cari amici, il razzismo ma soprattutto il campanilismo anche di quartiere in Italia esiste da sempre (da ragazzo, a Trevi, con alcuni compagni la sera ci spostavamo nella frazione accanto, a 500 metri, per prenderci a sassate: e la sera tornavamo tutti a casa con la testa rotta per essere presi a calci nel sedere da nostro padre). E poi la domenica si giocava felicemente a calcio tutti insieme. Ma in tutti questi anni in cui vivo a Milano (dal 1970, fate i conti voi) non ho mai sentito un accenno razzista nei confronti del Sud (a parte la esternazione fraintesa di Vittorio Feltri che a 80 anni è in cerca di sollecitazioni emotive e di scossoni psicologici per sentirsi vivo, ma che, non ignoriamolo, è stato una grande nave scuola per numerosi giornalisti del Sud).
Chiedete, ma purtroppo non c’è più, a Salvatore Ala, arrivato da un paesino della Sicilia, mi pare Barcellona, a vendere grafiche d’artista porta a porta e in poco tempo è diventato un gallerista di riferimento internazionale, chiedete alla napoletana, nostro grande orgoglio e patrimonio culturale nazionale, Lia Rumma, di quanto sia razzista Milano. O avreste dovuto chiedere al calabrese Gianni Versace e a sua sorella Donatella, o ai siciliani Dolce e Gabbana. E sempre per la moda a Massimo Giorgetti, MSGM, e la cui ultima campagna si intitola Milano Milano Milano, un inno d’amore alla città. Perché la moda a Milano è retaggio del meridione inventivo e geniale.
O se vogliamo parlare di musica, mio punto debole, citiamo l’ottimo Achille Lauro, che certo brianzolo non è. O il grande Mimmo Rotella, reuccio di Roma, Parigi e poi Milano. Calabrese sino all’osso, da tenere in casa un clan di amici calabresi. Chiedetelo anche a Giacinto di Pietrantonio da Lettomanoppello in Abruzzo o a Massimiliano Gioni da Busto Arsizio o anche a Salvatore Siena, originario da qualche paesino della Sicilia e da tempo primario oncologico all’Ospedale Niguarda, tra i primi dieci centri oncologici al mondo.
O allo straordinario Pierluigi Sacco da Pescara, che qui a Milano sta studiando, insieme ad altri, come contribuire a far sopravvivere la cultura e l’impresa illuminata in Italia. O a Cristiano Seganfreddo, che con la sua Fondazione Marzotto, di Valdagno che opera anche da Milano, individua e offre sostegno a centinaia di Start Up italiane, quelle che nessuno conosce e che invece forse guariranno questo paese. O Gianfranco Maraniello, direttore del Mambo e ora del MART, forse milanese per caso ma figlio di napoletani doc come Giuseppe e Titti, sua madre, di cui ancora noi famiglia Politi avvertiamo il vuoto per averci lasciato troppo presto.
Questi alcuni nomi che mi vengono in mente. Ma se volete ne potrei fare centinaia. Ma tutta Milano e forse molta Lombardia sono un laboratorio per i volenterosi di tutto il mondo e soprattutto del Sud Italia. Milano e la Lombardia e il Veneto con i dovuti raffronti, sono la New York e la Silycon Valley italiana, veri motori e acceleratori di volontà e qualità.
La Sanità milanese? Ospedali come il Cardiologico Monzino, forse il primo in Europa nel suo genere o l’Istituto Stomatologico Italiano o il Policlinico, dove la mia amica Daniela dall’Umbria è venuta più e più volte e a costo zero, per un complicatissimo e riuscitissimo trapianto del fegato, rappresentano delle grandi eccellenze pubbliche mondiali che nessun errore politico può oscurare. Certo, oggi la Sanità Lombarda ha evidenziato le lacune della Sanità Italiana, giudicata dai politici e giornalisti faciloni la migliore d’Europa. Però se la Sanità Lombarda, malgrado alcune défaillance dovesse chiudere le frontiere, mezza Italia, forse di più, piangerebbe lacrime amare. Solo il Veneto può reputarsi più organizzato della Lombardia, senza però possederne le medesime eccellenze. E vorrei chiedere a chiunque, se dovesse scegliere tra il Cardarelli di Napoli e il Policlinico di Milano, a chi si affiderebbe.
Il vero razzismo nei confronti di Milano e che a me fa ridere, arriva dal Sud
Io il vero razzismo, fomentato da una insana cultura antropologica, l’ho visto e vissuto in prima persona solo in Sardegna, dove più volte mi hanno intimato di tornare nel continente perché non avevano bisogno di me in vacanza. E forse avevano ragione. Avevo sbagliato io a non scegliere la Liguria o la Versilia o anche il Veneto. Dove mi sento più congeniale. Ma in Sardegna ho anche incontrato amici per una vita, generosi e sempre disponibili a donarti il cuore e anche l’anima. E questo solo in Sardegna, sdegnosa, arcigna e generosa. Io invece ho un grande rispetto per l’orgogliosa e coltissima e impenetrabile altezzosità del duca di Salaparuta, Tomasi di Lampedusa, che anticipando qualsiasi clausura, malgrado la sua ricchezza, si vantava di non essere mai andato da Salaparuta oltre Palermo. E quando suo cugino, il poeta Lucio Piccolo lo costrinse a seguirlo a Viareggio, mi pare, per presentarlo ad Eugenio Montale, lui si sentiva come un pulcino fuori dal guscio, lui, il grande e inaccessibile intellettuale siciliano, erede morale di Federico Secondo e della Scuola Siciliana, dalla battuta fulminante.
Amici, non toccatemi la mia Sicilia, che forse non rivedrò mai più ma che a Ortigia, mi ha offerto una delle più solari vacanze estive della mia memoria. Alla faccia del razzismo nazionale, spesso più ostaggio dei media che reale. Certo, le diversità a volte sgomentano, ma noi italiani sappiamo integrarle con estrema facilità e con una pacca sulla spalla, se non ci fosse una classe politica sempre pronta a strumentalizzare tutto per raccattare qualche voto e una generazione di giornalisti considerata la più corrotta d’Europa, salvo alcune luminose eccezioni.
Io sono sempre stato un po’ razzista
A pensarci bene io sono sempre stato un po’ razzista. Nei confronti degli imbecilli, dei burocrati, degli ignoranti arroganti, dei politici stupidi (dunque quasi tutti), dei fascisti mentali, annidati a destra, centro e soprattutto a sinistra. E fascisti tra gli ideologi di sinistra che non si rendono conto del male che hanno fatto al mondo e ne fanno ancora all’umanità.
L’Arte Povera è orfana

A Torino ho partecipato alle primissime riunioni che preludevano la nascita del’Arte Povera. Si era agli inizi del 1967 e il grande collezionista torinese, il vero mentore dell’Arte Povera, Marcello Levi, aveva affittato un grande spazio, DAP, Deposito Arte Presente, dove aveva raccolto opere di Giovanni Anselmo, Alighiero Boetti, Pier Paolo Calzolari, Mario Merz, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zorio, Ugo Nespolo, Gianni Piacentino, Piero Gilardi. Non assomigliava ad uno spazio espositivo ma ad un caravanserraglio, con materiali (poi definiti opere) sparsi sul pavimento o attaccati alle pareti. Si respirava un’aria di libertà e di rinnovamento che ti faceva sentire al centro di una piccola rivoluzione. Un giorno tutti gli artisti riuniti e qualche appassionato (il sottoscritto, Gian Enzo Sperone, Tucci Russo, qualcun altro) arrivò da Genova Germano Celant, tutto di nero vestito e al centro del conclave, prese la parola e rivolto agli artisti: tra noi dobbiamo stabilire un rapporto da regime militare.
Nessuno di voi potrà realizzare una mostra senza il consenso di tutti gli altri, nessuno potrà decidere di esporre in un museo o galleria se non avallato da tutti. Nessuno potrà vendere un’opera se non saremo tutti d’accordo. Il bastone del comando resta a me (questo non lo disse ma lo fece capire). Il riferimento militare del momento era il generale vietnamita Giap, il Napoleone Rosso, grande stratega della guerriglia (Appunti per una guerriglia, si chiamava il manifesto dell’arte povera pubblicato in Flash Art a ottobre/novembre 1967) che sconfisse prima l’esercito coloniale francese e poi le truppe americane. Ebbene, disciplinati come soldatini vietnamiti, tutti gli artisti presenti aderirono alle proposte di Germano Celant ubbidendo. E chi non obbedì fu espulso dal gruppo.
Se il nemico si concentra perde terreno, se si disperde perde forza.
Questa una massima del generale Giap, diventata un’opera storica di Mario Merz, esposta a Documenta nel 1972 ma anche una sorta di massima del Gruppo. Il rigore militare voluto da Germano Celant durò a lungo, sino a che alcuni artisti (Penone, Pistoletto, Boetti) non divennero più forti del capo che li aveva messi insieme. Ma il gruppo talvolta cambiò pelle ma non si disgregò mai.
La parola di Germano aveva sempre un grande potere, mentre io sono ancora sorpreso da come il grande critico genovese sia riuscito a tenere in pugno un gruppo di scalmanati sempre imbizzarriti e spesso gli uni contro gli altri.
Ciao Germano. Sarà ancora la tua parola dei tempi d’oro, Vangelo per i tuoi soldatini ormai promossi generali?
Per scrivere a Giancarlo Politi:
giancarlo@flashartonline.com