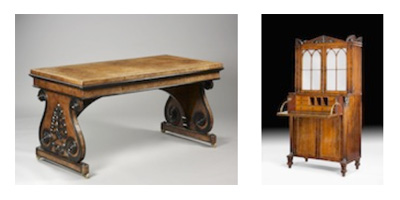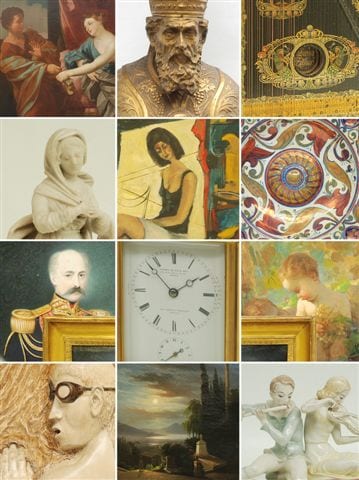Daniele Marzorati (Novedrate, Como, 1988), lavorando con il disegno, la pittura e la fotografia, indaga le narrazioni costruite e conservate dall’immaginario della società, portando alla luce le strutture identitarie, coloniali e politiche in esse presenti.
Parte di Off Topic – progetto dialogico di Gianluca Gramolazzi che si sviluppa, di volta in volta, su un’unica tematica, tralasciando le opere o le mostre – questa conversazione mostra il pensiero dell’artista focalizzandosi sugli oggetti legati alla colonizzazione.
Il processo di globalizzazione ha alterato le culture locali a favore di un’unica cultura globale. Nelle prime campagne di marketing globali, come quelle di Benetton, viene presentato un mondo che include tutte le diversità, appiattendole e strumentalizzandole. Nonostante ciò le culture locali hanno cominciato a essere influenzate dalle immagini della cultura globale. In questa interconnessione continua di appropriazioni, sintesi culturali e schiacciamento dell’individuo si è creata una cultura omologata che non dà spazio a novità.
Viene trasmessa l’idea di dover lavorare con la novità, l’inedito, qualcosa deve essere di consumo immediato ma, d’altra parte, anche questa condizione non è in realtà nuova.
Sicuramente non si possono dire cose inedite. Sono nuove solo perché caricate della soggettività.
Penso esista la possibilità di avere un pensiero indipendente, la cui identità sia legata al corpo e al tempo. La differenza tra un pensiero nuovo, nel senso di individuale e uno omologato, massificato, penso stia nel riconoscere la realtà per quella che è, al di là di astrazioni, teorie, propaganda e senso comune. Forse dovremmo pensare a saper distinguere tra un nuovo capace di aprire a visioni, e un nuovo unicamente per data di produzione a noi vicina, dunque legato al (consumato) sminuito concetto di contemporaneo. Ad esempio, il concetto di alterità spesso è utilizzato in modo semplicistico e abusato, nel mio lavoro lo penso come singolarità di ognuno, ossia di rispetto della differenza e dell’individualità. Il Diverso è quindi un potenziale, per citare Victor Segalen: “la diversità delle culture umane è dietro a noi, attorno a noi e davanti a noi”.

Il colonialismo ha messo a contatto culture distanti, contaminandole e alterandole in maniera significativa. Ad esempio, il bambù è diventato una pianta di largo consumo, soppiantando la canna comune sia per uso ornamentale sia per altri usi. Come il processo di globalizzazione, quello coloniale, ha modificato le immagini e la visione sugli oggetti, uniformando i desideri e la percezione del reale.
Alcuni miei lavori sono strettamente legati al tema del colonialismo e considerano la vegetazione come aspetto centrale da cui evidenziare le strutture di potere imperialiste. Ad esempio Sezioni (2015-2016) legato ai tagli boschivi per la produzione di carbone effettuati in periodo fascista nell’entroterra sardo o Déplacement (2017-2019) in cui ricerco l’intreccio tra la vegetazione locale e i platani originariamente piantumati nella concessione francese a Shanghai seguendo il modello dei boulevard parigini e attualmente diffusi ovunque nella città. Certamente il colonialismo ha avuto un ruolo determinante nella contaminazione forzata di elementi vegetali e non solo e, la globalizzazione, determinata alla sua radice dal sistema capitalistico eurocentrico bianco e maschile formatosi dal 1492 in poi – data indicativa – è un processo che ne fa parte. Queste relazioni sono state analizzate da figure come Aimè Cèsaire, Frantz Fanon, o altri ancora. Personalmente mi interessano i loro punti di vista che sono spesso per me delle istanze di partenza e mi aiutano a scegliere gli oggetti, i luoghi, le situazioni a cui guardare. A mio avviso è importante che il lavoro si fondi su oggetti già indicativi e connotati, anche storicamente, perché ci permettono di vedere altro. Questo che mi sembra renda significativi sia gli oggetti, sia lo spostamento che la mia operazione visiva compie su di essi nel tentativo di diramarsi il più possibile, quindi loro o la storia non sono il punto d’arrivo. La superficie degli oggetti in fondo è solo il loro aspectus.
Mi sembra che la tua intenzione sia quella di immaginare che cosa l’immagine potrebbe dire in relazione al proprio contesto, mediante uno sguardo differente. Prima accennavi al concetto di alterità, in cui lo sguardo è un argomento centrale. Quando poniamo lo sguardo sopra qualcosa, non bisogna dimenticare come e quanto la visione sia alterata dal pensiero occidentale ed eurocentrico.
La questione dello sguardo, soprattutto se pensata attraverso un soggetto guardante, è indubbiamente legata all’uomo occidentale. La storia dell’arte occidentale ci propone infatti molti esempi: la finestra dalla quale si apre il punto di vista (la prospettiva rinascimentale) o lo specchio in cui ci si riflette (il romanticismo/surrealismo). Campo e controcampo potremmo dire, ma entrambi legati all’individualità. Al di là di questo dualismo personalmente cerco di lasciare più spazio possibile all’osservatore attraverso le mie immagini. Molte volte mi chiedo se la mia operazione sia quasi invisibile, ma a mio avviso l’operazione differente risiede proprio nell’“invisibilità” che è costituita da molte scelte volte a determinare l’immagine in modo silente, e a renderla attraversabile al di là della narrazione che è lo storytelling attualmente voluto. In questo credo risieda la mia operazione sullo sguardo e sulla poetica; nel momento in cui l’osservatore ha spazio per interrogarsi e per interrogare gli oggetti che sta guardando, partendo dalla superficie visibile che gli si palesa davanti, forse scompare in parte il punto di vista, perché le risposte che l’immagine può dare non sono veicolate fino in fondo. La scelta della figura da cui partire diventa fondante, ma resta solo iniziale. Da lì in poi spero che la figura diventi immagine, apertura.

Gli oggetti e il modo in cui si guardano sono stati nel corso del tempo, anch’essi, modificati da flussi continui di persone e di culture. I latini hanno colonizzato la zona dei liguri apuani ed etruschi, sostituendoli e mischiandosi con loro. Però, come è successo a molti antropologi culturali francesi, oggetti tribali venivano considerati come manufatti artistici e inseriti in musei, non rispettandone l’uso. Perché l’oggetto culturale è da salvaguardare? Che cosa può apportare alla contemporaneità? Dal 1970 l’Unesco ha sancito la restituzione di oggetti espropriati illecitamente da paesi stranieri. Qui si pone un’ulteriore riflessione: da una parte un oggetto trafugato, esposto in un museo occidentale, ha permesso di sviluppare un pensiero che ha modificato la cultura nel quale è stato inserito, ad esempio Les Demoiselles d’Avignon di Picasso; d’altra parte lo stesso oggetto mi sembra risulti depotenziato nella propria cultura di riferimento. Quindi riconsegnare o no? Esiste una risposta?
Al di là della restituzione e di ciò che l’oggetto subisce (viene depotenziato o meno?) credo sia importante affrontare il problema perché ci permette di ristabilire i criteri di relazione tra gli oggetti, tra le strutture di pensiero che li incasellano e il modo in cui esse si innestano nel presente. Sono queste strutture ancora condivisibili? Per essere più diretto, non credo affatto che si decolonizzino i musei spostando parti di collezioni, cambiando le diciture delle immagini o usando le quote di rappresentanza legate al sistema teorico museale che attualmente discute la decolonizzazione restando unicamente retorico. A mio parere la questione è stabilire un diverso approccio, se vogliamo essere con J. Beuys, direi stabilire una “Terza via” che fuoriesce da un dialogo binario. La vera domanda successiva è: ma come la costruiamo? Questo è il punto più difficile a cui sinceramente non ho una risposta lineare. A ciò cerco personalmente di rispondere attraverso il mio lavoro e quindi potremmo dire la creazione di una “Terza via” nella produzione delle immagini.
Ad esempio con questa logica strutturo i miei lavori ed è per questo che uso una macchina fotografica di grande formato, pesante e direi quasi disfunzionale. Essa quasi per statuto mi mette nelle condizioni di considerare la fallibilità, l’errore e l’imprevisto come parte del corpo del mondo da accettare e con cui fare i conti. Ciò credo permetta di aprire delle visioni di cui neppure io conosco il più delle volte la risposta se non nei presupposti iniziali che la costituiscono, e nella direzione che voglio essa prenda (ossia la scelta dell’oggetto da osservare). Si parla spesso ad esempio di rimosso coloniale, ma molto sta sotto la luce del sole anche se, il più delle volte, resta inosservato, tralasciato. Probabilmente non utilizzerei neppure il termine marginale, perché molti di questi oggetti sono esposti in luoghi pubblici o in musei. Si tratta quindi di riportare alla coscienza, al pensiero attivo, al corpo delle persone ciò che gli si presenta dinnanzi. Per dare un esempio concreto: ho ultimamente lavorato a Parma attraverso la figura di V. Bottego e con i reperti presenti nel Museo di scienze Naturali di Parma. Il monumento a lui dedicato si trova nella piazza della stazione e gli animali che si vedono nelle mie immagini sono nel display del museo. Forse allora non li vediamo bene proprio perché queste due strutture, trasparenti e abitudinarie, non ci permettono di guardare ai corpi, agli oggetti partendo dalle loro figure e dalla loro materia, per entrare nella loro carne e capire di cosa sono costituiti. Forse per aggirare il colonialismo dobbiamo usare questa posizione, iniziare a passare attraverso le strutture che lo contengono per far aria intorno ai loro contenuti e dar quindi nuova vita senza la gabbia ideologica che finora li conteneva.
Seguendo questa logica ho pensato di riumanizzare i corpi di Omo e Giuba del monumento di Parma e di avvicinare gli animali contenuti nel museo, per cercare, solo per mezzo dei protagonisti che possono parlarci in modo diretto, di trovare qualcosa in più, al di là di tutto ciò che noi già pensavamo di conoscere e di ciò che gli avevamo recintato intorno. Credo quindi sia necessario un atto di rinnovata coscienza per trovare qualcosa di nuovo in ciò che nuovo non sembra affatto. La restituzione di reperti può essere quindi un atto, o una parte del processo, ciò che è determinante è il cambiamento dei piani di relazione tra le parti e le strutture di pensiero che le regolano nella prassi.

Questo contenuto è stato realizzato da Gianluca Gramolazzi per Forme Uniche.
https://www.danielemarzorati.com/
https://www.instagram.com/daniele.marzorati/