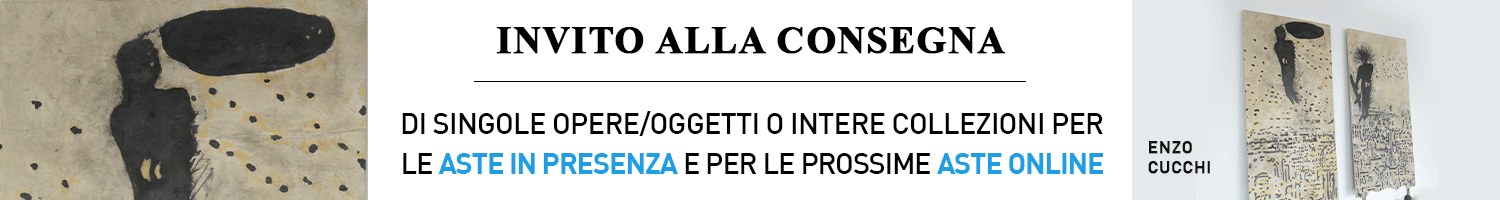Illumina il Lido Bones and all, capolavoro horror romantico di Luca Guadagnino interpretato da Taylor Russell e Timothée Chalamet
– Pronto? Hai un minuto? Sono sconvolto!
– Pronto! Che succede? Hai una voce turbatissima… Sei lì al Lido?
– Sì, sì, tranquillo. Devo solo scaricare l’emozione. Defribillarmi un attimo…
– Cos’hai visto di così sconvolgente?
– “Bones and all”, il nuovo Guadagnino.
– Ah, cavolo! Sono tutt’orecchi!
– Niente. Un capolavoro. Sono, te lo giuro, in estasi. Ormai lui, che considero il nostro maggiore living director, è una garanzia, ma ogni volta riesce a superarsi.
– Addirittura? Ho letto che è una storia di cannibali…
– Sì, certo. Un “horror romantico”. Ma, come ogni film di genere particolarmente ben riuscito, è anche cento, mille altre cose. Intanto è bellissimo, struggente, tenerissimo, violentissimo, un sensazionale viaggio on the road nel cuore degli USA più suburbani, illuminati la notte dai lampioni fiochi e dalle luci interne delle case a due piani col giardino intorno: sembra di sfogliare per due ore un catalogo di fotografie di Todd Hido. Ma è soprattutto una metafora straordinaria e decisamente inedita della “diversità”: “Quando hai scoperto di essere così?”, “Anche mio padre lo era”, “Tra di noi ci si riconosce tutti”, “Siamo condannati a restare così per il resto della nostra vita”, “Non potremo mai essere come gli altri”, e via così. Come se in tempi di ipercorrettezza politica e dittatoriale inclusività, Guadagnino volesse provocarci col dire “Vediamo se avete il coraggio di includere anche questi qui”, e chiarire una volta per tutte che se sei diverso, qualunque sia la tua “diversità”, sei condannato a restarlo per la tua intera vita; la sfida è riuscire a fartene una ragione senza fingere di essere uguale agli altri e nasconderti sotto il consenso di quelli che non hanno la minima idea di come tu sia fatto, dentro o fuori.
– Davvero c’è tutto questo nel film, o è una tua elucubrazione personale?
– Te l’ho detto: è un film di genere. Un horror, per quanto romantico e disperato. Cosa credi, che i morti viventi della famosa “Notte” di Romero siano solo morti viventi, e basta?
– Capisco. Ma non è che tanto sangue e tanto splatter terranno lontani gli spettatori?
– Questo non so dirtelo. A me sta a cuore il cinema, e quando ne vedo così tanto schizzare dallo schermo, me ne lascio irrorare a fiottate. C’è una tensione lirica e drammatica degna degli evidenti mostri sacri presi a modello, da Romero a John Carpenter e Scorsese… Perfino l’Hitchcock di “Frenzy”, nel mostrare da dentro e da fuori la scena del crimine (o del rito di sangue…). Chalamet, già grissino di suo, ostenta 63 chili di magrezza scheletrica, in contrasto con l’ambra della pelle di Taylor Russell: sono loro la coppia dei giovani amanti cannibali, manifesto di una generazione che i padri se li è persi per strada, e ne ha ereditato colpe fatali e irredimibili; un Romeo e una Giulietta sopravvissuti alle tombe di famiglia, in fuga dentro i tramonti rosso sangue dell’America degli anni ‘70, quella di Tobe Hooper e di tutti quegli altri registi che con i loro B-movie ne hanno descritto il cupo e strisciante disagio. Una storia maledetta, disperata, talmente densa ed eticamente complessa da rischiare di scadere in un incongruo e improbabile lieto fine. Ma quando il film finisce, con le lacrime agli occhi ti rendi conto che i protagonisti e il regista ne sono venuti a capo nell’unico modo possibile: loro due con l’Amore, e l’altro, semplicemente con il Cinema.
– Accidenti che peana!

– Ci voleva, però, per rifarmi delle altre due visioni della giornata. Intanto “Bardo”, di Alejandro Inarritu, ormai distante anni luce dai capolavori degli inizi. Una specie di “Otto e mezzo” tra Fellini, Malick e Bela Tarr, pieno di immagini favolose e visivamente orchestrate da padreterno, purtroppo al servizio di un vuoto pneumatico e drammaturgico addirittura claustrofobico. Unico gran bel momento, la sequenza della discoteca, commentata da “Let’s dance” di David Bowie (‘la più bella canzone degli anni ‘80’, come diceva una mia ex compagna di università), purtroppo inserita in un flusso di eventi di grottesca banalità e fastidiosa eccentricità, che vorrebbero stupirti con l’aggiunta di effetti speciali e distrarti dall’imbarazzante egoriferimento di un regista che ormai anche i meme sui social danno irrimediabilmente in caduta libera… Vedrai che magari un Leone glielo danno pure!
– Senza appello, vedo. E l’altro titolo?
– “Tár”, di Todd Field. Un film che più che pregi, ha senz’altro buone intenzioni. Ma il risultato finale è un fogliettone piatto e patinato, come quei bestseller prefabbricati che riescono a piazzarsi nelle classifiche dei libri più venduti. È la storia di una direttrice d’orchestra (per fortuna NON è un film che vuole convincerti che anche le donne possano esercitare con successo una professione in cui hanno sempre brillato soltanto bacchette maschili), guarda caso lesbica, intelligente, musicalmente preparatissima, baciata da un successo stellare che l’ha portata a incidere quasi tutto Mahler (tranne la Quinta Sinfonia) con le più grandi orchestre del mondo. Insegna nella più prestigiosa scuola di musica di New York, dove bacchetta fieramente qualche studente che, intortato dalle recenti teorie sulla sessualità, rifiuta Bach giudicandolo un abusatore seriale di Magdalena (sua moglie) perché la ingravidò di 20 figli… Fin qui tutto bene, e chi pasteggia con la musica classica come il sottoscritto rischia anche di divertirsi, poi però prevalgono quelle regole del cinema secondo le quali un film non può andare avanti a parlare di Bach, Bernstein e Mahler e pretendere di trionfare al box office. Perciò salta fuori che il Maestro Tár, felicemente accoppiata con il primo violino della Filarmonica di Berlino (che è una donna) nonché mamma di una figlia adottiva, non è insensibile al fascino delle giovani fanciulle, come la sua giovane assistente italiana, un’altrettanto giovane violoncellista russa, e un’allieva del suo corso di direzione d’orchestra, problematica e possessiva, dalla quale tenta di smarcarsi. Molti sono, in sceneggiatura, i riferimenti al MeToo e alla pratica di distruggere carriere di astri della musica, espressamente citati nei dialoghi (James Levine, Charles Dutoit, Placido Domingo), accusandoli di presunti abusi sessuali mai comprovati da alcun procedimento legale. Adombrati da strane sequenze riprese con il cellulare da anonimi stalker, affiorano anche nel plot pesanti dubbi sul comportamento della musicista, che esplodono in uno scandalo in seguito al suicidio di una delle ragazze da lei concupite. Ben presto alla qualità dei discorsi sulla musica, effettivamente ben scritti, si sostituisce un mélo da fiction di lusso, che nel finale sfocia nel ridicolo, addirittura nel “camp”. Mi sarei aspettato ben altra prova da Cate Blanchett, solitamente sublime, qui invece molto deludente nelle sequenze sul podio direttoriale, dove viene meno la meticolosa cura del regista, autore anche dello script, nel ricostruire il cinematograficamente (oggi) poco frequentato mondo della musica classica, dei musicisti e delle sale da concerto (numerose sono le sequenze girate all’interno della celeberrima Philharmonie di Berlino): la gestualità direttoriale della Blanchett non risultava credibile neppure dai trailer. Nuoce, peraltro, a un film che tuttavia qui al Lido ha riscosso un successo notevole da parte di un pubblico ormai modificato percettivamente dalla quantità di fiction che circolano indisturbate sui nostri schermi domestici, l’eccessiva lunghezza: quasi tre ore!…
– Per fortuna che c’è Guadagnino.
– Per fortuna, sì! Per fortuna!
https://www.facebook.com/people/Anton-Giulio-Onofri/1405664800