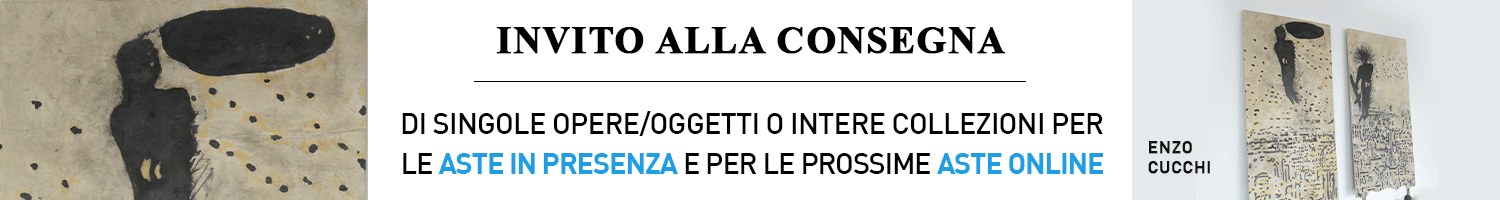Tornato a mani vuote da Cannes nonostante l’ottima accoglienza, Rapito pare uno sceneggiato a metà tra il fogliettone e il romanzo popolare
– Hai visto “Rapito”.
– Sì, ahimè.
– Ma come? Da Cannes non sono arrivati che elogi sperticati…
– Comprendo benissimo che il glamour di una prima mondiale di gala sulla Croisette possa benevolmente influire sugli umori e sui giudizi degli accreditati convenuti. La nuda e cruda sala di un cinema romano in una serata infrasettimanale al termine dell’ennesimo giorno di pioggia (e quaranta minuti spesi a trovare parcheggio col rischio di mancare la proiezione stampa) mi ha invece, credo, restituito il nuovo Bellocchio con tutta l’evidenza delle sue carenze e debolezze. Parlo per me, ovviamente, che già non ero uscito entusiasta dalla maratona di “Esterno Notte”…
– Mi ricordo, mi ricordo.
– Ma lì qualcosa di buono c’era, nonostante si trattasse del bis della vicenda Moro già trattata nel magnifico “Buongiorno Notte”. La natura televisiva della miniserie non soffocava del tutto un racconto tratteggiato dalla felice irruenza cinematografica delle zampate da anziano Maestro. Il fatto è che chi anagraficamente, come purtroppo il sottoscritto, ha seguito in diretta l’intera carriera di un cineasta nato come enfant terrible, cresciuto all’ombra di Padreterni senza più riuscire a brillare particolarmente, nemmeno approfittando, via via, di una scena lasciata sempre più vuota dalle morti di Pasolini, Visconti, Rossellini, Fellini, Antonioni (ma pure Germi, Petri, Risi, Zurlini, Pontecorvo, Bertolucci, Loy, Olmi, Maselli, e tutti quelli che mi sto dimenticando), infossandosi poi in un tunnel creativo apparentemente senza via d’uscita (dio mio che brutti, o almeno che modesti, i suoi film degli anni ’80 e ’90!…), per poi riesplodere nel nuovo secolo con quell’oggettivo capolavoro che è “L’ora di religione”, ma azzeccando in seguito un film ogni due o tre con troppo altalenante cadenza qualitativa, chi come me, dicevo, lo segue praticamente da sempre, non può non incontrare qualche difficoltà a chiamarlo “Maestro”. Bellocchio ha saputo, questo glielo riconosco, rinnovarsi ed evitare di invecchiare adottando formule di racconto sempre aggiornate, come ha dimostrato con “Il traditore”, dove sembra aver assimilato con successo linguaggio, forme e ritmi del mélo televisivo delle odierne fiction, senza smarrire l’ampiezza e la densità del passo cinematografico. A me personalmente non è piaciuto “Vincere”, mentre ho apprezzato senza riserve “Il regista di matrimoni”: cito questi due titoli per farti capire quanto il suo cinema tenda a sfuggirmi di mano ad ogni nuovo titolo, spiazzandomi e impedendomi di riuscire a trovarci un filo rosso, una continuità di mano e di stile. Perciò “Il traditore” mi ha sorpreso favorevolmente dopo quelli che personalmente considero veri e propri tonfi, cioè “Bella addormentata”, “Sangue del mio sangue” e “Fai bei sogni”. Tutti film, comunque, che potranno anche piacerti o non piacerti, ma che non garantiscono a sufficienza l’oggettivo tasso di qualità e autorevolezza che fa di un cineasta un “Maestro”.
– Severo. Forse troppo. Ma il tuo discorso ci sta pure.
– Di buono c’è che non si è involuto nelle lentezze e nelle rarefazioni che hanno infestato le opere della vecchiaia di molti, quelli sì, Maestri, vittime di un forse fisiologico inaridimento creativo. Il cinema del Bellocchio ottantenne sembra anzi prediligere la baldanza e i tempi veloci di un mélo che abbondi di concitate cabalette e scatenati pezzi d’insieme: ma spesso la sensazione è quella di un’isteria non calibrata, di tasti di pianoforte pestati con incontrollata esuberanza, di eccessivo didascalismo. Qualunque sia la storia che racconta. Difetti che in questo “Rapito” (titolo che sa di appioppo provvisorio, poi mantenuto per mancanza di estro ulteriore) distraggono dagli aspetti morali, etici e drammatici della vicenda del piccolo ebreo bolognese sequestrato alla famiglia dagli sgherri di Papa Pio IX verso la metà dell’800 per iniziarlo alla fede cattolica, perché una servetta, spaventata nel vederlo malaticcio in culla, decide di “battezzarlo” all’insaputa dei genitori con un rito tanto arbitrario quanto “fai da te”.

– Era un progetto di Steven Spielberg, poi abbandonato perché pare non sia riuscito a trovare l’interprete giusto per il ragazzino protagonista.
– Secondo me, ma posso sbagliare, la vera ragione della rinuncia di Spielberg non può essere questa. La mia opinione è che lui abbia capito in seconda battuta che un fattaccio del genere non era semplicemente una storia di Buoni e Cattivi come “Schindler’s List”: in quel caso i nazisti, cioè il Male Assoluto, potevano essere rappresentati, salvaguardando i dettami dello stile e della credibilità narrativa, come spietati assassini, aguzzini a sangue freddo, invasati dall’ideologia suprematista di un pazzo che comunque aveva risolto i problemi economici di un Paese alla deriva dopo la deflagrazione dei fasti imperiali con la sconfitta di una guerra mondiale. Tutto un altro affare è il caso della Chiesa Romana del diciannovesimo secolo che, per quanto macchiatasi di azioni indiscutibilmente riprovevoli come questa illustrata nel film, aveva ragioni sue proprie giustificate da un contesto storico, politico, ideologico, intellettuale e spirituale che oggi può risultare senz’altro incomprensibile ai nostri contemporanei postmoderni e postideologici, privi, forse, degli strumenti necessari per decifrare con chiarezza criteri e modalità alla base del pensiero e delle azioni degli italiani di 150 anni fa, come ad esempio la fede religiosa o l’amor patrio. Non proprio pane per i denti dello statunitense Steven Spielberg, che ha forse preferito non imbarcarsi in un’impresa così delicata e rischiosa. Questo è quello che io penso sia successo davvero. Ora, dipingere (come hanno fatto in “Rapito” Bellocchio e i suoi sceneggiatori) la Chiesa come un’accolita di frustrati, detentori di un potere assunto per divina volontà che autorizzasse abusi e manipolazioni alla stregua di un’associazione mafiosa, è una semplificazione troppo sommaria. Non nego né colpe né responsabilità, anzi mi unisco alla condanna della Storia, ma desidererei che queste “malefatte” mi venissero illustrate senza prescindere dagli intricati e complessi legami con i cardini del pensiero religioso cristiano (il peccato originale, il sacrificio, la rinuncia, con la difesa di secolari codici etici, morali, filosofici: vedi alla voce Bergman) senza ridurle ad espressioni di crudeltà gratuita ai limiti del macchiettismo: lo considero un criterio contrario a quell’onesta intellettuale che dovrebbe, a ventunesimo secolo entrato da un bel po’ nel vivo del proprio corso, improntare di sé ogni racconto serio, documentato e veritiero del passato più e meno recente. …Insomma, a forza di dare retta a chi sostiene che “è brutta”, ci siamo scordati la letteratura italiana che abbiamo studiato a scuola: la Notte dell’Innominato dei Promessi Sposi è un pattern estraneo agli sceneggiatori incaricati di reinventare oggi per lo schermo, grande o piccolo che sia (dov’è ormai la differenza?), figure storiche come Condottieri, Re, Imperatori e Papi di epoche storiche lontane nel tempo, piallati sulla superficie pixellata della ricerca immagini di Google. Per modi ed inflessioni, il Papa Pio IX interpretato da Paolo Pierobon in questo “Rapito” sembra configurato sullo stampino di Gargamella…
– Lo stregone cattivo dei Puffi?
– Esattamente. Un cattivo dei fumetti, appunto. Una caricatura, lontanissima dal personaggio reale, che fu dopotutto un papa liberale, dispensatore di amnistie, a suo modo pacifista, generoso nel finanziare bonifiche e restauri di antichità e catacombe (se il Colosseo non è crollato lo dobbiamo a lui), profondamente ispirato a una spiritualità troppo spesso assente nei sui predecessori… Da gente come Bellocchio mi sarei aspettato un’analisi meno superficiale e sommaria delle ingerenze del potere temporale nell’Italia agitata dai moti risorgimentali e dalle guerre di indipendenza. Ma come latita nella rappresentazione delle malefatte vaticane, lo spessore è nullo anche nel ritrarre il complesso personaggio di Edgardo Mortara, il ragazzino rapito, affidato a Enea Sala, volenteroso biondino un po’ troppo bellino (quando tutti i piccoli attori che impersonificano i suoi numerosi fratellini avrebbero avuto volti infinitamente più adatti e azzeccati), e, da seminarista ormai cresciutello, a quel Leonardo Maltese che aveva dato prova magistrale di sé in “Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio, qui manifestamente privo di una guida altrettanto sicura: i suoi occhioni sgranati, le sue labbra arrotondate da uno stupore inconsapevole e permanente non ci aiutano a comprenderne il tormentato percorso interiore e l’ambigua fascinazione verso una figura “paterna” tanto imponente come quella di un Pontefice. Né conferisce a Edgardo quella qualità tipica dei protagonisti dei film, che ci fa tifare per loro e comprenderne ogni gesto e pensiero. Al contrario, non si capisce la ragione del suo avventarsi sul trono del Papa durante una processione provocandone la caduta rovinosa, né (attenzione! Spoiler!) si giustifica il suo rifiuto di rientrare in famiglia, o l’assurda pretesa di battezzare la madre morente. Atti sconsiderati, sconclusionati, di cui la regia non ci fornisce alcuna plausibile spiegazione. Scommetto che se il film lo avesse diretto Spielberg, certi dubbi non mi avrebbero nemmeno sfiorato.
– Però scusami: come possono queste tue parole severe e negative contrastare in modo così radicale con l’accoglienza unanimemente entusiasta di pubblico e stampa prima a Cannes e poi nelle sale italiane?
– Che vuoi che ne sappia? Non ho la presunzione di dire che ormai sono tutti troppo abituati a una narrazione di marca televisiva, e che non sanno distinguere uno sceneggiato tra il fogliettone e il romanzo popolare da un vero gran film. Perché al di là dei personaggi tagliati con l’accetta e della troppo manichea divisione tra buoni e cattivi, “Rapito” non regge neppure come spettacolo cinematografico di qualità. C’è qualche buona sequenza, questo sì: una su tutte, l’insurrezione di Bologna del 1859, una cinquantina di secondi con un bel movimento di carrello pensato in funzione dell’azione coreografica delle comparse, con tanto di statua bronzea del Papa schiantata a terra, tipo il Wojtyla di Cattelan. Ma è perla rara in un’antologia di interni inquadrati con scarsa fantasia e città italiane dell’800 – una Bologna turrita, un’ansa del Tevere col Porto di Ripetta in direzione San Pietro – ricostruite digitalmente con imbarazzante risparmio di mezzi, effetto Minitalia. Mediocri perfino le prestazioni attoriali, e punge amaramente, dopo il capolavoro che è stato il suo Aldo Moro in “Effetto Notte”, un Gifuni in sordina e addirittura scolastico nelle vesti di un solerte cardinale dell’Inquisizione; mentre Fausto Russo Alesi sfoggia dall’inizio alla fine del film la medesima espressione di cane bastonato che fu già del Cossiga di “Esterno Notte” sul volto di Salomone Gradara, il padre del piccolo rapito. Di Paolo Pierobon ho già detto, ma più che sua, la colpa è dell’impostazione fra il grottesco e il disneyano di Papa Pio IX. A scaldare il racconto e tener desta un’attenzione che da metà film rischierebbe di impantanarsi nel troppo facile (e noioso!) gioco ad incrocio dell’avventura umana del seminarista (mai abbastanza convinto, almeno in apparenza, di quanto gli viene imposto dai catechisti, attratto piuttosto dalla furbizia del robusto amichetto del Ghetto, cui è toccata la sua medesima sorte, che si esprime in un simpatico e verace romanesco più simile al vernacolo del 2023 che al fiorito dialetto trasteverino di Giacchino Belli) e il processo che contrappone la sua famiglia alle autorità della Chiesa, c’è fortunatamente un adeguato commento musicale firmato da Fabio Massimo Capogrosso. Alla sua seconda collaborazione con Bellocchio dopo “Esterno Notte”, il compositore romano ha saputo, stavolta con maggior dovizia di brani e di note, inserire con convincente disinvoltura la propria partitura complessa e articolata fra musiche di altri compositori “storici” (Rachmaninoff, Shostakovich, Ligeti e Arvo Pärt) espressamente richiesti in colonna sonora dal regista.
– Ciò nonostante rimani del parere che il film non meriti la sufficienza?
– Già. Rimango di questo parere, caro il mio “Maestro”: bocciato. O quantomeno rimandato al prossimo film.