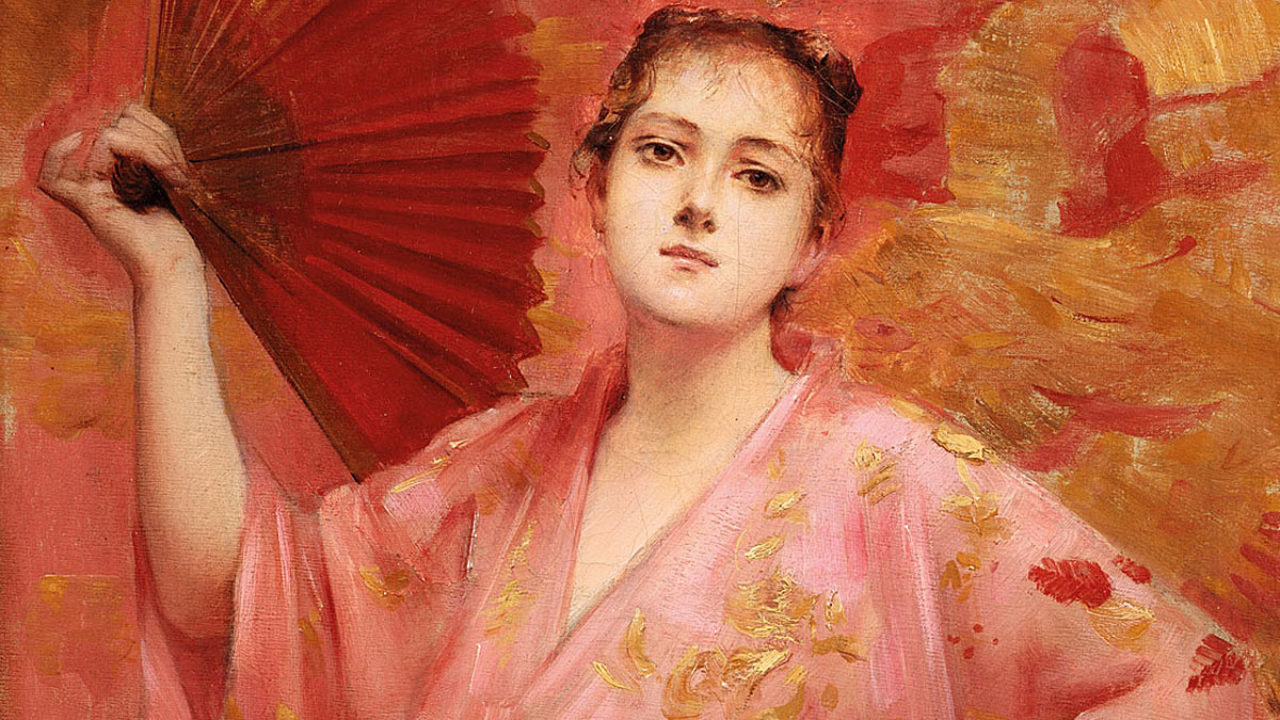Un possibile itinerario lungo l’attività pittorica di Francesco Lauretta, artista che ha recentemente esposto alla Galleria Giovanni Bonelli di Milano (18 gennaio – 24 febbraio 2024).
Imprescindibile è per la pittura tornare su se stessa. Piccola o grande che sia essa si distingue, ancora e nonostante le più o meno gioiose kermesse dei sistemi, per quel che riguarda la pratica. Essa, dunque, non può che avanzare via via esplicitandosi; afferrando e lasciando andare le sue direzioni, le sue attenzioni, i suoi paradossi, le ironie, i drammi e le cautele. Dipingere è un fatto a se stante e Francesco Lauretta ne è consapevole.
Il pittore nato a Ispica (Ragusa) nel 1964 lo aveva annunciato di recente, in occasione della sua mostra personale Grigio Contemporaneo presso la Galleria Giovanni Bonelli di Milano (18 gennaio – 24 febbraio 2024), cimentandosi in una serie di dipinti che riprendevano in grigio il raffronto pittorico intuito da Paul Cézanne nei tempi che furono. Lauretta aveva annoverato come vera la frase del maestro, il quale osò scrivere che “finché non si è dipinto un grigio, non si è pittori”. Spunto assai poco provocatorio, o di certo nei limiti del proprio coinvolgimento (nel senso di fascino e attrazione), che Lauretta ha accolto, secondo le sue parole, per un “rinnovato interesse verso la pittura” e come sollecitazione “a riflettere intorno a questo medium” (Never relaxed, 2024).

Ed è qui il punto, come occasione per potere in qualche modo entrare un attimo di più entro la questione, di questi tempi sotto i riflettori. “Ma che cos’è un dipinto? Uno strato di colore? Decorazione? Rappresentazione? Un gesto creativo? Un’idea dipinta? Un mondo dipinto? Un quadro dipinto?”, si domandava Hans Belting scrivendo di Sigmar Polke. È forse, in verità, tutto questo insieme e molto altro ancora. Non un riflesso di qualcosa, ma “teatro” in cui la pittura è “diventata essa stessa un palcoscenico con segni e persone”. Un azzardo, che farà storcere il naso a taluni, ma inviterà altri a ricoverare le proprie illusioni nell’incertezza di un lavoro offerto, insieme narrativo (in quanto chiaro segno evidente di ciò che mostra) e pensiero espresso per via di un’esperienza intrapresa, e ancora non conclusa.
Da un lato, quindi, la volontà, sia essa critica, giocosa o folkloristica di potersi calare entro la “visione” del popolare. Dal ritratto (Emma, 2015) alla situazione più “semplice” (Il quadro più bello della nostra vita (remix), 2017), in quanto unita e chiara, ora veicolata dal segno deciso, dal colore intenso e luminoso, dal gioco, la spensieratezza, le processioni (Idola, 1998; Processione rossa; Processione blu, 2017). Si pensi pertanto alla Cassata intitolata Caffè Sicilia, del 2019 (quadro esposto durante la mostra In questa luce a Palazzo Nicolaci, Noto, 2021), che della tradizione, dell’uso e del gusto, così come del costume, riprende l’opulenza, la fluorescenza, lo zucchero pastoso che appiccica le dita. A tal punto che, se non fosse per la gola, sarebbe di certo più bella che buona.

Eppure anch’essa apre al tormento, allo “sconfinamento pittorico”, come descritto da Pietro Gaglianò, poiché immaginata a un tempo quale elemento performativo – da far girare come una bellissima “scultura mobile” trasportata da alcuni camerieri durante un’inaugurazione –, e caduca; disfacentesi, con i pezzi di frutta “ammaccati dal caldo”. Oggetto pittorico che “nel suo splendore” rivela “la sua fine”. Una festa, o la festa di Francesco Lauretta, che può essere colta in questo secondo aspetto. Nell’idea del finale, come la danza mortale di Mads Mikkelsen nel film Un altro giro di Thomas Vinterberg. Il “finale di partita” così evidente negli spolveri site-specific (vedute del cimitero di Ispica), come Final!, esposto nel 2022 in occasione della retrospettiva Festival presso il MAC di Lissone.
Fantasmi “di una nascita o di una rinascita”. Cifra pittorica che “suggerisce qualcosa da venire”. Quel che resta da chiarire, pertanto, riguarda, in fondo, quale sia il nesso tra l’uno e l’altro dipinto, tra Uno e Altro, un dittico del 2005 in cui nel primo ricorre di nuovo la festa (ovvero la ricorrenza civile o religiosa, familiare e collettiva, motivata anche da un fausto avvenimento, ossia promettente) e il popolare, con tre ragazzi disposti attorno ad un’asinella; e il secondo, impropriamente sinopia del primo, giacché stessa immagine ora dipinta con varie tonalità di bianco. Uno soggetto e Altro metodo evidente del muoversi nel medium, nella varietà possibile del doppio che la strada pittorica indica. Tornare sullo stesso, mesto e riflessivo, sorridente e triste, perdita e ritrovamento.
Come chiave possibile, o come volta attorno alla quale è offerta la via di ciò che può essere, di tutto ciò che può farsi. La serie de I Sucati è forse il nodo. La scintilla di un ristoro pittorico che permette l’accenno di una sintesi: là dove è tollerata la convergenza del metodo e dell’immagine dipinta, ora formante, ora avverabile. In senso letterale il nome indica “gli espulsi” – una serie di opere realizzate con scarti ai quali sono stati applicati colori in esubero, esposti per la prima volta nel 2017 nella mostra collettiva Idioti – e denotano quel cardine, o un cardine, che regge, almeno ipoteticamente, le briglie evasive dell’umana esperienza. Imprescindibile anche per essa, come per ogni atto pittorico, essere ripresa, rivista e ripercorsa, a causa di quelle omissioni che nel tempo tornano come rigenerative, sintomatiche e rivelatrici di nuove direzioni.