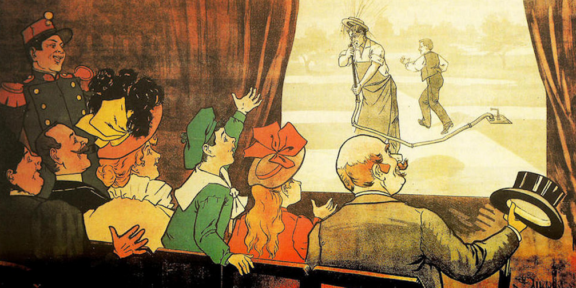Nel panorama (sconfinato) dei festival cinematografici italiani – il format festivalier, rispetto alla sala cinematografica tradizionale, ha sofferto meno la crisi di pubblico degli ultimi anni – si è affacciato e via via affermato il Riviera International Film Festival (RIFF).
Situato nella suggestiva cornice di Sestri Levante, tra la Baia del Silenzio e la Baia delle Favole, il Festival “Vuole dare lo spazio che si meritano a quei giovani registi – la manifestazione è riservata a cineasti sotto i 35 anni – che vengono ‘maltrattati’ dai grandi festival” dichiara il Presidente Stefano Gallini-Durante introducendo il tradizionale incontro con i registi dei film in concorso di questa edizione, l’ottava, andata in scena dal 7 al 12 maggio. Anche quest’anno sono state numerose le personalità di spicco attratte dal Festival: da Martina Stella a Raoul Bova, da Rossella Brescia ad Ambra Angiolini. Per non parlare di quelle internazionali: oltre al regista Andrew Dominik (suo il biopic Blonde su Marilyn Monroe, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2022), a Sestri Levante sono approdati tre Premi Oscar: la produttrice australiana Eva Orner, il montatore Pietro Scalia (collaboratore a più riprese di Bertolucci, Ridley Scott, Oliver Stone e Gus Van Sant) e Susan Sarandon, indimenticabile protagonista di film come The Rocky Horror Picture Show e Thelma & Louise.

“I veri protagonisti del RIFF sono i registi, i produttori, gli attori e tutti quelli che realizzano i nostri film e documentari in concorso. Ogni anno sono tantissimi e arrivano da tutto il mondo” scrive Massimo Santimone a corredo di una foto che lo ritrae insieme ai registi di questa edizione. Santimone è programmer del Festival sin dalla prima edizione: per selezionare i film da portare a Sestri Levante ogni anno si trova a girare il mondo, frequentando tra gli altri la Berlinale, sede dell’European Film Market. I film in concorso sono stati “scovati” anche in altre rassegne cinematografiche internazionali, come il Sundance e l’International Film Festival di Rotterdam.
Essendo il terzo anno che frequentiamo la rassegna (qui i reportage delle edizioni 2022 e 2023) possiamo testimoniare che è proprio così. Il RIFF, partendo dal nulla, negli anni è diventato meta obbligata per gli appassionati di cinema e non: hanno sicuramente contribuito in tal senso la location di rara bellezza, gli ospiti glamour e in ultimo, non per importanza, i giovani registi, attori, produttori, direttori della fotografia che ogni anno animano le due sezioni “in concorso” – quella dedicata ai film di finzione e quella incentrata sui documentari – con la loro idea di cinema. Si tratta di autori non ancora affermati e che, forse proprio per questo, sono desiderosi di ottenere un riscontro da parte del pubblico sul loro lavoro: questo dialogo è reso possibile dai dibattiti che accompagnano quasi tutte le proiezioni del Festival e che, potenzialmente, possono proseguire tra i vicoli del caruggio o pieds dans l’eau sulla Baia del Silenzio.

11 quest’anno i film in concorso provenienti da 10 nazioni diverse. Oltre a questi, 10 documentari, spesso incentrati su temi legati all’ambiente come in We are Guardians, ritratto di un gruppo di nativi brasiliani pronti a sacrificare la propria vita per salvaguardare ciò che resta della foresta amazzonica, baluardo dell’equilibrio climatico mondiale la cui stessa sopravvivenza è messa a rischio da anni di disboscamento incontrollato e finalizzato anche all’ampliamento dei pascoli di animali la cui carne è esportata in tutto il mondo, Italia compresa. A trionfare è stato The Quiet Maid (2023) dello spagnolo Miguel Faus, ritratto di una cameriera colombiana che lavora instancabilmente in una lussuosa villa sulla Costa Brava spagnola, dove una ricca famiglia di mercanti d’arte trascorre le vacanze estive. In un ambiente ostile, saprà reclamare uno spazio vitale che la porterà a prendersi un’insperata rivincita sul destino. Ci sono però almeno altri sei film che hanno catturato la nostra attenzione.
Il primo è diretto dal più giovane regista in concorso, il 24enne inglese George Jacques. Black Dog (2023), sta a metà tra il film di formazione e un road movie: racconta la storia di due adolescenti che, in fuga dalla propria città, Londra, ma soprattutto dal loro passato e dalle loro stesse vite, condividono un’avventura che li porta fino in Scozia, durante la quale hanno il tempo e lo spazio per venire a patti con una parte di sé che fino allora non avevano saputo accettare. Ottime le prove dei due protagonisti Keenan Munn-Francis e, in particolare, Jamie Flatters – attore classe 2000 già apparso in film del calibro di Avatar-La via dell’acqua – che, per la sua interpretazione in grado di restituire tutti i demoni che possono vivere all’interno di un neo-diciottenne alla ricerca delle proprie radici, è stato premiato come Miglior Attore dal Festival.

Sempre dall’Inghilterra proviene In camera (2023), film d’esordio del regista Naqqash Khalid: anche in questo caso interpretato da un cast eccezionale – Nabhaan Rizwan trasmette a chi guarda lo stesso spaesamento vissuto dal protagonista, perso in un mare di provini da attore fallimentari e a dir poco stranianti – e da una regia che non ha paura di assumersi dei rischi, tra simbolismi e un’analisi approfondita della psiche instabile dei personaggi. La messa in scena è a tratti visionaria, anche se non sempre limpida nello svolgimento della trama. Quando gli viene chiesto se c’è qualcosa nel suo film di cui non è pienamente soddisfatto risponde, filosofico: “Ho sperimentato molto e forse non tutto è uscito come avrei voluto. Fa parte del gioco, sono fiero anche delle parti che potrebbero risultare meno convincenti”.
La Norvegia è il paese natale di Thea Hvistendahl, regista di Handling the Undead (2024), tratto dal romanzo dello scrittore svedese John Ajvide Lindqvist. In una calda giornata estiva a Oslo, i morti misteriosamente si risvegliano e tre famiglie vengono gettate nel caos quando i loro cari defunti tornano da loro. La cineasta, premiata per la Migliore Regia, racconta: “Ciò che mi ha colpito del libro è che tutta la premessa su cui si basa la vicenda, ovvero i morti che si risvegliano, fosse uno strumento per ‘visualizzare’ il lutto delle persone ancora in vita. Il linguaggio ‘horror’ in tal senso viene sì utilizzato per creare tensione nello spettatore, ma al tempo stesso per veicolare un messaggio insolito per questo genere, ovvero che se i morti si dovessero davvero risvegliare ciò non li renderebbe di nuovo ‘vivi’, come probabilmente li percepiremmo noi: rimarrebbero persone morte, che non hanno nulla a che fare con il nostro mondo e che non desiderano farne parte. Che ci piaccia o meno”.

Dall’horror si passa al thriller: è il caso di We Have Never Been Modern (2023) di Matej Chlupacek, cineasta nato in Repubblica Ceca al suo secondo lungometraggio. Ambientato nel 1937 in una cittadina dell’Est Europa che aspira a diventare un modello di metropoli moderna, il film segue una donna che ritrova il corpo senza vita di un neonato e si confronta con un mistero che nessuno sembra voler risolvere. Il film è ambizioso e stratificato: diversi i temi affrontati, dalla condizione della donna all’identità di genere, indagati prima grazie a un sotto testo thriller che si esaurisce rapidamente per dare largo spazio alla caratterizzazione psicologica dei personaggi, mentre il film, soprattutto nella seconda parte, sembra avvolgersi su se stesso finendo per perdere di vista, e in buona parte tradire, le intriganti premesse iniziali. Nota di merito per i produttori del film, in grado di ricreare le atmosfere anni ’30 in modo credibile e con un budget relativamente basso. La protagonista Eliška Křenková è stata premiata come Miglior Attrice.

Difficile, se non impossibile, da classificare è Electric Fields (2024) della svizzera Lisa Gertsch. Contraddistinto da una ricercata fotografia in bianco e nero e inquadrature fisse da cui i personaggi entrano ed escono, quasi disinteressati a mostrarsi allo spettatore, il film è suddiviso in sei episodi che sembrerebbero non avere nulla in comune fra di loro, se non il personaggio del primo episodio, l’unico a riapparire brevemente negli altri segmenti di narrazione, e i “campi elettrici” citati anche nel titolo. In ogni capitolo troviamo infatti un oggetto attraversato da un campo elettrico, che si tratti di una lampadina che inspiegabilmente si auto-alimenta o una radio in grado di risvegliare – in modo inaspettatamente comico e irriverente – i defunti. Racconta la regista: “In ogni episodio ho voluto mettere in scena persone che si sentono bloccate, fino a che qualcosa di molto strano accade nelle loro vite, costringendoli a reagire”.
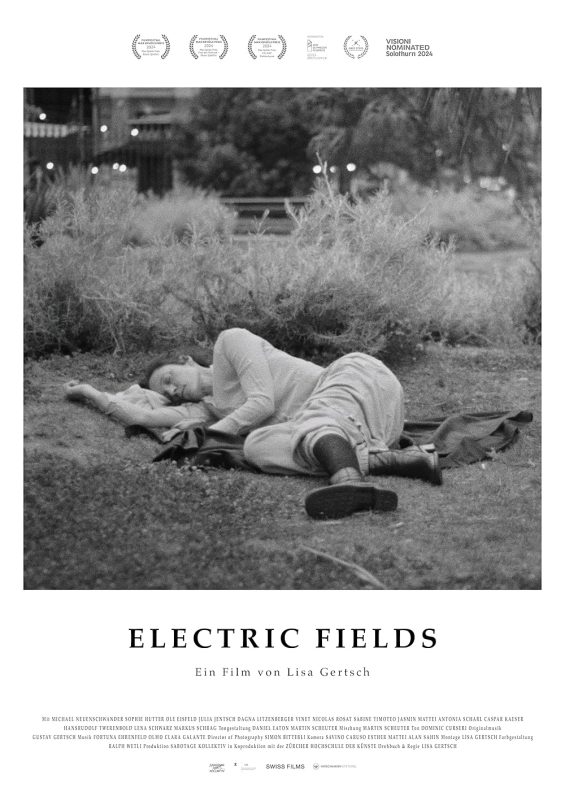
Riguardo alle difficoltà di girare un film a budget zero, come nel suo caso, riferisce: “Sono anche produttrice del film, ho organizzato personalmente la logistica delle riprese. Il film l’abbiamo fatto in tre: oltre a me, il direttore della fotografia e una persona addetta al suono”. Quale il significato del personaggio ricorrente? “Volevo che fungesse da ‘specchio’ nei confronti degli altri personaggi. È l’unico a subire un’evoluzione, l’unico che riesca a contrastare l’immobilità a cui tutti gli altri non sembrano trovare rimedio”. Da cosa è stata dettata la scelta del bianco e nero? Pensi di portarla avanti nei prossimi film? “Da un punto di vista pratico, il bianco e nero ti garantisce una libertà che il colore non ti permette di avere. So per certo che il mio prossimo non sarà in bianco e nero, ma non escludo di tornare a usarlo in futuro”.
Il film è girato in 4:3, con il risultato che i personaggi sembrano essere schiacciati dall’inquadratura ristretta: come sei arrivata a questa scelta? “Non so esattamente perché ho deciso di adottare questo formato: la migliore spiegazione in realtà mi è stata data da una delle attrici che, una volta visto il film per intero, ha avuto la sensazione che i personaggi fossero osservati dall’alto, da una sorta di entità esterna che guarda a questi strani individui in modo distaccato. Ciò che mi interessava di più era che la cinepresa non si muovesse, in modo da riflettere la condizione ‘stagnante’ in cui si trovano i personaggi”.

Infine, il film che ha inaugurato questa ottava edizione del Festival – l’unico italiano in concorso –, Io e il Secco (2023) di Gianluca Santoni, scritto insieme a Michela Straniero. Curiosamente, il percorso di questo lungometraggio inizia nel 2017, anno in cui viene organizzata la prima edizione del RIFF: in quell’anno la prima stesura di Io e il Secco vince il premio Miglior Soggetto al premio Solinas – dedicato alla scrittura per il cinema – con la seguente motivazione: “In un mondo dove i padri sono ombre lontane o minacciose, Denni con la ‘i’, piccolo eroe picaresco, e il Secco, inverosimile killer in fuga da una prossima paternità, affrontano insieme il senso di essere uomini”. Basta questo per descrivere un esordio alla regia con diversi pregi, primo fra tutti quello di dare vita a un cortocircuito in cui la mascolinità tossica e violenta contro cui Denni decide di scagliarsi rischia di essere da lui stesso perpetrata.

Chiediamo al regista marchigiano quale sia stata la scintilla da cui è partito. “Tutto nasce dal personaggio di Denni, dal conflitto di un bambino con la figura brutale del padre, che detesta senza rendersi conto che il suo desiderio di vendetta, se esaudito, lo renderebbe altrettanto colpevole”. Come mai avete deciso che il Secco sarebbe stato un personaggio romano, sia per parlata che per qualità caratteriali? “Il motivo è proprio la lingua. In fase di scrittura io e Michela ci siamo accorti che l’ironia presente nella sceneggiatura è tipicamente romana: a un certo punto abbiamo ipotizzato che il Secco fosse romagnolo, ma abbiamo notato che non avremmo ottenuto lo stesso effetto”.
Come avete lavorato sulla colonna sonora, e in particolare come siete arrivati alla scelta di ‘Sere Nere’ di Tiziano Ferro, affidandogli un ruolo chiave? “Volevamo raccontare attraverso la musica sia il legame tra Denni e sua madre sia quello tra Denni e Secco. Serviva un brano che facesse parte dell’immaginario, dei ricordi più o meno sepolti, di un pubblico ampio. Volevo che il brano accompagnasse anche le emozioni del finale, sui titoli di coda: Dade, il compositore della colonna sonora del film, ha pensato di far realizzare una cover ai Santi Francesi e io mi sono fidato del suo istinto. È uscito un pezzo bellissimo che per ora si potrà ascoltare solo andando a vedere il nostro film”. Io e il Secco, vincitore del Premio per la Miglior Sceneggiatura e di quello assegnato dal pubblico al RIFF 2024, uscirà nelle sale italiane il 23 maggio distribuito da Europictures.