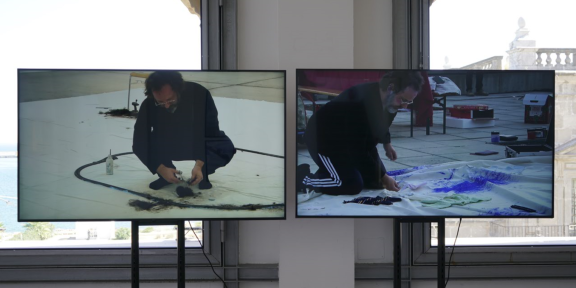Critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi riflettono sui nuovi protagonisti di una scena dell’arte contemporanea un tempo presidiata dall’Occidente
Sì, lo sappiamo bene, le categorie – Occidente, terzomondo, periferia – sono da tempo materia archiviata dal dominante globalismo. Da decenni il dilagare della comunicazione ha azzerato ogni distanza, garantendo ad artisti, critici, studiosi di ogni angolo del globo pari opportunità di intervenire nelle dinamiche socio-culturali. Una grandissima conquista di civiltà e di crescita. Eppure è sotto gli occhi di tutti che questo indispensabile riequilibrio sia presto sfuggito a logiche razionali, viziato da influenze ideologiche e politiche, che nei massimi sistemi nascondono sempre spinte finanziarie.
Fino agli anni Ottanta, inutile confutarlo, le redini del “sistema dell’arte” erano – salvo sporadiche eccezioni – saldamente nelle mani di attori che per semplicità definiremo “occidentali” (europei, anglo-americani). Dagli anni Novanta, grazie all’azione di diversi studiosi illuminati – Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, per citare qualcuno – sono iniziate ad emergere istanze “periferiche”, stimoli nuovi provenienti da realtà spesso ignorate, capaci di immettere ossigeno in un contesto non di rado asfittico e tendenzialmente autoreferenziale.
Risultati contrastanti
Negli ultimi anni, tuttavia, a questo salutare “revanchismo” si va sostituendo un meccanismo uguale e contrario al vizio originario. Oggi molti segnali sembrano voler affermare una aprioristica superiorità di quanto emerga da realtà vittime del lungo oblio. Con risultati spesso contrastanti, quando non del tutto scollegati all’oggetto fulcro di ciò che definiamo come “arti visive”, ovvero la qualità intrinseca di un’opera. Paradigmatico quanto avvenuto nel 2020, quando la seguitissima Power 100 List stilata dalla rivista ArtReview pose al primo posto il movimento Black Lives Matter. E gli esempi a conferma di questo trend sarebbero infiniti.

Anche la Biennale di Venezia, che resta il più importante evento internazionale per l’arte contemporanea, pare adeguarsi ai nuovi standard. Dopo una mostra ampiamente – per molti troppo – inclusiva come quella del brasiliano Adriano Pedrosa, ora arriva la direzione della camerunense Koyo Kouoh. Nulla da eccepire, ovviamente, sulle capacità dei personaggi coinvolti, del resto avvalorate da importanti curriculum. Ma una domanda si impone: davvero gli “occidentali” hanno improvvisamente perduto ogni capacità di leggere la realtà contemporanea? Da qui avviamo un’inchiesta nella quale coinvolgeremo critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi. Certi di proporre un approccio provocatorio, e anche divertente…
Walter Bortolossi
I cinici, questi saggi, dicono che è sempre stato così, nel Medio Evo come dopo la Rivoluzione Francese. L’arte non rispecchierebbe necessariamente la realtà o le pure intenzioni degli autori ma prospera dove l’economia la favorisce. Quindi il mito dell’indipendenza dell’artista sarebbe un’ipocrisia. Da tempo gli operatori del settore dell’arte contemporanea, soprattutto i curatori di grandi mostre, sono dei semplici professionisti di un certo ambito della cultura, con scarsa autorevolezza intellettuale: non ce l’aveva, tra le tante citabili, in realtà, nemmeno l’idea della “Platea dell’Umanità” di Szeemann, che rientrava nel filone, oggi piuttosto diffuso e forse inflazionato, della sociologia pot-pourri.
È perfettamente logico che i rappresentanti di paesi emergenti tentino di prendersi oggi la scena tentando di avere il loro turno per scrivere una storia a senso unico, esacerbando certe visioni secondo le quali “tutto è relativo” ma ignorando la costanza della velocità della luce. Si ha spesso l’impressione di assistere però ai revanscismi di un ceto di privilegiati accademici: il più delle volte non ci troviamo di fronte a dei Sartre che rifiutano il Nobel e nemmeno dei Frantz Fanon o dei Guevaristi che criticano i governi dei paesi che abitano ma ideologi che trafficano in temi modaioli e piuttosto collaterali e che trovano degli avversari di comodo all’esterno.
Detto questo le Biennali vanno giudicate a mostra fatta ed è presto per fare troppe condiderazioni . Nel curriculum della nuova direttrice c’è la partecipazione alla curatela di due edizioni di Documenta che, come altre, hanno fatto tanto fumo e poco arrosto. È da dire infine però che lo stato del sistema artistico italiano, al di là del valore o meno dei suoi protagonisti attuali, è pessimo: all’estero siamo ancora rappresentati dalle opere di artisti che hanno fatto le cose interessanti quando io ero bambino. E basta farsi un giro per le principali fiere d’arte del nostro paese e verificare se l’arte italiana che vi è esposta è in grado di fronteggiare ideologicamente e tematicamente il nuovo che avanza. Non mi pare proprio.

Andrea Cusumano
Stiamo vivendo un momento di crisi degli assetti politici, egemonici e culturali. Questo non può che influenzare le emergenze anche nel campo dell’arte contemporanea. Le scelte sono spesso politiche, nel senso più lucido del termine, e questo non deve stupirci. Il mondo occidentale, un luogo comunque difficile da descrivere univocamente e con precisione, ha da anni avviato un processo di ri-significazione. Un atto tecnicamente necessario, ma non sono sicuro del tutto onesto. Da un lato la così detta de-colonizzazione è molto spesso un atto dogmatico in sé, in alcuni casi a mio avviso persino reazionario e per di più colmo di contraddizioni. D’altro canto sarebbe onesto ammettere che l’attitudine coloniale, l’incapacità di vedere l’altro se non come risorsa per il proprio mondo, l’occidente non l’ha mai persa, e gli eventi catastrofici di questi giorni ne sono piena evidenza.
Il rischio è che questa parola così coraggiosa e necessaria, “decolonizzazione”, rischi di diventare il ‘simulacro’ di sé stessa; un lasciapassare per i salotti buoni della cultura e delle élite, invece che innescare un vero e profondo processo di ripensamento in favore di un mondo più equo, che dia pari opportunità e che sappia davvero aprirsi ad un umanesimo moderno e post-coloniale, un umanesimo multifocale e universale. Purtroppo siamo ben lontani da ciò e il rischio è che tali temi vengano affrontati – tal volta con grande profondità, più spesso goffamente – solo nelle mostre, nelle biennali, nei bandi e poco nelle scelte politiche reali.
Tutto ciò nulla ha a che fare con l’individuazione di Koyo Kouoh quale direttrice della prossima biennale, che so essere una curatrice molto preparata e capace di visioni ampie. Spero che sappia imprimere una significativa svolta a questo processo di riscrittura della contemporaneità. Semmai bisognerebbe riflettere sul fatto che il modello Biennale di Venezia con i suoi padiglioni nazionali riflette proprio il modello expo colonialista, mentre la globalizzazione del ‘sistema dell’arte contemporanea’ dimostra in modo efficace l’imposizione universale del proprio modello economico-finanziario.

Antonio Rocca
L’occidente ha mollato la presa sull’arte contemporanea? Penso e spero di sì. Auspico che l’arte testimoni la fine di un’egemonia, che ha fatto fin troppi danni.
Esiste tuttavia il rischio che l’emersione di nuovi centri, soggetti ed eventi, dissimuli un ultimo fatale trionfo. Sarebbe drammatico accorgersi che dietro spettacolari cambiamenti di facciata, si agita e prolifera il medesimo paradigma.
Credo che l’occidente abbia generato il capitalismo per divorare il mondo e credo che ora il figlio stia mangiando il padre. Non so se sia un bene.