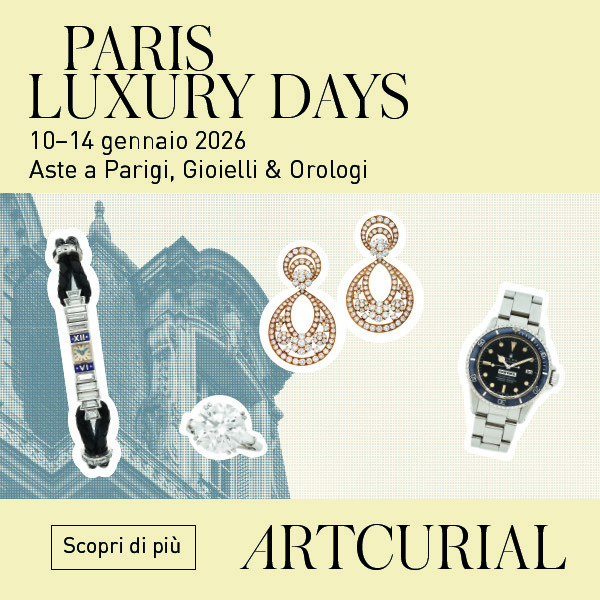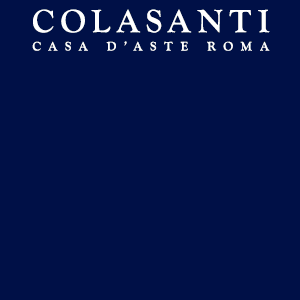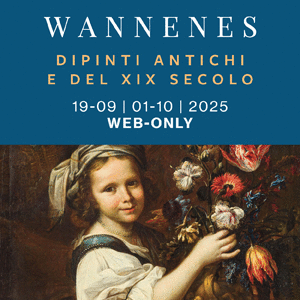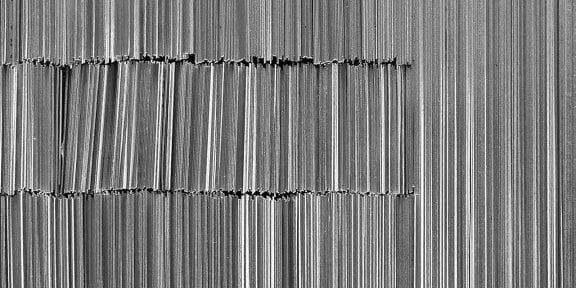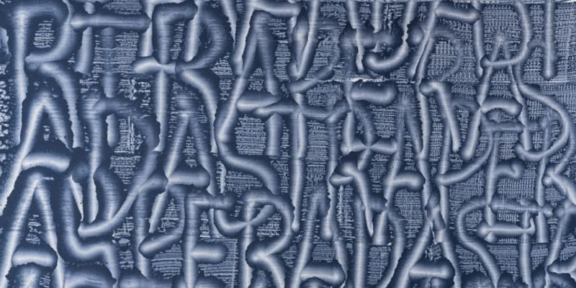Critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi riflettono sui nuovi protagonisti di una scena dell’arte contemporanea un tempo presidiata dall’Occidente
Sì, lo sappiamo bene, le categorie – Occidente, terzomondo, periferia – sono da tempo materia archiviata dal dominante globalismo. Da decenni il dilagare della comunicazione ha azzerato ogni distanza, garantendo ad artisti, critici, studiosi di ogni angolo del globo pari opportunità di intervenire nelle dinamiche socio-culturali. Una grandissima conquista di civiltà e di crescita. Eppure è sotto gli occhi di tutti che questo indispensabile riequilibrio sia presto sfuggito a logiche razionali, viziato da influenze ideologiche e politiche, che nei massimi sistemi nascondono sempre spinte finanziarie.
Fino agli anni Ottanta, inutile confutarlo, le redini del “sistema dell’arte” erano – salvo sporadiche eccezioni – saldamente nelle mani di attori che per semplicità definiremo “occidentali” (europei, anglo-americani). Dagli anni Novanta, grazie all’azione di diversi studiosi illuminati – Harald Szeemann, Jean-Hubert Martin, per citare qualcuno – sono iniziate ad emergere istanze “periferiche”, stimoli nuovi provenienti da realtà spesso ignorate, capaci di immettere ossigeno in un contesto non di rado asfittico e tendenzialmente autoreferenziale.
Risultati contrastanti
Negli ultimi anni, tuttavia, a questo salutare “revanchismo” si va sostituendo un meccanismo uguale e contrario al vizio originario. Oggi molti segnali sembrano voler affermare una aprioristica superiorità di quanto emerga da realtà vittime del lungo oblio. Con risultati spesso contrastanti, quando non del tutto scollegati all’oggetto fulcro di ciò che definiamo come “arti visive”, ovvero la qualità intrinseca di un’opera. Paradigmatico quanto avvenuto nel 2020, quando la seguitissima Power 100 List stilata dalla rivista ArtReview pose al primo posto il movimento Black Lives Matter. E gli esempi a conferma di questo trend sarebbero infiniti.

Anche la Biennale di Venezia, che resta il più importante evento internazionale per l’arte contemporanea, pare adeguarsi ai nuovi standard. Dopo una mostra ampiamente – per molti troppo – inclusiva come quella del brasiliano Adriano Pedrosa, ora arriva la direzione della camerunense Koyo Kouoh. Nulla da eccepire, ovviamente, sulle capacità dei personaggi coinvolti, del resto avvalorate da importanti curriculum. Ma una domanda si impone: davvero gli “occidentali” hanno improvvisamente perduto ogni capacità di leggere la realtà contemporanea? Da qui avviamo un’inchiesta nella quale coinvolgeremo critici, artisti, direttori di museo, giornalisti, galleristi. Certi di proporre un approccio provocatorio, e anche divertente…
Edoardo Cialfi
Essendo l’arte un’attività umana e il riflesso del tempo che l’essere umano vive nella propria contemporaneità, credo di poter dire che la crisi politico filosofica dell’occidente determini anche una crisi di significato nell’opera d’arte in occidente. Forse, in questo senso, è inutile stupirci della scarsa proposta avanguardistica di un mondo che con compiacente sonnolenza osserva il suo tramonto. Ciò che credo di osservare, sperando in un’inconsapevole miopia, è il rimescolare ottime carte che in passato sono state vincenti, oppure l’attenzione per immagini banali che spesso fine a sé stesse, non riescono a farsi immaginario.
Se però in direzione ovest osserviamo un tramonto, in direzione est osserviamo l’alba. La veloce avanzata asiatica ci costringe ad allargare la lente sulle produzioni artistiche e sugli investimenti dei giganti del levante. Con loro anche quello che consideriamo sud del mondo, ovvero il continente africano, seppur in modo meno eclatante, si prepara ad una forte entrata in scena nel sistema economico internazionale.
A mio avviso però, seppur l’occidente attraversa una fase di quiescenza, i linguaggi artistico-visivi appartenuti all’occidente egemone godono ancora di ottima salute. La globalizzazione ha esportato la nostra “maniera” (occidentale) in ogni intercapedine di mondo civilizzato, riscontrando peraltro grande successo. Questo perché seppur positivamente contaminata con le urgenze espressive di luoghi distanti spazialmente, la cultura visiva occidentale è ben presente nell’apparato compositivo della produzione artistica globale.
 Mario Consiglio
Mario Consiglio
La Biennale di Venezia è un evento che trascende confini geografici e culturali, rappresentando uno dei nodi centrali del grande sistema dell’arte contemporanea. Non importa chi ne detenga la direzione, né il paese d’origine dei partecipanti: ciò che conta è l’appartenenza a una rete globale che alimenta il dialogo artistico e culturale. La Biennale, infatti, è molto più di una semplice esposizione; è un simbolo della necessità collettiva di far parte di un discorso artistico internazionale, di posizionarsi all’interno di un ecosistema che attribuisce valore non solo alle opere, ma anche alla loro capacità di risuonare oltre i limiti territoriali.
L’arte contemporanea, con la sua natura intrinsecamente globale, rende quasi irrilevante il luogo d’origine o le scelte curatoriali specifiche, poiché l’obiettivo principale rimane sempre lo stesso: entrare in relazione con il mondo, accedere a circuiti di visibilità e legittimazione. La Biennale diventa così il palcoscenico perfetto per esporre idee, concetti e identità che, pur radicati in contesti specifici, aspirano a dialogare con un pubblico universale.
In questo senso, partecipare alla Biennale è più di un traguardo: è un atto di affiliazione. È un modo per affermare la propria presenza in un sistema complesso e stratificato, dove l’arte non è solo espressione creativa, ma anche dinamica economica, politica e culturale. Il vero protagonista non è quindi il singolo organizzatore, l’artista o il paese d’origine, ma la volontà collettiva di riconoscersi e farsi riconoscere come parte integrante di una scena globale. Alla Biennale di Venezia, il locale si dissolve nell’universale, e il particolare diventa universale.

Manuela De Leonardis
La “revanche” degli orientali sull’orientalismo. Non è il titolo di un saggio. È quello che ho pensato qualche mese fa mentre camminavo per Bab al-Wazir street, nel distretto Darb al-Ahmar della Cairo Islamica, vedendo una caffetteria dove i locali fumano la shisha. All’interno, sul fondo di mattonelle bianche e azzurre, così come sull’intonaco scrostato delle pareti esterne, le riproduzioni fotografiche mostrano scene di genere tratte dal repertorio di pittori orientalisti ottocenteschi come Jean-Léon Gérôme, Narcisse Berchere, Henry Stanton Lynton, Edwin Lord Weeks, Alberto Pasini e Fabio Fabbi.
Interessante, a distanza di qualche generazione, questa riappropriazione da parte degli stessi soggetti di un immaginario dell’Oriente visto dagli occidentali che è tratto dal reale ma enfatizzato nell’accentuazione della componente esotica. In un certo senso è una dichiarazione d’appartenenza, di restituzione di un’identità. Come dire «mi riprendo ciò che mi appartiene». Una visione in più, non la sottrazione di qualcosa.