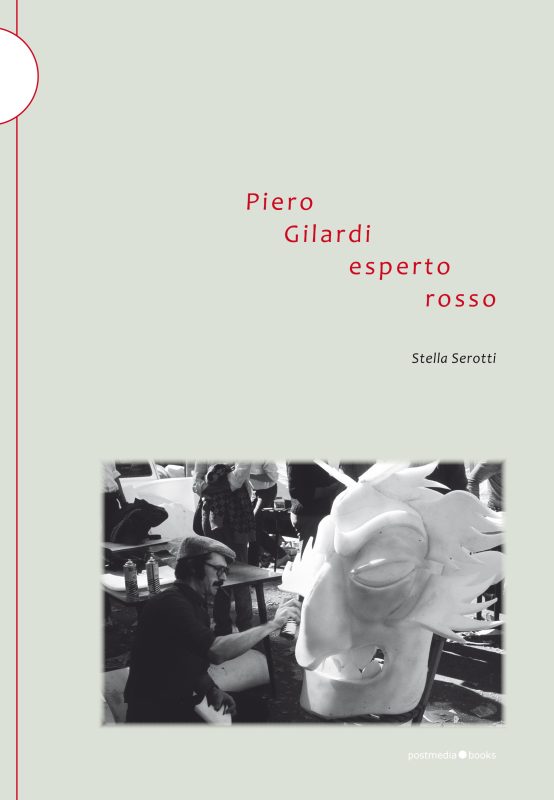
Piero Gilardi esperto rosso è il libro di Stella Serotti, edito da Postmedia Books nei primi giorni di quest’anno. Il testo ricostruisce tutta la vicenda artistica di Gilardi a partire dalla sua prima mostra “tecnologica” a Torino nel 1963, passando per i tappeti natura e l’Arte Povera, fino al distacco radicale nel Sessantotto, ai laboratori teatrali in contesti geografici remoti e proseguendo con gli interventi politici più recenti.
La quarta di copertina chiude la presentazione del volume scrivendo: «Forse le proposte di Piero Gilardi, e soprattutto l’atteggiamento con cui sono state attuate, possono essere d’ispirazione a chi si domanda come rendersi utile, coi propri strumenti, alle rivendicazioni attuali e ai processi di miglioramento delle condizioni di vita della collettività».
Ho questo libro sul tavolo da un paio di settimane, non l’ho ancora letto, perlomeno non del tutto. Ne ho lette molte pagine, ma in modo disordinato, aprendo a caso, saltando tra i capitoli, tra le immagini e, di fatto, facendo un grave torto all’autrice che, si capisce immediatamente, ha prodotto invece un lavoro organico e rigoroso ricostruendo una storia precisa, collocandola in una vasta cornice di fatti e idee. Però, a volte ci sono anche delle letture che si fanno così e non sono meno pregnanti, né meno illuminanti.

La vicenda artistica, umana e politica di Gilardi, come afferma Serotti nell’introduzione, oltre ad essere importante per se stessa, sul piano estetico quanto su quello storico, può illuminare anche molti punti del nostro presente, in modo particolare per quanto concerne un aspetto estremamente difficile da circoscrivere: il rapporto tra l’arte e il cosiddetto “attivismo”, cioè tutte quelle pratiche creative-poetiche che avrebbero la pretesa non solo di assumere una posizione estetica – e perciò etica – sulla realtà, ma di influire sulla realtà stessa, di produrre “anche” un cambiamento di qualche tipo: verità, giustizia, progresso, diritti – liberté, égalité, fraternité…
Ecco, ho sempre avuto problemi a rapportarmi con questo concetto dell’attivismo per come lo si intende nella scena dell’arte contemporanea che, come sappiamo, è composta di molti livelli (verrebbe da scrivere “millepiani” e chissà se D&G sarebbero contenti), con i piani alti in cui turbinano grandi idee e molti dollari e i piani bassi in cui serpeggiano grandi idee e basta. Attivismo è un termine che ho sempre trovato debole e anche opaco, richiama una qualche forma di “attività”, un’attività che una minoranza di ostinati esercita in opposizione, forse, alla “passività” che si presume sia il tratto dominante della nostra società.

Con questo libro tra le mani credo di capire meglio il nodo della questione e la differenza abissale tra il tipo di arte “attivista” praticata e possibile oggi e il lavoro titanico di Gilardi e di molti altri artisti della sua generazione. Il punto mi sembra semplice, e non si tratta di una semplice questione semantica, me ne sono reso conto solo oggi (ringrazio Serotti): Piero Gilardi non era un artista “attivista”, era un artista “comunista”. E quando si dice comunista si deve intendere proprio Comunista con tutti quegli arnesi annessi ormai in disuso: la bandiera rossa, il pugno chiuso, i proletari, la lotta di classe, i compagni, il Padrone, il Capitale e, laggiù in fondo, il Sol dell’Avvenire. E non solo Gilardi era comunista, erano comunisti tutti quelli intorno a lui – e quelli che non erano comunisti erano anti-comunisti, perciò antagonisti veri. C’era un orizzonte ideologico che era anche una prospettiva ideale, un progetto comune e condiviso con un lessico che dava voce a questo progetto e tutto questo creava le condizioni di una reale possibilità per l’arte di essere utile, e forse necessaria. L’arte era una componente non marginale della grande, comune e comunista, lotta ingaggiata per il conseguimento del bene comune. Oggi ci dicono che quel progetto è stato un fallimento, una specie di sogno ad occhi aperti sognato da milioni di persone, offuscato ogni tanto dai lacrimogeni lanciati dalla polizia in tenuta antisommossa schierata, come sempre, a difesa dei privilegi delle persone sbagliate, e sporcato dal sangue versato dai pochi che hanno scelto il modo più sbagliato per lottare. Così, quando si guardano nei musei le opere degli artisti che con Gilardi hanno compiuto quel tratto di strada – alzando, quando necessario, il loro pugno chiuso – cerchiamo di dimenticare lo scopo per il quale quelle opere sono state create (fare la rivoluzione comunista, nientemeno) come se in fondo l’ideologia che ha fornito loro da propellente non fosse che un aspetto marginale.

Ma non è questo l’argomento, perché questo libro, facendo la storia della straordinaria vicenda artistica di Gilardi che ha attraversato quel periodo così complesso con grande coerenza e coraggio, oltre che con poesia, ci mostra in fondo la debolezza dei modi dell’attivismo artistico odierno (dei “modi”, non delle ragioni): ogni gesto estetico, per quanto potente, per quanto sincero, necessario, per quanto “bello” e sentito e intimamente condivisibile, sembra mancante di una componente essenziale: un contesto politico, un lessico comune e condiviso e anche e soprattutto, un orizzonte che non sia solo ideale ma anche “ideologico”. Ed ecco la parola che non si può più pronunciare, che non siamo nemmeno più capaci di pensare. Questo forse perché pensiamo l’ideologia solo nei suoi esiti Novecenteschi – l’enciclopedia Treccani lo spiega così: «il termine ha tuttavia conservato un significato più specifico e ristretto, che viene utilizzato per indicare dottrine e movimenti politici precisi (comunismo, nazismo, fascismo), accomunati da alcune caratteristiche: la presenza di un retroterra teorico più o meno elaborato, che pretende di fornire una spiegazione esaustiva (e definitiva) dei processi storici e sociali; il tentativo di trasformare totalmente la società e l’uomo, secondo un preciso modello; l’intensa partecipazione emotiva dei militanti, spesso simile alla ‘fede religiosa’; il ruolo-guida di un partito dotato di una ferrea e capillare organizzazione». E così dimentichiamo che “l’ideologia” può essere anche altro, lo strumento per indicare un punto nell’orizzonte, per creare un lessico condiviso, per immaginare modi nuovi per stare assieme, per dare forma e direzione alle idee, per sperare.
Per quel che mi riguarda, credo che solamente negli ambienti del cosiddetto “ambientalismo militante” ci sia la possibilità di costruire un progetto che, oltre a essere sociale, estetico e umano, possa diventare ideologico (e quindi politico), nel senso pieno del termine, ma mi sembra che anche da quelle parti ci sia una sorta di reticenza a pronunciare questa parola perché evoca solo cattivi ricordi – e probabilmente mi sbaglio. Detto questo, non resta che leggere “bene”, in modo ordinato, diligente e rispettoso del grande lavoro che contiene, il libro bello e necessario di Stella Serotti, Piero Gilardi esperto rosso, perché “forse le proposte di Piero Gilardi, e soprattutto l’atteggiamento con cui sono state attuate, possono essere d’ispirazione a chi si domanda come rendersi utile, coi propri strumenti, alle rivendicazioni attuali e ai processi di miglioramento delle condizioni di vita della collettività”.




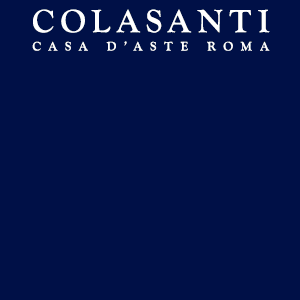


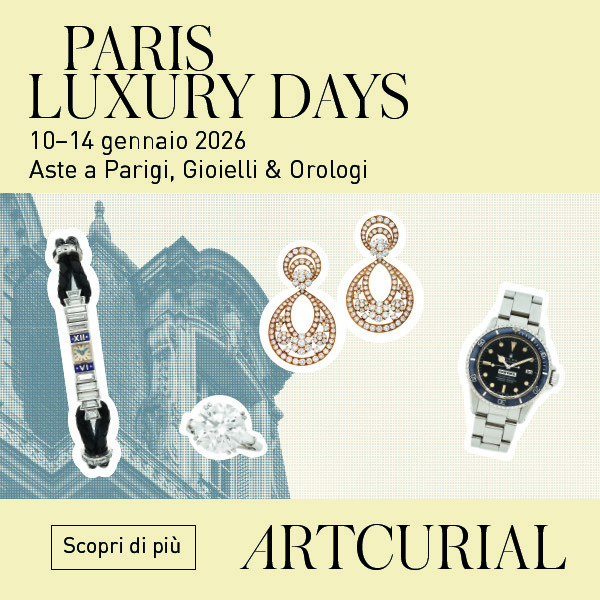
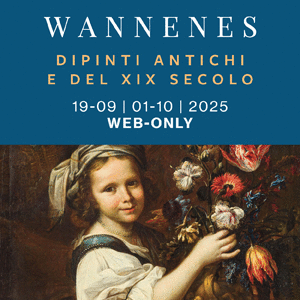

![Peter Halley, poi l’ultimo Novecento italiano: i risultati dell’asta di Meeting Art PETER HALLEY [New York 24/09/1953] Small Prison Dyptich, 2002](https://artslife.com/wp-content/uploads/2024/07/asta-956-lotto-100-1-576x288.jpg)




